È possibile preferire la fuga alla difesa dopo essere stati incolpati di un delitto non commesso, rischiando l’equivoco e il castigo in virtù di una totale estraneità ai fatti? Sì, se il protagonista nasce dalla penna di Guido Piovene, uno dei grandi dimenticati della letteratura italiana del secondo Novecento.
Guido Piovene, vicentino, iniziò come giornalista per Il Convegno di Ugo Ojetti, il nume tutelare di Indro Montanelli, per passare in seguito al Corriere della Sera sul quale si guadagnò l’amaro privilegio della pubblica vergogna che pagherà, a sue spese e con lucida ferocia, nel romanzo autobiografico La coda di paglia (Mondadori, 1962; Dalai, 2001), riguardo un vecchio antisemitismo di comodo, figlio di quell’italico costume, comunissimo e per questo democratico, spesso avvezzo al cicisbeismo intellettuale, ai cangianti propositi e alle facili carriere, costume che sulle spalle non certo larghe e meno perdonabili di Piovene, non gli impedì comunque dallo scontentare nei suoi articoli gli interessi di ambedue le sponde politiche, fino a essere allontanato da quest’ultime con sospetto e paura, essendone stato libero quanto scellerato frequentatore, pericolosa scatola nera di rapporti indicibili e verità inaccettabili, mai rivelate dallo scrittore, ma sempre scontrosamente sottese.
 Ed è in questo atteggiamento di tacita e aggressiva passività nei confronti dell’ambiguità della morale, che va intesa tutta la poetica dello smisurato talento di Piovene, talento più pesante della sua stessa storia, sin dal suo primo romanzo, Lettera di una novizia (Bompiani, 1941; 1994)), la storia di Rita, prossima alla monacazione, che di fronte ai dubbi riguardo la sua vocazione cerca di ricostruire la sua infanzia nelle lettere al priore, meraviglia di amarezza e prospettivismo, già rivelatrice dei tormenti dell’autore, fino al deflagrante capolavoro Viaggio in Italia (Mondadori, 1957; Bompiani, 2017)), il resoconto di tre anni di viaggio, regione per regione, attraverso il Paese, impresso in una nitida istantanea nella sua caotica ricostruzione, sospeso tra due realtà e mai veramente pacificato.
Ed è in questo atteggiamento di tacita e aggressiva passività nei confronti dell’ambiguità della morale, che va intesa tutta la poetica dello smisurato talento di Piovene, talento più pesante della sua stessa storia, sin dal suo primo romanzo, Lettera di una novizia (Bompiani, 1941; 1994)), la storia di Rita, prossima alla monacazione, che di fronte ai dubbi riguardo la sua vocazione cerca di ricostruire la sua infanzia nelle lettere al priore, meraviglia di amarezza e prospettivismo, già rivelatrice dei tormenti dell’autore, fino al deflagrante capolavoro Viaggio in Italia (Mondadori, 1957; Bompiani, 2017)), il resoconto di tre anni di viaggio, regione per regione, attraverso il Paese, impresso in una nitida istantanea nella sua caotica ricostruzione, sospeso tra due realtà e mai veramente pacificato.
Si sviluppano così i temi ricorrenti di Piovene, il ritorno al luogo natale concomitante alla perdita di sé, la sciatta luce che si agita dietro alle apparenti eroicità umane, l’indagine delle minute irreciprocità degli affetti, la sfida alle irreversibilità della vita, che immersi in uno stile cristallino, sobrio e modernissimo fanno di Piovene un unicum, o come sosterrebbero i più maliziosi, un intelligente manierato autoritratto.
Le stelle fredde, Premio Strega 1970, si possono carpire in un solo sguardo, recandosi nelle campagne vicentine, tra Recoaro Terme, dove si trova Villa Margherita, e Vicenza, presso la chiesa di Santa Corona che ospita il Battesimo di Cristo di Giovanni Bellini.
Villa Margherita è il luogo dell’infanzia di Piovene che ispira l’ambientazione del romanzo, villa di fine ottocento immersa in un ombroso verde tra il quale occhieggiano le arcate neorinascimentali color ocra che la stagliano in un fragile silenzio senza tempo, e che a oggi rischia di andare perduta per sempre.
 Il dipinto di Bellini, invece, su ammissione dello stesso scrittore, è invece l’archetipo fiabesco, l’ideale della narrazione, in cui storia geologica e umana insieme determinano il senso chiave, quello dell’appartenenza alla terra e ai suoi destini votata, all’interno di uno scenario composto da elementi concettuali e paesaggistici. Su tale rappresentazione il sentimento indagatore vela, lasciandone intravedere le seppur vaghe sembianze, una realtà enigmatica che non può essere rivelata, e che nel romanzo di Piovene ne è anima e tensione. È il quadro del libro, e il libro del quadro.
Il dipinto di Bellini, invece, su ammissione dello stesso scrittore, è invece l’archetipo fiabesco, l’ideale della narrazione, in cui storia geologica e umana insieme determinano il senso chiave, quello dell’appartenenza alla terra e ai suoi destini votata, all’interno di uno scenario composto da elementi concettuali e paesaggistici. Su tale rappresentazione il sentimento indagatore vela, lasciandone intravedere le seppur vaghe sembianze, una realtà enigmatica che non può essere rivelata, e che nel romanzo di Piovene ne è anima e tensione. È il quadro del libro, e il libro del quadro.
Qual è la trama? La trama è quella accennata in apertura. Non è una semplice fuga, quella del protagonista, che lo porta ad abbandonare la città, il lavoro di pubblicitario, e Ida, con la quale convive, ma è la crisi tra individuo e storia che in essa non trova altro che confuso rumore.
Rifugiatosi nella casa di campagna dovrà fare i conti con una serie di fantasmi, in primis il padre, che vive lì solo, poi con le minacce del precedente marito di Ida e il suo conseguente misterioso assassinio, la latitanza protetta e garantita da Sergio il poliziotto, e il fantastico incontro con Dostoevskij, miracolosamente ritornato per un breve lasso di tempo nel mondo dei vivi, a testimoniare, con sconcertante credibilità, cosa accade dopo, in un aldilà somigliante a una nebbiosa condizione mentale. Attraverso di loro tutto è capovolto, svuotato, ridotto, mortificato, anche attraverso un’amara ironia: il rapporto padre e figlio, l’amore, il pentimento, la scrittura, la grandezza umana, la religione, la morte, ma sempre con triste rispetto, tanto più frustrato quanto più disilluso, sentimento nel quale si può scorgere la definitiva sconfitta del realismo che in Piovene trova i varchi attraverso cui levare il suo canto del cigno.
L’uomo di Piovene è l’uomo che ha un rapporto conflittuale con la trasformazione, una conflittualità a suo modo eccezionale, figlia del desiderio di abbandono definitivo di ogni inganno della memoria, la quale si manifesta solo in relazione agli oggetti. Per via di questo rapporto il personaggio sceglie l’isolamento. E per via dell’assenza di questi, i mobili, il ciliegio divelto, scattano i meccanismi dell’indagine, mai veramente ricercata, ma vissuta con il magone di chi non può sottrarvisi.
Nessuno ha sondato la fastidiosa insensatezza di vivere con la stessa serenità, lo stesso coraggio, la stessa ferina franchezza liberatoria, mitigata, da una parte, dalla poesia dello stile, e dall’altra, dalla dignità con cui viene toccato il rapporto con il prossimo, il quale rappresenta sempre un timido quanto disinteressato appiglio.
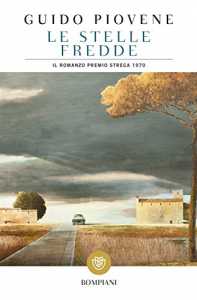 Nessuna metafisica è presente, è la vita a essere metafisica in sé. Il bene e il male appaiono come grottesche caricature, intenti fallaci di un’umanità che ha perduto il senso dell’inevitabile e del mistero, senza per questo motivo meritare poco credibili sferzate. In Piovene non c’è moralismo, né provocazione, ricordiamolo, ma solo il peso di un nichilismo che porta a una gelida e umanissima pietas.
Nessuna metafisica è presente, è la vita a essere metafisica in sé. Il bene e il male appaiono come grottesche caricature, intenti fallaci di un’umanità che ha perduto il senso dell’inevitabile e del mistero, senza per questo motivo meritare poco credibili sferzate. In Piovene non c’è moralismo, né provocazione, ricordiamolo, ma solo il peso di un nichilismo che porta a una gelida e umanissima pietas.
Sarà la morte del padre a rendere il personaggio finalmente un uomo, permettendogli quell’ultimo salto, lo sprofondare nella vita, non per l’accettazione di un ruolo, ovvero quello dell’individuo adulto, ma attraverso l’ultimo e definitivo slancio verso la nevrosi che diventa condizione perenne e immobile di chi ha cercato nella solitudine l’unica risposta plausibile.
Immerso nel suo studio, tra le carte che inizierà a compilare sempre più ossessivamente, il protagonista sarà sepolto nella grande casa che lo vedrà restituirsi alle ombre così come da esse era stato liberato. Passerà i giorni a scrivere. Scoprirà il suo senso, e quello del mondo insieme. Vedrà la realtà rimpicciolirsi, diventare segni, parole, cataloghi. E da qui il lampo rivelatore: l’unico senso del mondo è nel suo essere catalogato. Il mondo è questo gigantesco catalogo. C’è un fondo di verità in ogni cosa.



