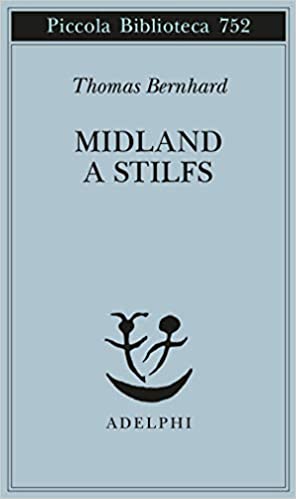La vertigine, derivante dalla montagna regina e sovrana e dalle architetture linguistiche elaborate da Bernhard, s’installa prepotente in questo trittico. Il lettore si accorgerà presto che, dalle vaste alture ai disperati colloqui di avvocati e fratelli, le fantasticherie della vita si ammucchiano con grandiosità quasi mitologica. Vertigine di prima classe se si è alle prese con l’Ortles e le infauste valli tirolesi. Il pericolo è a ogni passo, e la perdita di senso accompagna il gusto del ridicolo e della sfrontata e irrimediabile persistenza dell’ombra. Che segna e conferma le capacità attoriali dei protagonisti presentati dallo scrittore austriaco nel folto delle sue opere. Da Glenn Gould a, verrebbe da dire, sé stesso. I traduttori italiani, per la maggior parte traduttrici, fanno di tutto per accogliere (non senza difendersene ma vincendo, come in questo caso, la partita) gli avviluppamenti feroci, oltre che psichedelici, della prosa di Bernhard verso chi azzarda la soluzione di una frase riscritta dieci volte nella medesima pagina. L’intemperanza induce allucinazioni, così come l’inducono le alte vette intorno a Stilfs, dove il villeggiante inglese Midland attua contrasti con i pazzi del luogo, che in fondo sono soltanto i sani avvolti dalla loro “atmosfera artificiale”. Abitanti di una bolla che trattiene la debolezza universale fino a concludere che sì, in fondo la vita non ha più alcun senso. Né il “racconto”. E forse Midland, avendo attraversato il confine, sta dalla parte di Bernhard quando scrive che sparerebbe subito al più piccolo cenno di storia.
Le occasioni “sinistre” vanno avanti nei successivi due racconti dove vengono chiamate a raccolta le stranezze occasionali intorno a un mantello di loden e alle inquietudini di un acrobata e uno scienziato, fratelli di sangue e incapaci di controllare la propria arte. In questa breve trilogia “della solitudine”, apparsa per la prima volta nel 1971, Bernhard racconta di persone condannate all’estinzione, in luoghi misteriosi e oscuri per natura, non si sa da chi creati per influenzare animi allo sbando sebbene apparentemente “normali”. La ferocia delle varianti adesca il lettore a cui nulla è delegato, anche se l’arma critica è a portata di mano poiché Bernhard elargisce sempre il catalogo dei pericoli (in Estinzione o nell’Autobiografia, per esempio) a cui lui stesso è scampato negli anni precedenti. Scrivere con il martello o con l’ascia non è eccitante, ma in letteratura è forse l’unico “soffio di significato” (Manganelli) a cui bisogna esporsi. Ulisse si specchiava nelle proprie avventure, Midland si trova in un ambiente in cui i movimenti sono congelati, così come accade al cliente davanti all’avvocato del secondo racconto, e ai fratelli sull’Ortles. I discendenti di Ulisse dunque stanno oltre lo specchio. A migliaia circolano fra noi, non resta che stare a sentire chi riesce a narrarne le futili esistenze: Bernhard, Beckett e quel proiettile corrazzato che fu Burroughs. Il primo ambienta la meccanica mondiale che spinge gli umani a pasteggiare con bisogni sempre più matematici nella sua Europa centrale, l’Interzona in genere misconosciuta. Disumani gli abitanti delle montagne alpine, se confrontati agli uomini-serpente dello scrittore nordamericano. Può essere una suggestione, aspra e stravagante, ma basta addentrarsi nell’irreparabilità di questi oggetti narrativi perché il corpo della parola si avventi ai nostri cervelli senili. E ne smantelli gli ultimi brandelli di riscatto. È probabile che nessuna prosa come quella di Bernhard provi la definitiva pazzia del genere umano dentro l’habitat a cui nulla risparmia. Ma tutto travolge.