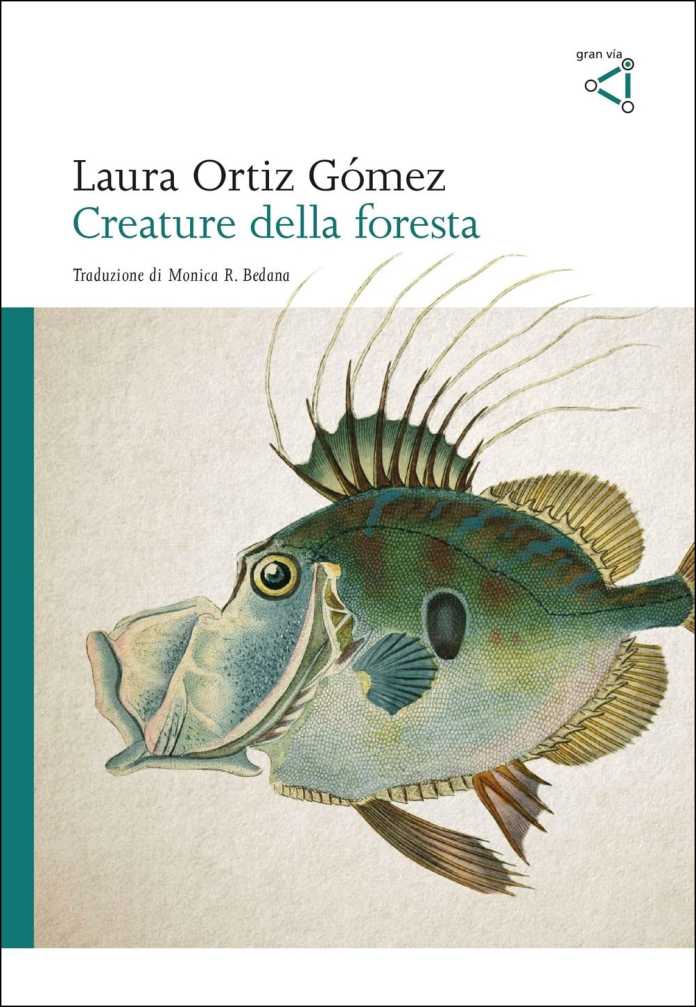Creature della foresta è il libro d’esordio della scrittrice colombiana Laura Ortiz Gómez che nel 2020 con questa pubblicazione vince nel suo Paese il Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica. Sono nove i racconti che ci vengono proposti e si palesa fin dal primo colpo d’occhio il tenore delle pagine dell’intera raccolta: Creature della foresta sembra voler essere il grido sovrumano di anime che hanno visto ogni orrore e provato ogni sofferenza. Con una scrittura graffiante, caustica e fantastica, le creature che Ortiz Gómez mette in scena sono uomini e donne, bambini e bambine che cercano di trasfigurare la loro quotidianità racchiudendo e inglobando in loro il mondo reale con quello immaginario, l’azione materiale con l’istinto di conservazione che può diventare consapevolezza interiore, benché essi non ne abbiano piena cognizione.
Ciascun racconto ha un peculiare protagonista che gronda dolore da ogni fibra del proprio corpo; ciascuno di essi è un essere umano straziato da una condizione da cui vorrebbe fuggire o che vorrebbe riuscire a spiegare: ma l’esistenza è oltremodo spiazzante e indicibile. Ed è proprio lì che, mentre ci si scontra con la sofferenza e si rischia di soccombere, lo sguardo dell’autrice diviene uno sguardo pragmatico verso la vita dei suoi personaggi, tanto da immergerli in un bagno di realtà, quasi a imporre loro di cambiare prospettiva dopo tanto dolore, per far sì che il cuore arrivi ad accettare il compromesso della quotidianità: “Adesso, che non te ne importa più nulla, hai ospitato in te un silenzio che è saggezza pura e dura. La saggezza di dormire, mangiare e cacare”, si dirà di uno dei protagonisti.
 Con trame molto diverse fra loro e ben inserite nel tessuto colombiano, le immagini che Ortiz Gómez ci propone spesso sono perturbanti e si animano in uno spazio senza frontiere, in una dimensione al limite dell’illusorio. Ci parla di guerra e di povertà, di sofferenza e di dolore umano che non risparmia nessuno, ci parla del fiume, degli animali, dei morti, e ancora di madri che non ci sono e di padri che non esistono. Ci sono immagini di sesso e immagini di dipartite. Ma, sopra ogni altra situazione e attività umana, appare ciò che rimane dopo la devastazione della lunga guerra, con l’avvento del paramilitarismo e del narcoterrorismo, in una realtà mal digerita e che si cerca di sputare lontano da sé per potersene liberare.
Con trame molto diverse fra loro e ben inserite nel tessuto colombiano, le immagini che Ortiz Gómez ci propone spesso sono perturbanti e si animano in uno spazio senza frontiere, in una dimensione al limite dell’illusorio. Ci parla di guerra e di povertà, di sofferenza e di dolore umano che non risparmia nessuno, ci parla del fiume, degli animali, dei morti, e ancora di madri che non ci sono e di padri che non esistono. Ci sono immagini di sesso e immagini di dipartite. Ma, sopra ogni altra situazione e attività umana, appare ciò che rimane dopo la devastazione della lunga guerra, con l’avvento del paramilitarismo e del narcoterrorismo, in una realtà mal digerita e che si cerca di sputare lontano da sé per potersene liberare.
Nulla sembra essere lasciato al caso in questa dimensione, crediamo di essere collocati in un ambiente certo ma poi improvvisamente tutto si trasforma, il ritmo della narrazione sovverte l’ordine delle cose e l’ordine del tempo: il lettore si ritrova inaspettatamente a vagare, talvolta a saltellare, in un fiume, su una montagna, in un cimitero. Attirato dentro la pagina, risucchiato e fatto rimbalzare, obbligandolo a prendere le distanze per riuscire a respirare con giusto ritmo. Il dolore dei protagonisti sembra sottendere ogni valore, ma sulla loro desolazione l’autrice non ci concede di piangere perché ha nuovamente sconquassato la scena e fatta intuire una possibile via di fuga, forse una possibile sopravvivenza. Grazie alla lucidità e alla caparbietà con cui in questi racconti ci viene mostrata la vita degli abitanti in questi piccoli paesi rurali della Colombia, poveri e devastati, la scrittrice fotografa immagini che restano a lungo scolpite nella memoria, azione e dettagli diventano universali, una filosofia di esistenze in grado di vivere nonostante tutto. Scrive Ortiz Gómez: “Pur sospinto dalla lingua della madre, il vitello a un certo punto rimane immobile, si ferma, e fermarsi significa già essere soli. In questa scena è come se tutto durasse quindici anni, oppure all’infinito. È una cosa così vecchia venire al mondo. Così vecchia e così brutale”. Come se il tempo e la disperazione non si misurassero più, mentre l’umanità tutta implora salvezza.