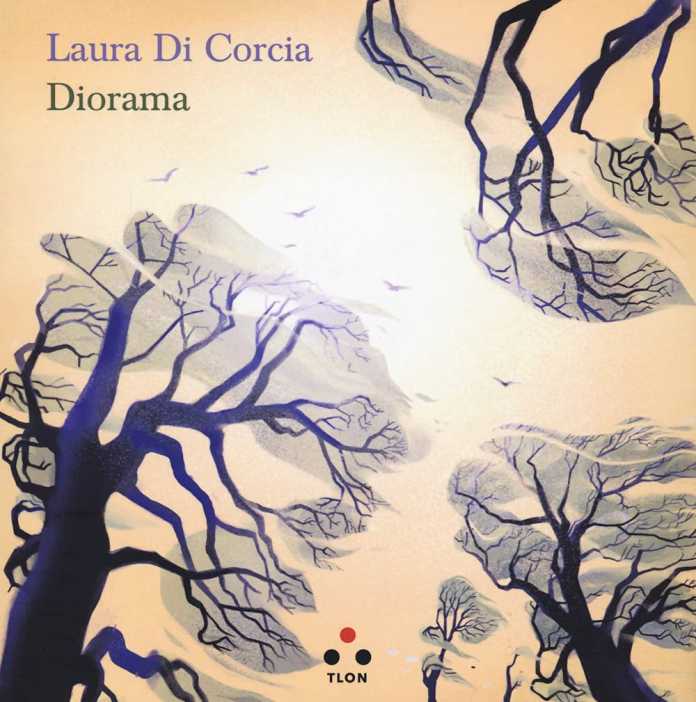Già dedicata alla traduzione di autori e autrici, come a esempio Anne Carson e Ben Lerner, la collana di poesia di Tlon intitolata al Controcielo di René Daumal – altro libro apparso nella breve, ma già prestigiosa, storia di questa iniziativa editoriale – accoglie per la prima volta, per quanto ancora segnato da una chiara extra-territorialità, il volume di un’autrice in lingua italiana. Laura Di Corcia, infatti, è poeta di origini italiane, ma risiede da molto tempo nel Canton Ticino e – per stare alle definizioni territoriali (che hanno un valore euristico probabilmente limitato, ma l’hanno) – è una delle voci più importanti della poesia svizzera contemporanea. Filippo Tuena lo scrive in maniera decisamente migliore nell’introduzione, più sintetica e al tempo stesso meno legata a quella che può essere, invece, una mia tendenza al sociologismo d’accatto: “La ferita di Laura di Corcia, se fanno fede i suoi testi, parrebbe essere quella dell’altrove: quella di trovarsi, in maniera stanziale, lontana da un dove da cui proviene e che le riappare a volte in maniera imprevedibile”.
La manifestazione della ferita, del resto, è consustanziale all’immagine-cardine del libro, ossia alla scrittura poetica come costruzione, e insieme decostruzione, di un diorama, spingendo, parallelamente, verso l’indagine di quel che resta fuori dalla cornice dell’immagine (oppure di là dal vetro, come si legge a circa metà del libro, nella prosa in apparenza garbata, e in realtà tragica, intitolata, appunto, Piccioni e vetro), e quindi di ciò che sta sul margine, sempre periglioso, tra “visibile” e “invisibile”. Detto questo, poi, alla levità del “parola”, nel libro, si contrappone spesso la forza d’urto del “sasso” – oggetto contundente che, tuttavia, può lasciare delle stimmate anche nella mano che lo raccoglie.
Basterebbero queste poche righe, forse, per insistere sull’importanza e il valore del volume. Tuttavia, l’opera – terzo libro di poesia di Laura Di Corcia, dopo Epica dello spreco (Dot.com, 2015) e In tutte le direzioni (Lietocolle/Pordenonelegge, 2018) – presenta altri spunti di riflessione, che necessitano di essere analizzati un po’ più a fondo, poiché restano aperti anche dopo la lettura del volume nel suo insieme. Così aperti, anzi, che, nella produzione dell’autrice, Diorama si configura forse più come un libro di transizione che non come un’acquisizione perfettamente autonoma e a sé stante (e questo, per chi scrive, è sicuramente un merito).
La possibile transizione è testimoniata, innanzitutto, dalla ricca varietà delle tre sezioni e dei testi che ne esorbitano, nonché dai loro possibili sviluppi. Tale ricchezza tematica si trova poi adeguatamente supportata dal polimorfismo metrico (a tratti vicino a un’idea di poesia popolare, a tratti splendidamente spericolato nell’adozione della più erudita prosa poetica), senza per questo venir meno alla costruzione di una trama molteplice. Tra i fili più evidenti di questa intessitura – da intendersi più come intreccio tematico e formale che non come struttura narrativa – vi è sicuramente il titolo della seconda sezione (La catastrofe è già passata) e da qui conviene partire.
Oltre a rielaborare un principio-cardine della psicologia winnicottiana – riassumibile, a grandi linee, così: “nel momento in cui nel soggetto si verifica la paura del crollo, il crollo è già avvenuto” – La catastrofe è già passata ritorna, come eco, in tutta la sezione così intitolata, e anche oltre. Molto chiaro è il rimando che si legge ne I giorni della catastrofe, la prima poesia della quarta sezione – dedicata al “Terzo paesaggio”, riferimento al termine coniato da Gilles Clément nell’omonimo Manifesto (2004) – sul quale tanta poesia italiana contemporanea si arrovella già da tempo (lo testimoniano i dibattiti reperibili sul sito Le Parole e Le Cose o sulla rivista Versodove). Rifuggendo l’identificazione diretta con le vittime della pandemia da Covid-19 (tentata, invece, da un altro autore italo-svizzero come Fabio Pusterla in Requiem per una casa di riposo lombarda, per Marcos y Marcos), Di Corcia ci indica che il ciclo delle catastrofi è ben più ampio di quello che sembra esserci ultimamente toccato in sorte. E se la chiusura di I giorni della catastrofe recita: “Andiamo via da qui? Sì, ma torniamoci sempre”, illuminando quelle che sono le dinamiche costitutive del trauma (a proposito, “Tutti sono nudi, nessuno è salvo” recita una delle due epigrafi della poetessa angloamericana Marianne Moore, che Di Corcia ha il merito di riportare all’attenzione), altri testi tematizzano la dimensione del trauma e della catastrofe in modo molto più esplicito.
Da Salem, 1692 a Kobane 2019, passando per Keiko Ogura – nome di una superstite della bomba atomica sganciata dall’esercito statunitense su Hiroshima – si è posti di fronte non soltanto a una storia così dolorosa da non meritarsi nemmeno la definizione e la possibile astrazione connessa alla Storia, ma ci si confronta più chiaramente con la “legge dell’atomica, della vita”. Nella stessa poesia – la cui esplosione, dal punto di vista tematico e formale, amplifica la dimensione retorica di un possibile riferimento alla tradizione poetica: E il nome di Maria Fresu (1986) di Andrea Zanzotto – si legge in fondo come sia “la vita che per definirsi distrugge altra vita”.
Il male assurge a forza quasi ontologica, secondo una tensione trans-storica: più su ancora, tornando all’iniziale sezione che dà il titolo al libro, Diorama, si può leggere che “è pazzo, pazzo, pazzo / chi crede che l’ontologia / sia solo scienza dell’essere”. Nell’apparente sentenziosità che si può intravvedere in questa come in altre possibili citazioni (numericamente esigue, comunque), la costruzione stessa di Diorama continua, in realtà, a invocare una storia, per quanto diversa dalle strutture convenzionali della storia con la “S” maiuscola. Anche in questo caso, è una dimensione che va continuamente ricercata fuori cornice; esemplare, a riguardo, è la chiusa del primo testo della seconda sezione, dove a guadagnare una visibilità altrimenti negata dalla storia/Storia sono le classi subalterne: “I contadini rimangono a lato / la storia continua e li sfiora / loro pregano in ginocchio / sul ruvido / di fronte alla passiflora”.
Allo stesso modo, una delle maschere dell’io lirico che si presenta più spesso è quella della “guerriera silenziosa”, impegnata in una guerra che può essere privata, ma che ha sicure rispondenze nel contesto che ci troviamo a vivere. È così che la terza sezione viene a intitolarsi Trincea, significando simultaneamente questa condizione esistenziale di belligeranza, ma anche la separazione del soggetto dagli oggetti, o dai soggetti, che restano fuori dalla cornice, dalla linea tracciata, dal vetro. D’altra parte, non è un caso che il testo immediatamente successivo a quello della prima apparizione della “guerriera silenziosa” presenti, con notevole understatement, una scena da Lugano, scuola professionale, radicando più a fondo il conflitto in una dimensione esistenziale probabilmente autobiografica e al tempo stesso dissimulando ancora un po’ l’impatto della storia/Storia sulla scrittura poetica.
Forse è un impatto che non è stimato in tutto e per tutto come tale, ma – come Di Corcia ha il merito di indicare, in uno dei suoi pochi ma assai rilevanti affondi verso la repubblica delle lettere – questa è una debolezza che, in realtà, pertiene a tutti coloro i quali vanno ripetendosi, perpetuando ad libitum il meccanismo dell’autoreferenzialità, che “il problema è che questo ragionamento / lo fanno / sempre gli stessi”. Il libro di Di Corcia, invece, ci spinge a guardare nel diorama di questo ragionamento e in questa visione del mondo, con il suo inevitabile portato più ideologico che poetico, allo scopo non troppo sottaciuto di aprire una transizione verso qualcos’altro, forse ancora più prezioso, dentro e fuori la poesia italiana contemporanea.