Un missionario del XIX secolo racconta che nel regno di Cakaudrove (Isole Fiji) ogni giorno all’alba i sudditi assistevano nel più assoluto silenzio al rito della masticazione reale. Mentre il re schiacciava tra i denti la sua radice di kavakava tutti lo incoraggiavano urlando: “Mastica!” ma, al termine del rito, esplodevano poi in una sonora risata. L’aneddoto, preso dalla massa pantagruelica di dati che David Graeber e David Wengrow rovesciano sul lettore nelle oltre settecento pagine di Dawn of everything (L’alba del tutto, RIzzoli, 2022), non è certo il più sorprendente nè il più significativo di un libro concepito per ribaltare molti luoghi comuni sull’avventura degli umani nel pensiero storico corrente. E, tuttavia, può fornire indirettamente, un sunto non disprezzabile di un testo teorico monumentale, costruito in dieci anni di corrispondenza tra i due autori, che vede ora la luce, a due anni dalla scomparsa di Graeber.
Quello di Cakaudrove resta infatti un rituale incomprensibile a partire dalle categorie che assimiliamo sui banchi di scuola, dove i “regni” sono più o meno come quello di Luigi XIV e nessun re si farebbe mai prendere per il culo ogni mattina dai suoi sudditi. Secondo i due David questo perché siamo stati educati a inquadrare ogni momento della storia e della preistoria solo retrospettivamente, in chiave di match (civiltà, faccina allegra) o di scostamento (decadenza, faccina triste), rispetto al modello del suo presunto decorso teleologico. Per quanto non smettiamo infatti di stigmatizzare l’universalismo “illuminista”, occidentale, etc nei discorsi di tutti i giorni, non riusciamo poi a fare a meno di rappresentarci la parabola umana nel suo complesso se non censurando le sue molteplici diramazioni e sperimentazioni collettive, assumendo, insomma, il punto di vista storico delle nostre attuali società e, in ultima analisi, dello Stato moderno.
Il mito della nostra evoluzione storica come sapiens resisterebbe nel senso comune a qualsiasi confutazione scientifica, perché è l’ultima vera Grande Narrazione, e tiene a bada oggi la prospettiva di qualsiasi cambiamento “radicale”. La scena del film che ci siamo fatti si apre al termine dell’ultima glaciazione, dopo centinaia di migliaia di anni di non storia, rotta solo dai richiami dei cacciatori-raccoglitori, e comincia con la prima startup: l’invenzione dell’agricoltura. Di lì in poi la storia decolla con le prime città del Neolitico, in Mesopotamia, raggiunge il suo climax con i regni e gli imperi – Assiri, Romani, Aztechi, Inca, Maya (arruolati benchè “misteriosi”..), e – dopo un flashback tra le dinastie cinesi e uno stacco sul Sacro Romano Impero – approdiamo finalmente agli Stati Nazione. Secondo gli autori – un antropologo e un archeologo, entrambi affermati intellettuali anarchici – questa “favola” esprime un preciso e ben radicato bias congnitivo che, ancorché screditato presso qualsiasi antropologo o archeologo “serio”, ritroviamo ogni volta che apriamo un libro di divulgatori alla moda come Jared Diamond, Steven Pinker, Yuval Noah Harari.
Per venirne a capo occorre rovesciare il nostro punto di vista:
Per dare un senso agli esordi dell’agricoltura neolitica, dobbiamo provare a vederla dalla prospettiva del Paleolitico, non del presente e, ancora meno, dal punto di vista di un’immaginaria razza di uomini-scimmia borghesi. Certo è più difficile ma l’alternativa è ricadere nella dimensione della mitopoiesi: riraccontare il passato come una storia del tipo “così e basta” che fa sembrare la situazione attuale in qualche modo irreversibile e preordinata. (pag.249).
Va detto che per capovolgere questa narrazione il percorso seguito dagli autori applica a suo volta, più o meno programmaticamente, quella che in alcuni casi si deve riconoscere come una forma di narrazione selettiva, ridimensionando in particolare l’influenza dei fattori linguistici, ambientali, climatici, etc a vantaggio di una visione prevalentemente “volontaristica”, volta a privilegiare l’autodeterminazione delle comunità nella vicenda storica e antropologica. È, in altre parole, un libro a tesi, con un obiettivo politico dichiarato e un irresistibile fascino intellettuale, che nasce in primo luogo dalla viva intelligenza di Graeber e dal supporto di un’ampia ricerca compilativa. Come pochi altri libri (forse “L’economia dell’età della pietra” di Marshall David Sahlins negli anni ‘60 , a cui si rende omaggio nelle prime pagine) sa di sradicare pregiudizi comuni con una ricaduta istantanea sulla nostra (asfittica) immaginazione politica, e per ciò stesso sembra destinato a suscitare un’ampia eco anche o soprattutto tra militanti e intellettuali di strada.
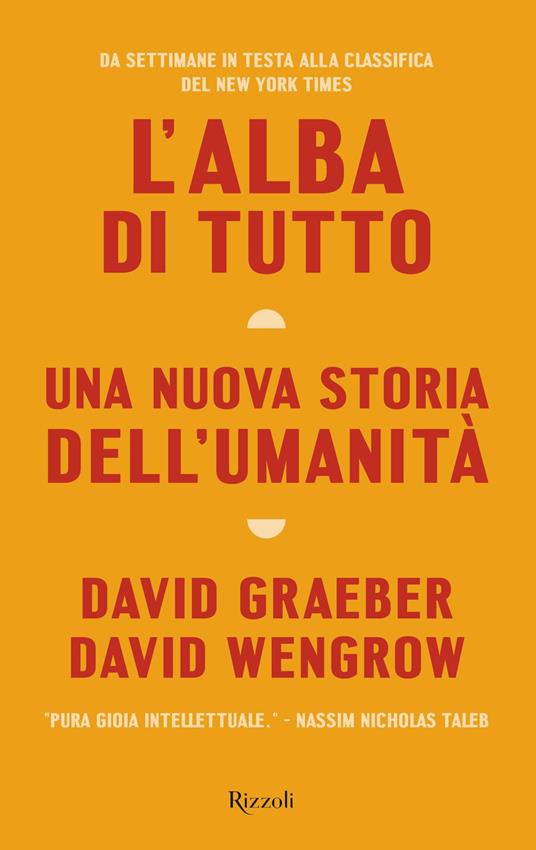
Così L’alba di tutto sceglie di afferrare subito il toro per le corna. E il toro filosofico non è qui tanto rappresentato dal Leviatano di Hobbes quanto dal suo apparente “opposto” speculativo: il “mito del buon selvaggio”, germogliato in seno al pensiero del ‘700 e codificato da Jean Jacques Rousseau. Al nucleo del filosofo ginevrino, che per la verità nel Discorso sull’origine e i fondamenti della diseguaglianza tra gli uomini fa parlare un selvaggio dichiaratamente immaginario, viene fatta risalire la mitopoiesi di un fantomatico “stato di natura”, un Eden dove gli umani potevano vivere in armonia, tra uguali, prima della caduta nella società degli impari e della diseguaglianza, insorta con la proprietà, cioè poi nella “storia” che conosciamo non meno dei contemporanei di Rousseau. Il mito, tuttora avvolto da un’aura benevola e progressista nel senso comune, avrebbe invece offerto all’Illuminismo, e in particolare a economisti come Turgot e Smith, la piattaforma teorica per descrive il cammino “storico” della civiltà occidentale come una specie di sviluppo per fasi, con un’unica direzione di marcia. Se la proprietà ci ha fatto scendere dalle liane, insomma, non resta che andare avanti. TINA (There Is Not Alternative) in pratica nascerebbe così, assieme al “mito del mito del buon selvaggio”.
L’illuminismo, con il suo corollario di tolleranza, di uguaglianza e di riforme sociali, in realtà non nasce nella testa di alcuni intellettuali bianchi particolarmente brillanti. O, meglio, vi nasce sì, ma solo dall’incontro con filosofi di un tipo completamente diverso, di cui nessuno fino a quel momento aveva immaginato l’esistenza. A fronte del buon selvaggio letterario e chimerico il processo di colonizzazione del XVI e del XVII secolo aveva infatti messo gli europei davanti a società basate su ontologie e filosofie politiche totalmente inedite per le loro orecchie e i loro cervelli. Ai primi del Settecento i voluminosi resoconti e i libri di viaggio di missionari ed esploratori dal nuovo continente, che riportavano i dialoghi e le conversazioni con questi nuovi filosofi americani, erano una lettera estremamente popolare presso qualsiasi famiglia mediamente colta di Parigi o di Londra. Diversi di loro erano arrivati anche in carne ed ossa al di qua dell’oceano.

Per riportarli al centro della vicenda che indirettamente darà vita all’Illuminismo, Graeber e Wengrow ricostruiscono il pensiero di uno di loro, Kandiaronk (“Topo muschiato”), appartenente al popolo Wendat (“Uroni”), filosofo americano approdato in Europa nel ‘600. Delle società europee ricavò un’impressione particolarmente negativa ma, contrariamente a quello che un fan rousseauiano avrebbe poi immaginato, non descrisse questa impressione nei termini di “diseguaglianza” ma di assenza di libertà e di solidarietà. Kandiaronk era stupito che gli europei avessero rinunciato alle tre libertà che lui considerava irrinunciabili: la libertà di muoversi e spostarsi in altre collettività; la libertà di non ubbidire agli ordini sgraditi; e quella di dare vita a nuove relazioni sociali. E si stupiva ancora di più che in Europa la gente, invece di adottare le misure collettive necessarie per realizzarle, fosse propensa a vivere in un mondo dove ognuno pensava a se stesso inseguendo cose futili. Le dottrine americane che fanno colpo sugli Illuministi non hanno, quindi, nulla a che vedere con un presunto “stato di natura” ma si basano su tre pilastri quali libertà individuale, assistenza reciproca e uguaglianza politica.
Per i due ricercatori, il pensiero illuminista nasce dal confronto – asimmetrico nelle modalità, paritetico nei contenuti – tra diverse culture e da un momento di apertura che il pensiero occidentale si affretterà a rielaborare a modo suo, come narrazione universale e evoluzionismo sociale, di pari passo con il processo di colonizzazione e di civilizzazione bianca. Lo stato moderno, dopotutto, era nato per negare le tre libertà indicate da Kandiaronk, e non per difenderle. Alcune idee rimangono, come un fossile ideologico, altre mutano di segno. L’idea di “’eguaglianza”, ad esempio, volta a volta intesa come economica, di opportunità, di rischio etc, rimane ancora oggi un concetto sospeso e indefinibile, in ultima analisi un ossimoro nella filosofia politica liberale e riformista.
Per uscire da questa trappola concettuale, il primo passo è smitizzare la cesura ideologica rappresentata dal Neolitico e, in particolare, dall’introduzione dell’agricoltura.
La versione di Harari è affascinante, riteniamo, non perché si basi sulle prove ma perché l’abbiamo sentita mille volte con un diverso cast di personaggi […] Torniamo nel giardino dell’Eden, solo che a indurre l’umanità ad assaggiare il frutto della conoscenza non è più un serpente scaltro, bensì il frutto stesso (cereali)”.
L’alba di tutto ripercorre da un capo all’altro del pianeta – dalla California all’Eufrate, dalla Cina alla Mesoamerica – il cammino dell’umanità come un’interminabile passeggiata sperimentale e non come marcia trionfale, un’avanti e indietro a zig zag, dove la molteplicità e la reversibilità delle opzioni antropologiche emerge gradualmente dalle tracce del passato preistorico.
Le scoperte archeologiche degli ultimi 30 anni non offrono da questo punto di vista certezze assolute ma sicuramente molti solidi indizi. I siti come quelli di Poverty Point (Louisiana) o di Nebelivka (Ucraina) comprovano oggi l’esistenza di grandi comunità preistoriche, e non solo di piccoli gruppi di cacciatori-raccoglitori. Per diversi millenni le comunità sembrano privilegiare negli stili di vita e nelle culture l’alternanza dei cicli stagionali, con stagioni dedicate alla caccia e altre alle attività sedentarie, senza apparentemente aderire alla rigida dicotomia che opporrebbe popolazioni nomadi e stanziali.

L’agricoltura stessa è presente in diversi insediamenti neolitici come attività secondaria, forse addirittura ludica, o non risulterebbe presente affatto, come a Çatalhöyük (7000 a.c.), né sembra coincide necessariamente con la centralizzazione dei poteri, nemmeno nella mezzaluna mesopotamica. Il suo impatto sugli assetti organizzativi e sugli equilibri di genere è complesso, frastagliato, varia negli orientamenti che emergono dai ritrovamenti e non consente oggi generalizzazioni frettolose. A fronte delle fantasie vittoriane di un Paleolitico edenico e tutto matriarcale, civiltà neolitiche come quella minoica sembrano invece effettivamente attestare la preminenza e la centralità della figura femminile nella politica, nella vita sociale e in forme artistiche dove “non ci sono eroi”. La Creta dei Palazzi era il mondo della Femina Ludens o, forse, della Femina Potents? Ovviamente non possiamo dirlo con certezza ma quello che l’archeologia dimostrerebbe oggi è la varietà e reversibilità delle strategie umane. Qualcuno, infatti, dopo aver innestato il turbo dell’agricoltura ha dovuto o voluto fare retromarcia, soprattutto nel “nuovo” continente. Come si osserva in riferimento ai ritrovamenti di Cahokia (Mississippi)
Il caso del Nordamerica non solo scompagina gli schemi evoluzionisti convenzionali, ma dimostra anche chiaramente quanto sia sbagliato che se si cade nella trappola della “formazione statale” non c’è via di uscita. (pag. 509)
Nel capitolo intitolato “Lo stato non ha origine”, Graeber e Wengrow mettono in chiaro che lo stato è solo un precipitato della modernità, un battito di ciglia in capo a centinaia di migliaia di anni, e che improntare la narrazione umana all’indagine delle sue origini devia dai rilievi e dalle finalità della ricerca storico scientifica. I tre vettori che ne dovrebbero segnale l’insorgenza – sovranità (monopolio della violenza), amministrazione (organizzazione della conoscenza) e carisma (controllo del consenso) – figurano infatti sparpagliati sugli assi spazio temporali della nostra specie e compaiono con morfologie spesso totalmente difformi anche sul crinale del Neolitico. E altro non rappresenterebbero se non l’opposto della filosofia sociale di Kandiaronk e del suo ampio ma ragionevole programma.



