“Morire, come vorresti? Fare ponte al passaggio. / Non corteo d’elezione, non pietoso trapasso; / né contesa né approccio aver rinviato / mancanza supplita con spurio coraggio”.
Il presagio di Alfredo Giuliani (Mombaroccio 1924 – Roma 2007) dichiaratamente espresso in questi versi della poesia La cara contraddizione (1955) fu quello di dover giungere ai posteri con la modestia e la sobrietà caratteristici del critico letterario, del curatore, del traduttore. Quindi di essere incarnato totalmente in un profilo esterno all’arte letteraria tout court, relegato dietro le quinte di un movimento culturale del quale, al contrario, Giuliani fece pienamente parte.
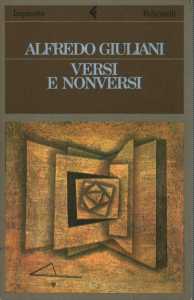 Laureatosi nel 1949 con una coraggiosa tesi sull’allora misconosciuto filosofo ebreo goriziano Carlo Michaelstaedter – oggetto di studi innumerevoli e fenomeno di culto ai giorni nostri – Giuliani seppe cogliere fin dagli anni Cinquanta i germogli di quella che sarebbe divenuta la più corrosiva avanguardia letteraria italiana degli anni Sessanta: il celebre “Gruppo 63”.
Laureatosi nel 1949 con una coraggiosa tesi sull’allora misconosciuto filosofo ebreo goriziano Carlo Michaelstaedter – oggetto di studi innumerevoli e fenomeno di culto ai giorni nostri – Giuliani seppe cogliere fin dagli anni Cinquanta i germogli di quella che sarebbe divenuta la più corrosiva avanguardia letteraria italiana degli anni Sessanta: il celebre “Gruppo 63”.
E se di fronte a nomi del calibro di Umberto Eco, Luciano Anceschi o Edoardo Sanguineti, il suo viene ancor oggi citato tra i comprimari, non dobbiamo dimenticare che fu proprio Giuliani a curare e introdurre, con un meraviglioso saggio, l’antologia che battezzò la leva poetica del Gruppo: I Novissimi (Einaudi, 1961), divenuta negli anni pietra miliare della poesia contemporanea – e delle risicate ultimissime pagine dei testi scolastici di quinta superiore.
Croce e delizia di questa paternità critica, nonché del legame con la neoavanguardia, fu la completa sottovalutazione delle raccolte poetiche, in prosa e pseudoteatrali che Alfredo Giuliani produsse nell’arco di un trentennio. Una produzione che questa raccolta omnia, oggi irreperibile, intendeva – prima ancora che omaggiare – riproporre al pubblico in tempi di riflusso e riallineamento della letteratura nazionale nel pieno degli anni Ottanta.
Dopo l’uscita di questa antologia, Giuliani si dedicò quasi esclusivamente alla collaborazione con le rubriche culturali di svariati quotidiani (tra gli altri Repubblica e Il Corriere della Sera), tralasciando consapevolmente l’attività poetica, nella quale fece capolino – con lo stile scherzoso, dadaista e funambolico che gli era proprio – solo negli anniversari di quel “63” cui era rimasto legato.
Nel 1993, infatti, pubblicò Ebbrezza di placamenti (Manni Editore) e poi nel 2003 Poetrix Bazar (Edizioni Pironti).
Il corpus cronologico delle opere di Alfredo Giuliani raccolto in Versi e non versi ci rivela anzitutto l’estrema eterogeneità della sua ispirazione, costantemente influenzata dagli autori stranieri da lui tradotti e dei quali amava fiutare le tracce.
Dai Frammenti di un’autobiografia (1950) vediamo per esempio emergere prepotente la figura di Thomas Stearns Eliot, sapientemente contornata di rimandi iconici alla prosa di Francis Scott Fitzgerald. Laddove invece nella raccolta Il cuore zoppo (Magenta edizioni, 1955) è un’altra icona della letteratura anglosassone a dominare lo stile, Dylan Thomas.
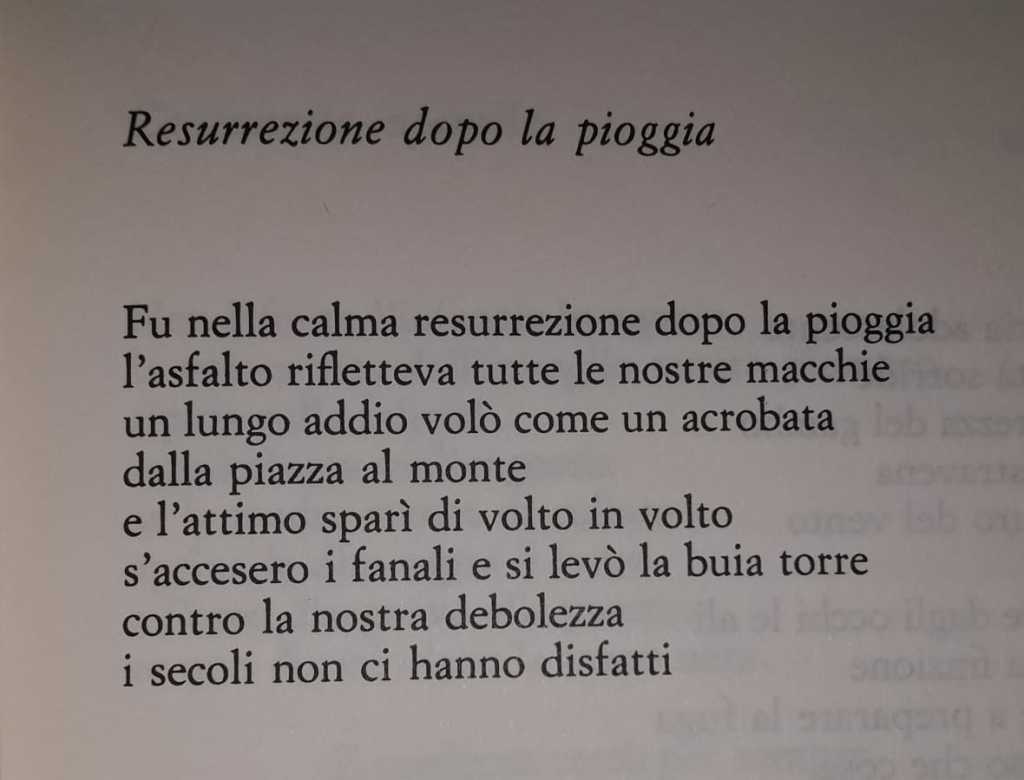
L’acquisizione di una più solida maturità e autonomia giunge nel 1965 con la raccolta Povera Juliet ed altre poesie (Feltrinelli), che diverrà la sua silloge più famosa.
Qui, infatti, Giuliani riesce a passare da uno stile molto vicino all’ermetismo, arricchito con un latente lessico leopardiano, a prove davvero straordinarie di poemetti in quartine (“La cara contraddizione”, già citata, “In debito di una morte famigliare”, “Il vecchio” e “Predilezioni”, forse la sua composizione più famosa in assoluto). In tali poemetti Giuliani forgia quel ritmo stilistico e quell’eclettismo ironico che lo rendono ancor oggi quasi un unicum nel panorama della poesia italiana degli ultimi cinquant’anni.
È in particolare il suo uso sistematico e magistrale del correlativo oggettivo di ascendenza eliotiana a caratterizzarne l’intensità poetica. L’accostamento di immagini dolcemente stridenti o paradossali, tese a definire una nuova grammatica delle sensazioni in epoca di incipiente rivoluzione dei valori e delle affinità, non appare mai gratuito, ma sempre calibrato su quell’eccesso di significato che la poesia deve fare proprio.
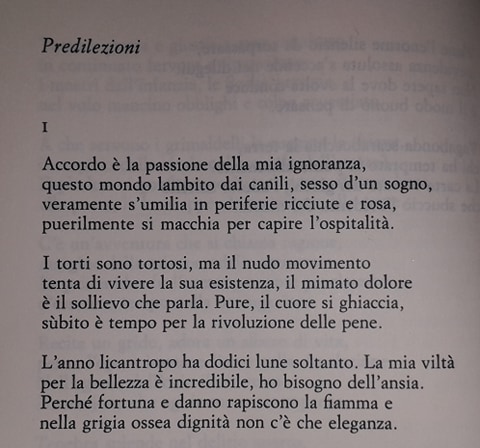
Per questa ragione, Giuliani è una delle pochissime figure della neoavanguardia a non trattare o citare esplicitamente argomenti politico-economici nelle sue composizioni – a differenza dei colleghi e amici Elio Pagliarani e Nanni Ballestrini.
Il suo sguardo si mantiene sempre all’interno dello “sperimentalismo” culturale e in particolare musicale. Sono infatti i nomi di Franco Evangelisti, Alvin Lucier e dei giganti Luciano Berio e Luigi Nono quelli che troviamo costantemente citati nelle dediche o accennati all’interno delle sue creazioni. Questo nell’assoluta convinzione che quanto stava avvenendo in termini di coscienza sonora grazie alle nuove ricerche e alle tecnologie degli anni Sessanta, avrebbe tracciato un orizzonte ben più ampio di quello concettuale (o peggio etico) che ancora si voleva attribuire alla poesia, come arte didascalica o morale.
In nome di questa nuova frontiera dettata dagli alchimisti delle frequenze, Giuliani pubblica Il tautofono (Scheiwiller edizioni, 1969) che segna la rottura definitiva con ogni reminiscenza canonica della poesia. Il metro libero, l’assenza della sillabazione e della punteggiatura minima, il vorticoso alternarsi di voci e frammenti diversi porta la poetica di Giuliani verso il cut up di stampo dadaista da un lato e verso la patafisica di Alfred Jarry – autore da lui amatissimo – dall’altra.
Negli anni della contestazione più profonda, Giuliani sente l’esigenza di connettere in media res la dimensione intima del soggetto con quella universale della sua azione, ma scongiurando costantemente ogni deriva eroica o prometeica: è l’ironia a salvarci davvero, la letteratura non ufficiale, l’oralità, il “sacro volgare” che Dario Fo stava portando sulle scene in quegli stessi anni col suo immortale Mistero Buffo.
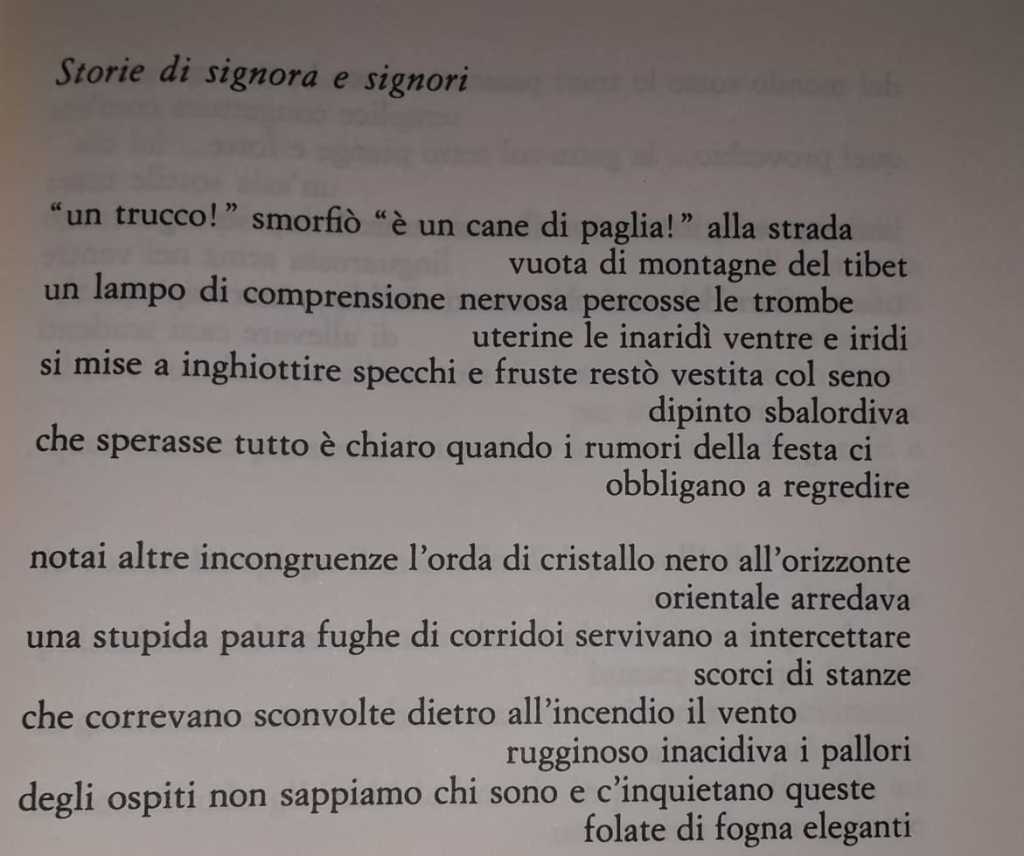
La parabola de Il giovane Max (Adelphi, 1972) un romanzo scomposto in tracce e rimandi caotici, segna l’apice e al tempo stesso la conclusione di questo lavoro sperimentale, come di un’intera epoca. L’opera guarda con disincanto agli esiti della contestazione, ne identifica i limiti e gli stereotipi in forma simbolica, ne sente il respiro corto e autoreferenziale. A questa critica, però, non fa seguire una coerente scelta stilistica, perché Giuliani accelera sullo sperimentalismo delle opere precedenti e lo intensifica fino a diventare barocco, ridondante, artefatto per mestiere.
Non è un caso, quindi, se Versi e non versi si concluda con il tiepido ritorno alle origini (metriche e ritmiche) della sezione Casuali (1978-1984): composizioni brevi, in quartine, pervase di malinconia, tra le quali, però spicca ancora occasionalmente l’indomabile volontà scherzosa e anarchica dell’autore.
Come nella poesia introduttiva della sezione, intitolata La sequenza delle parole, che Giuliani adottò quasi come un’esegesi in explicit della propria poetica
La sequenza delle parole ostacola la comprensione della frase
la frase traccia l’autodescrizione di chi la pronuncia
per la comprensione della frase le parole tagliano
il silenzio che senza comprendere rivelano come
l’orlo di un oggetto incluso nello spazio illusoriamente lo scava
se ascolti nella memoria chi ha detto “ho sete quando piove”
segui una traccia umida oltre la susseguenza o sincronia di due
stati di fatto o desiderio compresi nella frase ormai secca



