Note sulla traduzione italiana di Zong!, come narrato all’autrice da Setaey Adamu Boateng.
Il 18 ottobre scorso è uscita su Pulp una riflessione di Lorenzo Mari sul caso della traduzione italiana di Zong! di M. NourbeSe Philip, pubblicata a giugno 2021 dalla Benway Series e condannata pubblicamente dall’autrice tre mesi più tardi, dopo lunghe e infruttuose contrattazioni private. Più che con il testo poetico in sé, la riflessione di Mari si misura con gli strascichi polemici causati dalla sua pubblicazione, situandoli all’interno di una serie di considerazioni storiche, geografiche, legali e spirituali complesse, non sempre però cogliendo adeguatamente il bersaglio e tratteggiando un quadro molto parziale delle ragioni di fondo che hanno portato alla situazione odierna. Una situazione in cui gli editori della Benway Series continuano a promuovere il libro come se nulla fosse, mentre in rete la petizione di NourbeSe Philip che ne chiede la distruzione e le scuse ufficiali degli editori italiani per non averne rispettato “i protocolli di cura” continua ad accumulare firme.
Premetto subito che quest’intervento, al contrario di Mari che si schiera esplicitamente con la Benway Series, si schiera a favore delle ragioni di Philip contro questa pubblicazione. Intervengo qui in qualità di traduttrice, di studiosa della traduzione, di persona italiana che vive e lavora a Toronto da venticinque anni, e soprattutto di persona che negli anni ha sia assistito alla presentazione delle prime versioni di Zong!, sia partecipato in prima persona all’evoluzione del testo in un rito annuale di veglia collettiva, la cui memoria corporea diretta e condivisa mi convince sempre più che le lezioni più importanti di questo testo sono ancora in fieri – e forse questa vicenda è una di esse.
Voglio precisare anche che non ho dubbi sullo studio e la passione morale che hanno spinto Mariangela Guatteri, Giulio Marzaioli, Renata Morresi e Andrea Raos ad affrontare la traduzione poetica di un testo straordinariamente impegnativo quale è Zong!. Ma passione morale non garantisce attenzione etica ed è proprio nel divario apertosi tra l’una e l’altra che si è incistato il nucleo centrale della vicenda, coinvolgendo più ambiti e soggetti in un assemblaggio sociale di traduzione in cui la razza, in quanto retaggio ancora vivissimo dell’ordine coloniale europeo, ha giocato un ruolo chiave, onnipresente e in/visibile, ma soprattutto irriducibile a banali “differenze d’identità” come il “memoriale difensivo” (cito Mari) degli editori della Benway Series vorrebbe far credere.
In realtà, nonostante gli estremi del caso abbiano subito forti riduzioni polemiche che sembrano grosso modo fare perno sulla rilevanza o meno del discorso antirazzista nordamericano nel contesto italiano, quanto è avvenuto a mio parere mette in luce come i dispositivi legali, economici e ideologici attivati nel processo di traduzione abbiano interferito in modo sostanziale con la poetica (e spiritualità) decoloniale agita in questo libro, rivelando l’impatto sistemico, transnazionale e tuttora traumatico del razzismo anti-nero contemporaneo, non ascrivibile a “mancanza di buona fede” (cito dal memoriale degli editori di Benway), ma al funzionamento stesso delle norme attraverso cui oggi si produce cultura nella scia di un capitalismo globale la cui matrice coloniale di sfruttamento ed espropriazione di corpi, intelligenze e terre non è un rimasuglio storico di orrori che il progresso giuridico avrebbe bandito dalla cosiddetta civiltà occidentale, ma continua riproduzione che ne sorregge l’impalcatura di fondo.
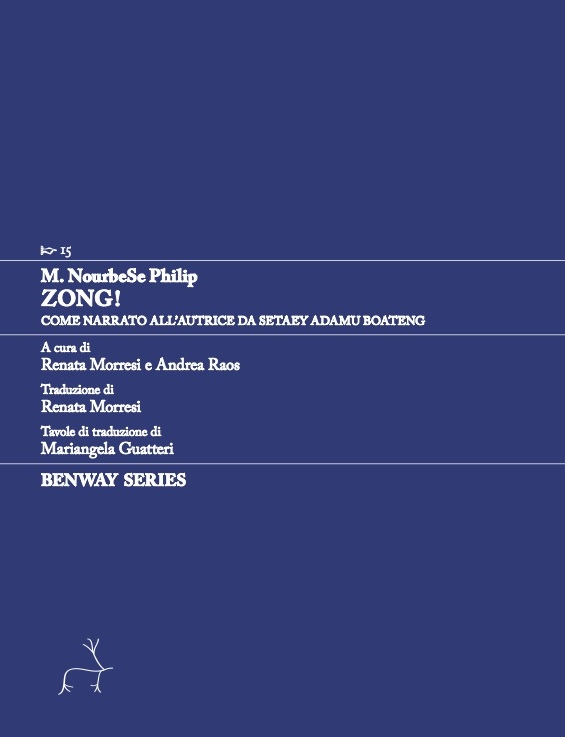
Per Mari il caso Zong! è sintomo di una “fragilità del campo letterario internazionale,” ma la sua analisi si limita a nominare solo le ristrettezze economiche e ideologiche italiane che lo affliggono, mentre gli assunti di valore che ne governano i criteri legali non diventano mai oggetto della sua analisi critica. Anzi. Come gli editori di Benway prima di lui, Mari difende la traduzione italiana proprio appigliandosi alle norme legali internazionali che ne hanno regolato l’iter, senza tener conto che l’adesione formale a tali norme può fare da criterio per ciò che è legittimo, ma non necessariamente per ciò che è giusto. La storia della modernità coloniale è lastricata di norme ingiuste che mascherano di neutralità universale i valori della cultura occidentale ai danni di quelli di tante altre, con effetti drammatici di genocidio ed esproprio culturale che continuano a far danno nella storia delle Americhe e del continente africano. Nel caso di Zong!, un libro che interroga proprio la matrice giuridica europea di tali effetti, è dunque importante chiedersi se i criteri che hanno reso legittima la traduzione italiana di questo libro siano stati sufficienti a renderla giusta.
Detto questo, sono consapevole del fatto che, come scrive la traduttrice Renata Morresi, visti dall’Italia, i motivi che hanno spinto NourbeSe Philip a chiedere la “distruzione” del testo italiano “sembrano abnormi” (in sostanza l’accusa è di una profanazione della sacralità di Zong!). Proprio per questo mi preme chiarire ciò che in essi rimane incomprensibile anche a quanti, come Mari, hanno tentato di darne conto, cadendo purtroppo in una serie di distinguo geografici e storici che hanno l’effetto di reimporre la violenza performativa di una prospettiva europea assunta come universale sul lavoro di un testo che proprio di quell’universalità fa bersaglio d’interrogazione.
Ma andiamo per ordine. Zong! Come narrato all’autrice da Setaey Adamu Boateng è un testo poetico interamente composto dalle parole e lettere trovate in Gregson vs Gilbert, un brevissimo parere legale emanato da una corte inglese nel 1783 in seguito ad una richiesta di risarcimento assicurativo per ‘danni’ che la nave negriera Zong [1] avrebbe subito al suo ‘carico’ di schiavi in seguito a gravi errori di rotta del suo capitano. Che il ‘danno’ fossero le vite di 150 persone africane gettate fuori bordo per mero calcolo commerciale è una mera postilla nella sentenza. Chiuso in quella che Philip chiama la “gabbia” del testo legale inglese, il libro ne distende e distorce le fitte maglie linguistiche, operando non solo uno smantellamento poetico dell’ingiustizia di norme europee che due secoli fa decretavano che un’umanità schiavizzata fosse solo ‘carico’ su una nave, ma anche restituendo, proprio attraverso quello stesso smantellamento linguistico, dignità di sepoltura e respiro spirituale ai morti di allora, e la possibilità a chi legge oggi di partecipare in un rito condiviso di elaborazione del lutto di un momento storico traumatizzante, la tratta atlantica degli schiavi, definita da Fred Moten la catastrofe socioecologica inaugurale della modernità occidentale.
Il caso della traduzione italiana del libro è scoppiato a settembre 2021, quando NourbeSe Philip ne ha annunciato la condanna, pubblicando prima sulla rivista Pree. Carribbean. Writing, poi su Facebook e sul suo blog, una serie di resoconti dettagliati degli eventi che l’hanno spinta a tale decisione. I resoconti di Philip citano la corrispondenza tra le parti in causa e indicano con precisione il momento in cui ad una cauta accoglienza iniziale è subentrata la condanna.

In sostanza, l’autrice accusa la traduzione italiana, che considera “flawed” (difettosa), di due violazioni etiche. La prima è che l’intero processo di traduzione è avvenuto senza consultazione autoriale e di conseguenza nell’ignoranza dei ‘protocolli di cura’ e ascolto degli antenati, in relazione ai quali il libro stesso è stato scritto, come indicato dal sottotitolo “Come narrato all’autrice da Setaey Adamu Boateng” – sottotitolo che, lungi dall’essere un banale espediente letterario, ne rivela l’orientamento etico di fondo in quanto lavoro di testimonianza che l’autrice ha portato avanti in una relazione di responsabilità nei confronti dei morti (Setaey Adamu Boateng è infatti il nome ricostruito di uno degli africani gettati fuoribordo dalla nave Zong). La seconda accusa mossa dall’autrice è che la traduzione non rispetta un principio visivo nominato in Notanda, la postfazione autoriale al libro, per il quale da un certo punto in poi nel testo nessuna parola o lettera, o gruppo di parole o lettere, può apparire immediatamente sotto un’altra. Questo principio di spaziatura sulla pagina (che purtroppo la traduzione italiana non rispetta quasi mai — cosa quanto più sorprendente considerate le dimensioni inusuali del libro), costituisce per l’autrice un aspetto non negoziabile del poema, perché ne sorregge l’impalcatura spirituale, che restituisce ‘respiro’ alle vite annegate di allora e a chi, leggendo oggi, si pone in loro ascolto.
A ben guardare, i protocolli di cura sottolineano la centralità della relazione nel lavoro poetico (Philip spesso si autodescrive come ‘un-author’ del testo, una ‘non-‘ o ‘dis-’ autrice, se vogliamo, che si mette al servizio della voce degli antenati), mentre la poetica del respiro sottolinea il primato dell’oralità e della recitazione ad alta voce, lì dove gli spazi bianchi ritmano l’alternarsi di voce e silenzio nella lettura orientando quest’ultima verso una dimensione rituale. Rito di veglia, per la precisione, il cui fine è di restituire dignità e ascolto ai morti, altrimenti annientati dalle forze del mare e dalla forza performativa della legge che nel 1781 decretava queste vite essere null’altro che ‘carico’ sulla nave.
Responsabilità scritturale verso gli antenati a monte, apertura ad una dimensione rituale del leggere a valle: sia i ‘protocolli di cura’ che la ‘poetica del respiro’ esprimono il contesto sociale e spirituale di significanza decoloniale del testo che lo rende irriducibile a criteri occidentali di normazione di valore letterario, per i quali il primato spetta all’individualità autoriale (ritenuta essere in ‘possesso’ della sua opera e dunque anche libera di ‘cederla’ ad altri) e alla pagina scritta (la cui lettura è principalmente fatta in silenzio). Sono questi ultimi principi che hanno regolato di fatto l’iter legale della traduzione italiana, ove sia l’acquisto dei diritti di traduzione, sia i fondi emanati dal Canada Council e il controllo in ‘peer blind review’ della qualità della stessa, sono potuti avvenire senza che nessuno fosse tenuto per legge a rendere conto né della dei ‘protocolli di cura’ né della ‘poetica del respiro’. Quando Mari sostiene che la correttezza dell’iter legale della traduzione “implica che le accuse dell’autrice siano riconducibili solo alla sua persona” dimentica volutamente che è la legge stessa che inchioda l’autrice in questa posizione, in quanto sancisce l’omissione di criteri di valutazione altri da quelli occidentali.
E qui vengo al problema del sacro. Per Philip i protocolli di cura e la poetica del respiro sono il “sacro” che anima il poema, e l’irremovibilità di questa nominazione è forse ciò che ha agitato di più gli animi in Italia, provocando reazioni estreme di rigetto e accostamenti traumatizzanti ai più nefasti totalitarismi religiosi di cui la storia italiana è piena (vedi i numerosi commenti in questo senso fatti sulla pagina Facebook di Benway). Ma anche travisamenti profondi che hanno portato a risposte arroganti e ad una terribile ironia storica che ha aggiunto insulto al danno perpetrato dalle violazioni stesse. Si tratta di arroganze visibili sia nella corrispondenza tra le parti postata sul blog dell’autrice che in parti del ragionamento di Mari.
Ad esempio, sul loro sito gli editori dichiarano di aver seguito la “via istituzionale” per “rispetto” del tempo dell’autrice. Tuttavia, una lettura attenta della corrispondenza tra le parti avvenuta quest’estate, rivela una dinamica molto diversa. Concediamo pure che “rispetto” ci sia stato nella decisione di non contattare l’autrice durante il processo della traduzione, ma di che “rispetto” si può parlare dal 18 giugno in poi, quando, nonostante l’autrice avesse dichiarato con fermezza le ragioni per cui non poteva accettare la traduzione, e nonostante Susanna Tamminem, capo redattrice della Wesleyan University Press, avesse concordato con il giudizio di Philip, e nonostante Morresi stessa avesse concesso che il testo italiano non rispettava in molti punti la spaziatura richiesta da Philip, gli editori di Benway hanno comunque deciso di procedere con la promozione del libro e di liquidare le proteste autoriali come un problema “personale” di mancata comunicazione?
Questa doppia mossa di valorizzazione della lettera della legge e di marginalizzazione della voce di un’autrice la cui opera poetica interroga esattamente ciò che la lettera della legge attivamente esclude, porta un carico di violenza simbolica la cui terribile ironia storica sembra sfuggire completamente agli editori di Benway, e a chi, come Mari, ne difende l’operato. Al nocciolo, la logica formale di fondo che permette a questi ultimi di smistarsi dall’obbligo etico di ascolto della voce autoriale è la stessa che 238 anni fa ha permesso ai giudici del caso Gregson vs Gilbert di smistarsi dall’obbligo etico di considerare come altro che mero carico le vite degli africani buttati fuori bordo dalla nave Zong. Nel 1783, infatti, il giudice Buller squalificò come “non pertinente” la richiesta fatta da alcuni avvocati di considerare i fatti avvenuti sulla nave Zong come rilevanti ad una causa per omicidio, perché una tale causa era fuori dall’ambito circoscritto esclusivamente dal contratto tra proprietari e assicuratori della nave. In quel contratto, i soggetti legali sono solo i proprietari e gli assicuratori della nave, mentre le vite africane vi appaiono unicamente come “carico”, insomma come oggetti senza volizione propria e senza accesso ad una personalità legale. In modo simile, nel 2021, gli editori di Benway squalificano come “non pertinente” la voce dell’autrice perché questa esula dall’ambito circoscritto dei contratti che la Benway ha ingaggiato prima con la Wesleyan Press e poi con il Canada Council.
Mi si dirà che questo paragone è ingiusto ed eccessivo, visto che nel 2008 la Philip aveva volontariamente firmato un contratto in cui rinunciava ai suoi diritti di traduzione sul libro e dunque la sua posizione non può essere paragonata a quella, assolutamente coercitiva, degli schiavi a bordo di Zong. Questa accusa mi è stata già fatta da Giulio Marzaioli sulla pagina Facebook di Benway, ove mi è stato detto che in un giro di frase io avrei “azzerato più di duecento anni di progresso giuridico.” Sorvolo per ora sull’idea che ci sia stato un reale ‘progresso giuridico’ nell’impianto coloniale che sorregge la giurisprudenza euro-americana (esistono ormai tomi nell’area dei Black Studies che mettono in luce come l’habeas corpus che fa da pietra angolare del nostro ordine giuridico, si fonda su di una non-detta ma onnipresente linea del colore anti-nera) [2]. Il punto qui è che non è agli africani uccisi che va paragonata la posizione di Philip. Piuttosto, la posizione autoriale è simile a quella degli avvocati che nella causa di Gregson vs Gilbert si adoperarono per convincere i giudici che si era trattato di omicidio inflitto su esseri umani e non di danno economico inflitto su un ‘carico’. Come gli avvocati di allora, Philip si sta adoperando per difendere i morti, i suoi morti, uccisi due volte, prima in mare e poi in tribunale.
Nel 1783 il caso non fu vinto, ma diede una spinta enorme al movimento britannico per l’abolizione della schiavitù. In altre parole, gli avvocati riuscirono a sollevare nella coscienza degli inglesi che assistettero al processo il dubbio che quelle vite fossero più che mero “carico.”
Nel caso del contenzioso sollevato da questa traduzione, l’insistenza di Philip a che siano rispettati i protocolli di cura e la poetica del respiro del testo solleva nella coscienza di chi legge il dubbio che in gioco nella traduzione ci sia molto di più di un problema tecnico di resa grafica o mera differenza morfologico-sintattica tra lingue. Tutt’altro. In gioco c’è una relazione di cura della memoria dei morti e attenzione al dolore dei vivi fondata su di un riconoscimento di fondo di quella che Katherine McKittrick chiama “black livingness” (traducibile in modo molto approssimativo con “il vivente nero”), che significa anche misurarsi con la specificità di forme di vita nere non assimilabili ai discorsi legali della modernità [3]. Non rispettare tutto questo equivale ad una inaccettabile profanazione.
Quando Philip accusa la traduzione di aver violato la sacralità del testo, si riferisce esattamente a quest’aspetto del poema. Non sono le parole da sole sulla pagina che sono sacre, anzi. Le parole sono null’altro che una decostruzione e ricomposizione ancora in fieri della violenza che l’ordine legale della civiltà europea ha inflitto e ancora infligge su vite rubate al continente africano. Come tali, le parole possono essere tradotte in tutti i modi possibili e secondo la sensibilità culturale della lingua/cultura d’arrivo. Philip non ha mai avuto nulla da ridire sul testo italiano di Morresi perché l’aspetto essenziale del poema, l’aspetto che compie il lavoro del lutto, non sono le parole in sé, ma gli spazi tra di esse. Sono quegli spazi che danno respiro ai morti e che liberano il testo legale dal suo retaggio oppressivo.
Nessuno alla Benway, nei lunghi tre mesi di contrattazione estiva con l’autrice, ha avuto la cortesia di riconoscere l’importanza spirituale di tali spazi, né ha compreso la gravissima mancanza di rispetto verso quei morti che la difesa a oltranza della pubblicazione del libro italiano ha perpetrato. A leggere la corrispondenza si ha l’impressione di una sordità voluta, quasi rancorosa, che rivendica il diritto degli italiani ad appropriarsi del testo inglese per operare un “corto circuito” (parole di Morresi) al fine di gettare luce sulla crisi migrante del mediterraneo. Ma questa traslazione geografica, per quanto valida di suo, è stata operata (e continua ad avvenire) senza il passaggio di un primo esplicito riconoscimento del carattere rituale di veglia insito nel testo. Senza quel passaggio, il libro italiano si presenta come mera appropriazione mimetica (colpisce per esempio nel libro l’assenza di una quale che sia nota di traduzione che dia conto delle inevitabili modificazioni avvenute nell’italiano) svuotata di un ingrediente essenziale che aiuterebbe a compiere un salto simbolico enorme nel contesto drammatico di quello che è a tutti gli effetti un nuovo ‘middle passage’ nel mediterraneo. Riconoscere l’importanza specifica dell’aspetto rituale del testo e la pertinenza delle ragioni di Philip anche al contesto italiano costituisce a mio parere un passo necessario alla coltivazione non solo di una sensibilità decoloniale nelle pratiche di traduzione contemporanee, ma anche più in generale di una sensibilità anti-razzista in Italia che vada oltre l’ovvia denuncia del razzismo fascista e prenda atto della necessità di dare voce e ascolto alle storie e soggettività della diaspora africana alle loro condizioni e nei loro termini.
“Ci sono memorie per scavare nelle parole senza profanare tombe” scrive Nicole Brossard ne Il deserto malva — un testo da me tradotto più di una decade fa. Continuo a pensare che sia ancora possibile imparare da questa vicenda e riparare al torto fatto, rifondando i termini della relazione con l’autrice, i suoi antenati e i suoi mondi. E il primo passo è riconoscere che torto ci è stato. Altrimenti, come ho già scritto su Facebook, è solo altra ‘cultura buttata al vento’.
Toronto, 30 dicembre 2021
Un grazie di cuore a Valeria Giasi e Vincenzo Bagnoli per il loro feedback e i suggerimenti sulla prima versione di questo articolo.
NOTE
[1] Non penso sia di secondaria importanza il fatto che al contrario dell’inglese, che le identifica con il doppio sostantivo ‘slave ships’, le navi adibite alla tratta di schiavi in italiano siano chiamate navi “negriere.” La litote che assorbe una condizione specifica di dominio legale (la schiavitù) nel colore della pelle (nera) la dice lunga sul retaggio razzista ottocentesco ancora presente nel vocabolario italiano.
[2] Vedasi in special modo Habeas Viscus. Racializing Assemblages di Alexander Weheliye (Duke University Press, 2014); The undercommons. Fugitive Planninng and Black Study di Fred Moten e Stefano Harney (Minor Composition, 2013); In the Wake. On Blackness and Being di Christina Sharpe (Duke University Press, 2016); The Long Emancipation: Toward Black Freedom di Rinaldo Walcott (Duke University Press, 2021).
[3] Dear Science and Other Stories (Duke University Press, 2021).



