La scia della narrativa sull’epopea della Resistenza continua ancora oggi; per evidenti motivi anagrafici, gli autori non raccontano più ciò che hanno vissuto in prima persona. Tra i contemporanei agli eventi, a parte la memorialistica e l’autobiografia, mi sembrano più efficaci quegli autori e autrici che hanno raccontato la guerra civile in maniera non agiografica. In particolare, Beppe Fenoglio ha saputo restituire il senso di rivolta di tanti giovani insieme all’inquietudine propria dell’età. Il romanzo che più di tutti mi rimane nella memoria, e che ho più volte riletto, è Una questione privata.
Scrive Italo Calvino nella prefazione al suo romanzo sulla Resistenza Il sentiero dei nidi di ragno, in occasione della ripubblicazione nel 1964 per il Club degli Editori:
E fu il più solitario di tutti che riuscì a fare il romanzo che tutti avevamo sognato, quando nessuno più se l’aspettava, Beppe Fenoglio, e arrivò a scriverlo e nemmeno a finirlo, e morì prima di vederlo pubblicato nel pieno dei quarant’anni. Il libro che la nostra generazione voleva fare adesso c’è e il nostro lavoro ha un coronamento, un senso, e solo ora, grazie a Fenoglio, possiamo dire che una stagione è compiuta, solo ora siamo certi che è veramente esistita: la stagione che va dal Sentiero dei nidi di ragno a Una questione privata.
Calvino conclude con una frase che è un’ammissione sincera e encomiabile: «È al libro di Fenoglio che volevo fare la prefazione: non al mio.»
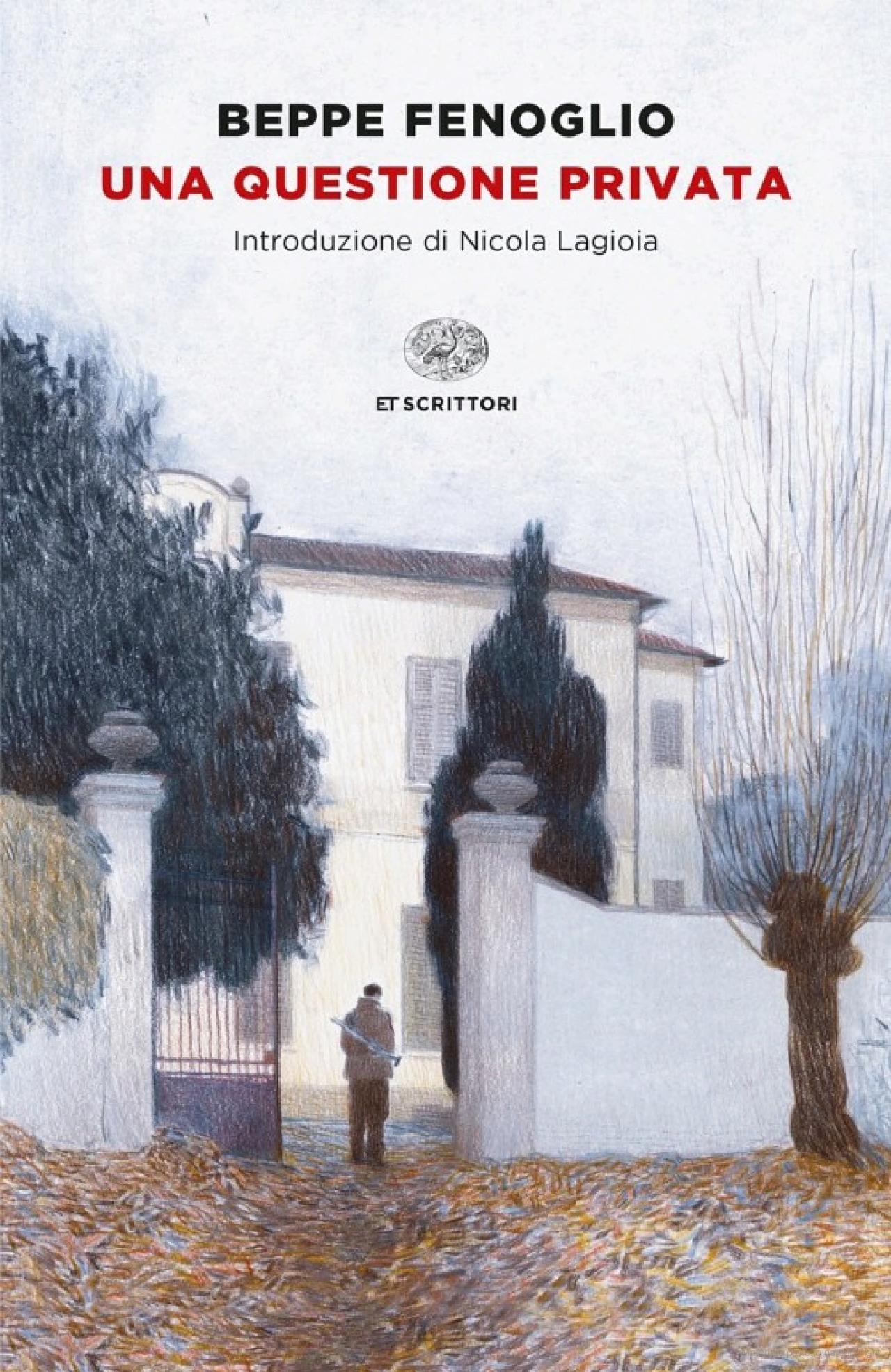 Due partigiani sono fermi davanti a una villa presso Alba, nelle Langhe. È qui che viene in villeggiatura Fulvia, la ragazza di uno dei due, che in montagna è conosciuto come Milton. Fulvia e i genitori sono fuori casa, probabilmente a Torino; Milton ha chiesto all’altro partigiano, Ivan, qualche minuto per abbandonarsi ai ricordi piacevoli che la villa gli evoca.
Due partigiani sono fermi davanti a una villa presso Alba, nelle Langhe. È qui che viene in villeggiatura Fulvia, la ragazza di uno dei due, che in montagna è conosciuto come Milton. Fulvia e i genitori sono fuori casa, probabilmente a Torino; Milton ha chiesto all’altro partigiano, Ivan, qualche minuto per abbandonarsi ai ricordi piacevoli che la villa gli evoca.
Ivan freme, vorrebbe tornare al comando perché se si avviano in ritardo, teme di incontrare nella nebbia pattuglie di soldati repubblichini; ma Milton è ormai in balia dei ricordi. Ogni albero intorno alla villa gli ricorda Fulvia, la vita prima della guerra, e forse la vita che si aspetta dopo la guerra.
È stato l’amico Giorgio Clerici, che adesso è pure lui in montagna, in un’altra brigata partigiana, a presentargli Fulvia al termine di una partita di pallacanestro. Fulvia è una torinese di sedici anni che con i genitori viene in villeggiatura presso Alba. Giorgio ha introdotto Milton con parole di elogio: «Fulvia, questo è un dio in inglese», e Fulvia l’aveva invitato alla villa perché le traducesse il testo di Deep Purple, la canzone di Peter DeRose.
Lui tradusse, dal disco al minimo dei giri. Lei gli diede sigarette e una tavoletta di quella cioccolata svizzera. Lo riaccompagnò al cancello. «Potrò vederti, — domandò lui, — domattina, quando scenderai in Alba?» «No, assolutamente no.»
Non ci si aspetterebbe di trovare in un romanzo sulla Resistenza la citazione di un brano pop (che, tra l’altro, ha anche suggerito a Ritchie Blackmore il nome del suo famoso gruppo hard rock: Deep Purple del pianista Peter DeRose, scritta nel 1933, era infatti la canzone preferita di sua nonna, un titolo suggestivo che gli rimase impresso nella memoria); ma questa è solo un’ulteriore riprova della freschezza, dell’attualità della Resistenza, e degli uomini e donne che l’hanno fatta, spesso imbalsamati in una capsula atemporale in cui i ruoli sono predeterminati da una tradizione agiografica.
Milton porta alla ragazza libri americani, come Edgar Allan Poe, poi racconti tradotti da lui stesso, finché da un certo momento in poi Fulvia non legge nient’altro che ciò che la letteratura che le passa lui. Costretta dai genitori a ritornare a Torino dopo l’8 settembre, quando le colline e la campagna sono diventate più pericolose delle città bombardate, Fulvia fa promettere a Milton di scriverle lettere, e lui ubbidisce, innamorato perso.
Ma quel giorno di nebbia, davanti alla villa deserta, il tarlo atroce del dubbio si insinua in Milton. Cos’è accaduto tra Fulvia e Giorgio? Milton si era accorto di quanto i caratteri della ragazza e dell’amico fossero compatibili. Vuole a tutti i costi scoprire se è accaduto qualcosa tra i due, mentre lui era in montagna: «Il fatto è che più niente m’importa. Di colpo, più niente. La guerra, la libertà, i compagni, i nemici. Solo più quella verità».
Al ritorno al comando di brigata, Milton chiede mezza giornata di permesso, vuole andare al comando partigiano a Mango, dove sa che si trova la formazione in cui milita Giorgio: «Non poteva più vivere senza sapere e, soprattutto, non poteva morire senza sapere, in un’epoca in cui i ragazzi come lui erano chiamati più a morire che a vivere.»
Giorgio però non si trova a Mango, al ritorno da una missione è rimasto indietro, gli altri l’hanno perduto nella nebbia fitta.
Le ore passano, le peggiori ipotesi di Milton e dei compagni trovano conferma: vengono a sapere che Giorgio Clerici, perduto nella nebbia, «un mare di latte», si è imbattuto in una pattuglia di fascisti. L’hanno riconosciuto subito come partigiano, dal momento che è armato e indossa una delle divise paracadutate dal cielo dagli inglesi insieme ai rifornimenti.
Ora è prigioniero in città, ma i prigionieri non durano molto in questa guerra. È essenziale un veloce scambio di ostaggi: ma i badogliani, le formazioni partigiane in cui Milton milita, non hanno ostaggi in questo momento.
Milton si reca al comando della formazione garibaldina che occupa una vicina collina; tra le due anime della Resistenza non corre buon sangue, i comunisti sono gelosi perché gli alleati paracadutano armi e vettovaglie solo agli “azzurri”, i badogliani. Milton conosce personalmente il comandante comunista Hombre perché hanno combattuto insieme, ma il suo tentativo va a vuoto, l’ultimo fascista nelle loro mani è stato fucilato il giorno precedente.
Perché si dà tanto a fare, Milton? Per salvare Guido, l’amico più caro, o per sapere la verità su quello che considera un tradimento sentimentale?
Una questione privata è un titolo redazionale, scelto recuperando quello che Fenoglio usava nel parlare del romanzo con la moglie, e che riflette la convinzione dell’autore per cui la Resistenza sia stata soprattutto una tragedia personale, una guerra civile dell’anima.
Alla morte, a 41 anni di età, Fenoglio lascia numerosi manoscritti, generalmente privi di titolo; tra essi “il libro grosso sul quinquennio 1940-1945”, su cui lavora a lungo, oggi pubblicato come Il partigiano Johnny, dal quale si ricaverà però anche Primavera di bellezza. È sua abitudine cannibalizzare i testi più lunghi per ricavarne storie autonome e brevi: La paga del sabato smembrato in due testi brevi, L’imboscata, che pure ha per protagonista il partigiano Milton, diviso per ricavarne racconti sulla Resistenza, che finiranno nell’unica raccolta pubblicata durante la vita, I ventitré giorni della città di Alba.
Sorpreso dalla malattia nel mezzo della maturità, anche artistica, Fenoglio si preoccupa di lasciare su un biglietto istruzioni sull’ordine in cui avrebbero dovuto essere pubblicati i suoi racconti, tralasciando di disporre per i romanzi: forse perché non li considera pubblicabili nella versione parzialmente completa in cui si trovano.
In Una questione privata, che tanto ha impressionato Calvino, pubblico e privato si intersecano in un intreccio indissolubile, che rende ancora più vera la storia. La disperata ricerca di Milton di un metodo per salvare il compagno non è dettata da amicizia o cameratismo, ma dal più umano e ambiguo sentimento della gelosia.
Secondo il fratello, Fenoglio sul letto di morte avrebbe chiesto alla famiglia di distruggere tutti i suoi scritti con l’eccezione di due racconti e di Una questione privata, segno che era consapevole quantomeno del valore del romanzo, anche se non considerava pubblicabili altri testi, forse perché incompiuti. Per nostra fortuna, il suo desiderio non è stato esaudito.



