In un recente articolo apparso su Il riformista, Lea Melandri, sostenendo l’ipotesi che sarebbe stato meglio non inviare armi all’Ucraina, ha scritto:
“Pace” oggi per me, come per molte altre femministe, vuol dire porsi “su un altro piano”, andare alle radici di quel primo atto di guerra che è stata la sottomissione delle donne, considerate “natura inferiore”, “animalità”, il loro asservimento al sesso vincitore. È da questa guerra mai dichiarata, e perciò più subdola, invisibile perché coperta dalla sua “naturalità”, che nasce il perverso connubio tra distruzione e salvezza, tra guerra e umanitarismo, guerra e religione. Se, come ho scritto più volte, “gli orrori hanno un genere”, è da questo fondamentale retroterra che dobbiamo partire per dar modo al pensiero e all’immaginazione di scoprire nuovi modi per uscire dalla barbarie che abbiamo ereditato.
“Su un altro piano”, in contrapposizione con interpretazioni e iconografie stereotipate trasmesse, quasi per eredità, da una generazione all’altra di studiosi dalla seconda metà dell’Ottocento sino ad anni relativamente recenti, ci portano questi due libri pubblicati recentemente in Italia e usciti in Francia nel 2020: l’obiettivo di entrambi è decostruire l’immagine della donna preistorica definita secondo i pregiudizi culturali androcentrici e sessisti degli studiosi maschi che per primi si sono occupati di preistoria.
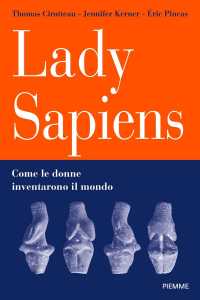 Lady Sapiens, scritto da uno storico (Pincas) insieme al regista del documentario omonimo (Cirotteau) e a un’antropologa (Kerner), con la supervisione scientifica della preistorica Sophie A. de Baune, racconta nel dettaglio le recenti scoperte che hanno gettato nuova luce sulle società del Paleolitico superiore (tra 40.000 e 10.000 anni fa) grazie al progresso delle analisi fisico-chimiche e bioantropologiche.
Lady Sapiens, scritto da uno storico (Pincas) insieme al regista del documentario omonimo (Cirotteau) e a un’antropologa (Kerner), con la supervisione scientifica della preistorica Sophie A. de Baune, racconta nel dettaglio le recenti scoperte che hanno gettato nuova luce sulle società del Paleolitico superiore (tra 40.000 e 10.000 anni fa) grazie al progresso delle analisi fisico-chimiche e bioantropologiche.
 Il libro di Patou-Mathis (il cui titolo originale è L’uomo preistorico è anche una donna), studiosa specializzata nel comportamento dei Neanderthal e direttrice del Centre national de la recherche scientifique (Cnrs), inquadra invece il soggetto nel contesto storico europeo nel quale sono nati gli studi di preistoria. La prima parte del libro è un ampio excursus sulla visione della donna nei testi e negli autori della tradizione giudaico-cristiana e greco-romana (la Bibbia, San Paolo, Aristotele, il diritto canonico, i trattati medici…). Le donne sono “uomini imperfetti”, colpevoli del peccato originale; inferiori per natura, come ripetuto nei testi di medicina da Ippocrate in avanti, dove sono riportate varie teorie per spiegare ‘scientificamente’ la loro debolezza e, di conseguenza, giustificare il dominio dell’uomo, che ha il compito di sorvegliarle e punirle; preda dei propri sensi, incapaci di governarsi da sole, facili all’isteria e quindi anche moralmente deboli, vulnerabili, incapaci di ragionare, inadatte a essere educate. Le donne hanno dentro di sé qualcosa di impuro che l’uomo teme e perciò cerca di dominare. Si pensi ai tabù sul sangue mestruale, considerato impuro in quanto sangue cattivo e oggetto di divieti in molte religioni. È un sangue che fa paura perché incontrollabile, reiterato e per molti dal forte odore: secondo una credenza molto diffusa in Europa fino all’inizio del Novecento, metteva in fuga la selvaggina, da cui deriverebbe l’esclusione della donna, in molte società, dalla pratica della caccia (uno strascico di questa credenza è forse rimasto in alcune imbarazzanti pubblicità sugli assorbenti femminili che eliminano i “cattivi odori”). Lo storico del Medioevo Jacques Le Goff riporta che nel Duecento si riteneva che l’uomo ebreo avesse le mestruazioni, una tradizione che testimonia tanto l’antisemitismo del tempo quanto l’alterità incarnata dalla donna. Nonostante certi aspetti quasi diabolici, la donna è destinata alla maternità, alla cura dei figli e in genere alla sfera domestica; nello stesso tempo, a essere piacente e servile, a curare e allietare gli uomini: è l’iconografia sessista ambivalente di madonna e puttana, come ha scritto bell hooks (pseudonimo di Gloria Jean Watkins), la scrittrice e femminista afroamericana da poco scomparsa.
Il libro di Patou-Mathis (il cui titolo originale è L’uomo preistorico è anche una donna), studiosa specializzata nel comportamento dei Neanderthal e direttrice del Centre national de la recherche scientifique (Cnrs), inquadra invece il soggetto nel contesto storico europeo nel quale sono nati gli studi di preistoria. La prima parte del libro è un ampio excursus sulla visione della donna nei testi e negli autori della tradizione giudaico-cristiana e greco-romana (la Bibbia, San Paolo, Aristotele, il diritto canonico, i trattati medici…). Le donne sono “uomini imperfetti”, colpevoli del peccato originale; inferiori per natura, come ripetuto nei testi di medicina da Ippocrate in avanti, dove sono riportate varie teorie per spiegare ‘scientificamente’ la loro debolezza e, di conseguenza, giustificare il dominio dell’uomo, che ha il compito di sorvegliarle e punirle; preda dei propri sensi, incapaci di governarsi da sole, facili all’isteria e quindi anche moralmente deboli, vulnerabili, incapaci di ragionare, inadatte a essere educate. Le donne hanno dentro di sé qualcosa di impuro che l’uomo teme e perciò cerca di dominare. Si pensi ai tabù sul sangue mestruale, considerato impuro in quanto sangue cattivo e oggetto di divieti in molte religioni. È un sangue che fa paura perché incontrollabile, reiterato e per molti dal forte odore: secondo una credenza molto diffusa in Europa fino all’inizio del Novecento, metteva in fuga la selvaggina, da cui deriverebbe l’esclusione della donna, in molte società, dalla pratica della caccia (uno strascico di questa credenza è forse rimasto in alcune imbarazzanti pubblicità sugli assorbenti femminili che eliminano i “cattivi odori”). Lo storico del Medioevo Jacques Le Goff riporta che nel Duecento si riteneva che l’uomo ebreo avesse le mestruazioni, una tradizione che testimonia tanto l’antisemitismo del tempo quanto l’alterità incarnata dalla donna. Nonostante certi aspetti quasi diabolici, la donna è destinata alla maternità, alla cura dei figli e in genere alla sfera domestica; nello stesso tempo, a essere piacente e servile, a curare e allietare gli uomini: è l’iconografia sessista ambivalente di madonna e puttana, come ha scritto bell hooks (pseudonimo di Gloria Jean Watkins), la scrittrice e femminista afroamericana da poco scomparsa.
L’interpretazione dei dati archeologici è stata falsata dai preconcetti culturali della borghesia europea della seconda metà dell’Ottocento, secondo i quali le disuguaglianze tra i sessi sono determinate dalla natura e sono quindi immutabili per ogni epoca e luogo. Lo sguardo maschile ha costruito un’immagine della donna nella preistoria confacente con la cultura patriarcale dell’epoca; ha teorizzato una divisione dei lavori sulla base del genere, sul presupposto che le donne non fossero in grado di svolgere certe attività; i compiti sono stati gerarchizzati, considerando più valorizzanti quelli svolti dagli uomini. Così la caccia, ritenuta prettamente maschile, è stata considerata più importante della raccolta di erbe, semi e ghiande, attribuita alle donne, in quanto permette di procacciare cibo dal maggiore valore nutritivo. La donna è stata relegata alla sfera familiare, alla cura dei bambini, mentre tutti gli affari connessi all’ambito sociale, politico, culturale, artistico, tecnologico, sono stati considerati di pertinenza maschile.
Nell’Esposizione Universale di Parigi del 1889 la ricostruzione di un rifugio di uomini di Cro-Magnon (poi inclusi negli Homo sapiens) comprendeva un maschio accompagnato da due avvenenti femmine vestite con un gonnellino, e a seno scoperto; l’iconografia della donna preistorica poco vestita (ma sempre rigorosamente di pelli e pellicce) avrà una lunga fortuna anche cinematografica (si pensi alla Raquel Welch di Un milione di anni fa, 1966). Nello stesso tempo (torna l’ambivalenza) la donna preistorica appare sovente rappresentata circondata da bambini che non le danno tregua, o mentre viene trascinata nella grotta come una bestia (per esempio in un film di Buster Keaton del 1923: Senti, amore mio).
Patou-Mathis sostiene che la condizione femminile di inferiorità si sia strutturata nel Neolitico, in concomitanza con l’affermarsi della sedentarizzazione, della domesticazione delle piante e degli animali, della formazione delle élite sociali e politiche. Secondo Friedrich Engels il “valore di mercato” delle donne sarebbe comparso insieme all’agricoltura, all’allevamento e all’unione coniugale (Origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato, 1884) e in parallelo potrebbe essere stato imposto il predominio maschile, anche con l’uso della violenza singola e collettiva (la cultura della guerra va di pari passo con la cultura dello stupro). Secondo Patou-Mathis è possibile che nel Paleolitico la famiglia monogama e patriarcale non fosse ancora definita come standard ma questa tesi non è validabile così come quella della prevalenza di società matriarcali o matrilineari, cioè che privilegiano la filiazione per via materna (questa fu la teoria sostenuta negli anni Settanta dall’archeologa Marija Gimbutas, su influenza di teorie femministe).

La materialità riscoperta dalla moderna archeologia permette di evidenziare la mancanza di fondamento di molte tesi un tempo date per scontate e di mostrare una visione più ricca e sfaccettata della donna e delle società paleolitiche. Come esempio di interpretazione falsata da vizi teorici Patou-Mathis cita un caso non preistorico: nel sito vichingo (VIII-X secolo d.C.) di Birka, nell’isola di Björkö in Svezia, nel 1878 fu scoperta la sepoltura di un guerriero, con corredo composto da una spada, due lance e venticinque frecce, due cavalli, un piano da gioco con pedine. Nel 2017, le analisi del DNA permisero di stabilire che lo scheletro in realtà era di una donna, morta tra i trenta e i quarant’anni. Dopo lo scoop non sono mancate le voci critiche: sono state analizzate le ossa giuste? Forse nella tomba era seppellito anche un uomo (che però non ha lasciato tracce…)? Forse si tratta di un transgender? Solo quando lo scheletro è stato riconosciuto come femminile, inoltre, alcuni studiosi hanno avanzato l’ipotesi che quelle armi potrebbero aver avuto un valore puramente simbolico e non essere mai state usate in vita. Anche in ambito preistorico non mancano esempi di sepolture maschili poi rivelatesi femminili, come la donna del Caviglione, ex-Uomo di Mentone, scoperta nel 1872 in una grotta sotto la falesia del Balzi Rossi a Ventimiglia. A discolpa degli archeologi della seconda metà del XIX e della prima metà del XX secolo c’è il fatto che fino ad alcuni decenni fa le analisi antropologiche non permettevano una identificazione sempre precisa del sesso e non era ancora possibile l’analisi del DNA.
Quando immaginiamo le donne e gli uomini della preistoria dobbiamo pensare a una pluralità di gruppi probabilmente molto differenti uno dall’altro e che gestivano in modi diversi le attività, come la caccia. Gli indicatori di stress biomeccanici da armi da lancio, rilevabili sulle ossa (per esempio, micro-fratture ossee che compaiono in seguito a lesioni delle articolazioni del gomito) sono presenti soprattutto negli uomini; questo, tuttavia, non esclude una partecipazione delle donne alla caccia, quantomeno in attività correlate come accade in molte comunità moderne di cacciatori-raccoglitori (spingere le mandrie verso i cacciatori, preparare le trappole, ecc.). Inoltre, dove l’apporto femminile doveva per forza essere grande (trattandosi di piccole comunità che non potevano permettersi di rinunciare a una parte della forza lavoro) era in tutti i lavori successivi all’uccisione delle prede: la conciatura e la lavorazione delle pelli, il trattamento delle carni, la preparazione del cibo.
 Il fatto che le donne siano state relegate a ruoli ritenuti secondari è tanto più sorprendente se si pensa all’arte figurativa, dove la figura femminile è sovra-rappresentata rispetto all’uomo. L’arte paleolitica raffigura principalmente animali. Quando troviamo figure umane, incise o dipinte su pareti di grotte, o statuette in osso, corno di cervide, pietra, argilla, quasi al 90% sono femminili e sono di solito appellate “Veneri”. La tipologia è molto varia; tratti ricorrenti sono la nudità, l’evidenza degli attributi sessuali (seno, natiche e parte superiore delle cosce, vulva), l’assenza o la dimensione ridotta della testa (spesso priva di bocca e occhi). In diversi casi sono molto prosperose (steatopigia). Le statuette sono state ritrovate su un territorio molto vasto dall’Inghilterra alla Siberia e sono presenti per circa 25.000 anni del Paleolitico superiore; la prima, la c.d. “Venere impudica”, fu scoperta nel 1884, nel rifugio di Laugerie-Basse in Dordogna. Tra le scoperte più recenti ed eclatanti un gruppo di 15 statuette ritrovate nel 2019 a Renancourt (presso Amiens) in un sito abitato tra i 28.000 e i 22.000 anni fa da un gruppo che si spostava seguendo le mandrie di cavalli, cervi e renne.
Il fatto che le donne siano state relegate a ruoli ritenuti secondari è tanto più sorprendente se si pensa all’arte figurativa, dove la figura femminile è sovra-rappresentata rispetto all’uomo. L’arte paleolitica raffigura principalmente animali. Quando troviamo figure umane, incise o dipinte su pareti di grotte, o statuette in osso, corno di cervide, pietra, argilla, quasi al 90% sono femminili e sono di solito appellate “Veneri”. La tipologia è molto varia; tratti ricorrenti sono la nudità, l’evidenza degli attributi sessuali (seno, natiche e parte superiore delle cosce, vulva), l’assenza o la dimensione ridotta della testa (spesso priva di bocca e occhi). In diversi casi sono molto prosperose (steatopigia). Le statuette sono state ritrovate su un territorio molto vasto dall’Inghilterra alla Siberia e sono presenti per circa 25.000 anni del Paleolitico superiore; la prima, la c.d. “Venere impudica”, fu scoperta nel 1884, nel rifugio di Laugerie-Basse in Dordogna. Tra le scoperte più recenti ed eclatanti un gruppo di 15 statuette ritrovate nel 2019 a Renancourt (presso Amiens) in un sito abitato tra i 28.000 e i 22.000 anni fa da un gruppo che si spostava seguendo le mandrie di cavalli, cervi e renne.
 Le Veneri costituiscono un enigma interpretativo che da sempre affascina gli studiosi. Immagini ideali, simboliche, di opulenza e femminilità o divinità della fertilità? La donna come madre (fecondità) o come portatrice di piacere (femminilità e sessualità): entrambe le interpretazioni sottintendono uno sguardo soprattutto maschile. L’ipotesi che si tratti di divinità ha forse accentuato l’invisibilità delle donne, viste soltanto in quanto motore della riproduzione della specie e della sopravvivenza a lungo termine. In certi casi è stato ipotizzato che si tratti di donne incinte e che le statuine che presentano fori per essere appese potessero avere la funzione di amuleti protettivi durante la fase difficile del parto. In ogni caso, non si tratta di rappresentazioni realistiche: dagli studi antropologici emerge che la donna preistorica, che conduceva una vita non sedentaria e aveva una dieta con molta carne magra (selvaggina), era generalmente magra e muscolosa, soprattutto nella parte superiore del corpo. Chi ha scolpito queste statuine, uomini o donne? Anche qui la ricerca di una risposta univoca potrebbe essere fuorviante. L’arte del Paleolitico, in particolare l’eccezionale arte parietale nelle grotte, è stata considerata per lungo tempo appannaggio esclusivamente maschile. L’unico dato certo è che le donne frequentavano le grotte tanto quanto gli uomini e lo dimostra un recente studio condotto da Dean Snow, professore di antropologia all’università della Pennsylvania che ha analizzato le impronte in negativo di mani presenti in otto grotte francesi e spagnole. Come è noto, sono state realizzate con lo stesso principio degli stencil, cioè soffiando il pigmento colorato intorno alle mani appoggiate sulla roccia: Snow, utilizzando l’indice di Manning (la proporzione tra lunghezza dell’indice e dell’anulare) ha provato che i tre quarti di quelle analizzate appartenevano a donne.
Le Veneri costituiscono un enigma interpretativo che da sempre affascina gli studiosi. Immagini ideali, simboliche, di opulenza e femminilità o divinità della fertilità? La donna come madre (fecondità) o come portatrice di piacere (femminilità e sessualità): entrambe le interpretazioni sottintendono uno sguardo soprattutto maschile. L’ipotesi che si tratti di divinità ha forse accentuato l’invisibilità delle donne, viste soltanto in quanto motore della riproduzione della specie e della sopravvivenza a lungo termine. In certi casi è stato ipotizzato che si tratti di donne incinte e che le statuine che presentano fori per essere appese potessero avere la funzione di amuleti protettivi durante la fase difficile del parto. In ogni caso, non si tratta di rappresentazioni realistiche: dagli studi antropologici emerge che la donna preistorica, che conduceva una vita non sedentaria e aveva una dieta con molta carne magra (selvaggina), era generalmente magra e muscolosa, soprattutto nella parte superiore del corpo. Chi ha scolpito queste statuine, uomini o donne? Anche qui la ricerca di una risposta univoca potrebbe essere fuorviante. L’arte del Paleolitico, in particolare l’eccezionale arte parietale nelle grotte, è stata considerata per lungo tempo appannaggio esclusivamente maschile. L’unico dato certo è che le donne frequentavano le grotte tanto quanto gli uomini e lo dimostra un recente studio condotto da Dean Snow, professore di antropologia all’università della Pennsylvania che ha analizzato le impronte in negativo di mani presenti in otto grotte francesi e spagnole. Come è noto, sono state realizzate con lo stesso principio degli stencil, cioè soffiando il pigmento colorato intorno alle mani appoggiate sulla roccia: Snow, utilizzando l’indice di Manning (la proporzione tra lunghezza dell’indice e dell’anulare) ha provato che i tre quarti di quelle analizzate appartenevano a donne.
 Patou-Mathis sostiene che nel Paleolitico forse non era nota la relazione tra l’atto sessuale e la procreazione e quest’ultima potesse quindi essere considerata soprannaturale. Gli autori di Lady Sapiens su questo punto divergono; un’evidenza della conoscenza dei vari stadi della riproduzione sarebbe indicata dalla rappresentazione, nel riparo sotto roccia di Roc-aux-Sorciers, nella Vienne, di tre figure femminili scolpite ad alto rilievo a grandezza quasi naturale e datate a circa 15.000 anni fa: mancanti di testa, piedi e braccia, potrebbero essere la raffigurazione di una donna incinta (evidente la rotondità del ventre), di una ragazzina e di una donna più anziana: le “tre età della vita”.
Patou-Mathis sostiene che nel Paleolitico forse non era nota la relazione tra l’atto sessuale e la procreazione e quest’ultima potesse quindi essere considerata soprannaturale. Gli autori di Lady Sapiens su questo punto divergono; un’evidenza della conoscenza dei vari stadi della riproduzione sarebbe indicata dalla rappresentazione, nel riparo sotto roccia di Roc-aux-Sorciers, nella Vienne, di tre figure femminili scolpite ad alto rilievo a grandezza quasi naturale e datate a circa 15.000 anni fa: mancanti di testa, piedi e braccia, potrebbero essere la raffigurazione di una donna incinta (evidente la rotondità del ventre), di una ragazzina e di una donna più anziana: le “tre età della vita”.
Le donne sapiens potevano procreare dai 13,5/14 anni ma è errato immaginarle circondate da numerosissimi figli. Una famiglia troppo numerosa non era facilmente gestibile da popolazioni non sedentarie, per cui è possibile che fossero già noti dei sistemi per evitare le gravidanze, nonché piante abortive come il dittamo. Gli studi sugli isotopi del calcio del latte materno (“misurabili” nello smalto dentale) hanno permesso di stabilire che presso gli australopitechi e gli Homo erectus la durata dell’allattamento dei cuccioli era piuttosto lunga, fino ai quattro anni; è possibile che tale situazione si sia mantenuta sino al Paleolitico superiore, anche perché l’allattamento prolungato è un sistema per diradare le nascite (di solito una donna mentre allatta non rimane incinta). Se le donne del Paleolitico potevano procreare sino ai trent’anni, ipotizzando un primo figlio intorno ai quattordici, si arriva a un massimo di cinque-sei figli per donna, ma è da tenere in conto l’alta mortalità infantile. Se superavano i primi anni di vita, gli uomini e le donne preistoriche avevano la possibilità di raggiungere quantomeno i 60 anni; è quindi plausibile l’esistenza di donne in menopausa che svolgevano l’importante funzione di aiutare i nipoti nella crescita e trasmettere loro saperi e conoscenze.
Gli studi archeologici permettono di illuminare altri aspetti. A esempio l’amore, femminile come maschile, per gioielli, ornamenti e abbigliamento: bracciali, cavigliere, collane, monili, copricapi, ciondoli in conchiglie, perle, canini di cervo (molti richiesti, importati da lontano, incisi e decorati), senza contare tutto quello che è andato perso o ha lasciato labili tracce nel record archeologico perché in materiale deperibile (fibre vegetali). Ma quando i nostri antenati si sono ritrovati senza pelliccia e hanno iniziato a vestirsi? Indirettamente ci aiutano i pidocchi: la differenziazione tra i pidocchi della testa e quelli del corpo risale, su base genetica, a 120.000 anni fa, ed è a quel punto che i pidocchi hanno iniziato a stabilizzarsi tra i capelli, probabilmente perché il resto del corpo umano era già coperto da vestiti. L’ago da cucito, in corno di renna o osso, è uno strumento che si differenzia molto nella forma a partire dai 40.000 anni fa, a indicare la crescente complessità dell’attività del cucito (pellicce, cuoio e tessuti in fibre vegetali). La confezione dei vestiti è un’attività nella quale possiamo immaginare fossero impegnate principalmente le donne, così come la scheggiatura della pietra era eseguita soprattutto dagli uomini, ma è improbabile che ci fosse una iper-specializzazione dei lavori, non funzionale in gruppi così ristretti.
L’altissimo artigianato era possibile anche perché verosimilmente gli antichi sapiens non erano costantemente occupati in attività lavorative necessarie e avevano tempo a disposizione per curare il “superfluo”. I Kung del deserto del Kalahari, in Namibia, sono impegnati nel procacciamento del cibo tra le 12 e le 19 ore alla settimana, tutto il resto del tempo è spendibile in attività come la produzione di eleganti oggetti di artigianato, le relazioni, le narrazioni intorno al fuoco. Molte attività, quindi, e non solo caccia; in realtà, nella preistoria il grosso dell’alimentazione dipendeva da animali di piccola taglia, dalla pesca di crostacei e piccoli pesci, dalla raccolta di semi e frutti (le donne raccoglitrici in questo senso erano davvero le “regine del mondo vegetale” ed è bene ricordare che la conoscenza delle piante fu fondamentale per la genesi dell’agricoltura nel Neolitico, cioè per la selezione delle specie da coltivare).
Lo studio della materialità è importante nel definire il ruolo della donna e le ideologie di genere, tanto più per la preistoria dove fonti documentarie di altro genere sono assenti; d’altra parte sono proprio quell’assenza e le molteplici possibilità di interpretazione che accentuano il rischio di sovrapporre il pensare contemporaneo alla ricostruzione del passato.
 La gender archaeology, nata negli anni ’80 in ambito anglofono sulla scia del movimento femminista, dapprima praticata solo da donne e con un focus sul femminile in tutte le sue sfaccettature, negli anni più recenti si è ampliata a un’indagine sulle relazioni di genere (un concetto non biologico ma culturale e sociale) nelle società del passato, focalizzandosi su alcuni ambiti quali le necropoli, la configurazione degli spazi nelle aree abitative, la divisione del lavoro. La gender a. si occupa di decostruire teorie e argomenti sessisti e critica l’androcentrismo delle letture archeologiche; i due libri considerati in fondo fanno esattamente questo. Non vi si accenna, però, a questioni terminologiche, oggi di grande attualità: si pensi ai dibattiti sul maschile e femminile nei nomi di professione o sull’utilizzo della schwa e dell’asterisco al posto del plurale maschile indifferenziato. Questioni che ad alcuni appaiono esclusivamente formali ma che derivano da una precisa storia culturale. Ci si potrebbe chiedere – è una provocazione – perché continuare a parlare di Homo sapiens (e vari Homo antenati) e non cercare invece un termine più inclusivo; per comodità, si dirà, ma la comodità in questo caso ha un prezzo. Nel racconto visivo dell’evoluzione umana (l’icona della scala evolutiva, già di per sé sbagliata perché veicola un’idea di progresso lineare) le donne sono sempre del tutto assenti.
La gender archaeology, nata negli anni ’80 in ambito anglofono sulla scia del movimento femminista, dapprima praticata solo da donne e con un focus sul femminile in tutte le sue sfaccettature, negli anni più recenti si è ampliata a un’indagine sulle relazioni di genere (un concetto non biologico ma culturale e sociale) nelle società del passato, focalizzandosi su alcuni ambiti quali le necropoli, la configurazione degli spazi nelle aree abitative, la divisione del lavoro. La gender a. si occupa di decostruire teorie e argomenti sessisti e critica l’androcentrismo delle letture archeologiche; i due libri considerati in fondo fanno esattamente questo. Non vi si accenna, però, a questioni terminologiche, oggi di grande attualità: si pensi ai dibattiti sul maschile e femminile nei nomi di professione o sull’utilizzo della schwa e dell’asterisco al posto del plurale maschile indifferenziato. Questioni che ad alcuni appaiono esclusivamente formali ma che derivano da una precisa storia culturale. Ci si potrebbe chiedere – è una provocazione – perché continuare a parlare di Homo sapiens (e vari Homo antenati) e non cercare invece un termine più inclusivo; per comodità, si dirà, ma la comodità in questo caso ha un prezzo. Nel racconto visivo dell’evoluzione umana (l’icona della scala evolutiva, già di per sé sbagliata perché veicola un’idea di progresso lineare) le donne sono sempre del tutto assenti.
E ancora, perché continuare a utilizzare il termine Venere per designare le statuette di donne? Se esse non rispecchiano, probabilmente, una visione sessista del corpo femminile, tuttavia il termine, quello sì, è stato dato da uomini e chiaramente deriva da stereotipi sessisti nonché culturali (Venere è un richiamo al mondo greco-romano). Nei primi anni del XIX secolo in Europa era ben nota la “Venere ottentotta”, una donna nata schiava in Africa australe, nella colonia olandese del capo di Buona Speranza, portata a Londra nel 1810; si chiamava Saartjie Baartman e aveva un fisico che destava stupore e ribrezzo, con cosce e sedere molto prosperosi e una ipertrofia degli attributi sessuali; divenne un fenomeno da baraccone e dopo la morte a Parigi nel 1815 fu sezionata e studiata da George Cuvier. Che il termine “Venere” nel XIX secolo porti con sé un certo retroterra (un forte richiamo al mondo sessuale e soprattutto alle fantasie erotiche maschili) è indicato anche dalla pubblicazione, 14 anni prima del ritrovamento della prima Venere, del romanzo erotico Venere in pelliccia, di Von Sacher-Masoch.
 Le trappole si celano non solo nei termini. Un rischio in cui si incorre è quello di piegare i dati archeologici a un femminismo stereotipato. Come ha ben spiegato bell hooks, il femminismo non è antagonismo nei confronti degli uomini e non può limitarsi a sostenere che le donne sono come gli uomini e devono poter fare gli stessi lavori. Le discussioni relative allo status di guerriere delle donne del passato, sulla base dei corredi funerari, rischiano di cadere in questo tranello. La guerra è stata a lungo considerata dagli uomini un’attività valorizzante; il vero femminismo non è dire “ecco, anche noi donne abbiamo partecipato a questa attività valorizzante” quanto piuttosto ribaltare il concetto di valorizzante, imposto dal sistema sessista del patriarcato. Il femminismo è una lotta contro questo sistema e deve emancipare gli uomini come le donne. Se l’orrore talvolta ha un genere, come ha scritto Lea Melandri, e la guerra è insita nei meccanismi di potere del patriarcato (come spiega benissimo Virginia Woolf in Le tre ghinee), non dovremmo essere fiere, di aver combattuto poco o per nulla? Di essere fuori, estranee a quel tipo di società? Un femminismo che si accontenta della parità di genere sul piano professionale e che non si interroga su questioni quali il rapporto tra lavoro e liberazione fa il gioco del predominio maschile. Quando studiamo le tracce materiali del passato probabilmente, come gli studiosi dell’Ottocento, trasliamo qualche nostro pregiudizio culturale sulle società antiche. Chiediamoci quale. Patriarcato e sessismo non hanno alcun fondamento biologico ma non bisogna costruire a tutti i costi il mito di una società ancestrale dove le donne erano libere o dominavano sulla sfera maschile. Raccontare la donna preistorica e il suo modo di vivere radicalmente diverso dal nostro può aiutare soprattutto a “trovare nuove parole e inventare nuovi metodi” (ancora Woolf in Le tre ghinee) alternativi al patriarcato e alle discriminazioni di genere, nella consapevolezza che la funzione dell’archeologia è qui e ora, per renderci felicemente coscienti di una pluralità di sguardi tra i quali quello maschile e sessista, per quanto troppo spesso ancora dominante, è solo uno dei tanti e prima o poi forse nessuno ne sentirà più il bisogno.
Le trappole si celano non solo nei termini. Un rischio in cui si incorre è quello di piegare i dati archeologici a un femminismo stereotipato. Come ha ben spiegato bell hooks, il femminismo non è antagonismo nei confronti degli uomini e non può limitarsi a sostenere che le donne sono come gli uomini e devono poter fare gli stessi lavori. Le discussioni relative allo status di guerriere delle donne del passato, sulla base dei corredi funerari, rischiano di cadere in questo tranello. La guerra è stata a lungo considerata dagli uomini un’attività valorizzante; il vero femminismo non è dire “ecco, anche noi donne abbiamo partecipato a questa attività valorizzante” quanto piuttosto ribaltare il concetto di valorizzante, imposto dal sistema sessista del patriarcato. Il femminismo è una lotta contro questo sistema e deve emancipare gli uomini come le donne. Se l’orrore talvolta ha un genere, come ha scritto Lea Melandri, e la guerra è insita nei meccanismi di potere del patriarcato (come spiega benissimo Virginia Woolf in Le tre ghinee), non dovremmo essere fiere, di aver combattuto poco o per nulla? Di essere fuori, estranee a quel tipo di società? Un femminismo che si accontenta della parità di genere sul piano professionale e che non si interroga su questioni quali il rapporto tra lavoro e liberazione fa il gioco del predominio maschile. Quando studiamo le tracce materiali del passato probabilmente, come gli studiosi dell’Ottocento, trasliamo qualche nostro pregiudizio culturale sulle società antiche. Chiediamoci quale. Patriarcato e sessismo non hanno alcun fondamento biologico ma non bisogna costruire a tutti i costi il mito di una società ancestrale dove le donne erano libere o dominavano sulla sfera maschile. Raccontare la donna preistorica e il suo modo di vivere radicalmente diverso dal nostro può aiutare soprattutto a “trovare nuove parole e inventare nuovi metodi” (ancora Woolf in Le tre ghinee) alternativi al patriarcato e alle discriminazioni di genere, nella consapevolezza che la funzione dell’archeologia è qui e ora, per renderci felicemente coscienti di una pluralità di sguardi tra i quali quello maschile e sessista, per quanto troppo spesso ancora dominante, è solo uno dei tanti e prima o poi forse nessuno ne sentirà più il bisogno.
Marylène Patou-Mathis, La preistoria è donna. Una storia dell’invisibilità delle donne, tr. Bérénice Capatti, Giunti, pp. 290, euro 20,00 stampa, euro 12,99 epub.
Thomas Cirotteau, Jennifer Kerner, Éric Pincas, Lady Sapiens. Come le donne inventarono il mondo, tr. Valeria Pascine, Piemme, pp. 222, euro 17,50 stampa, euro 9,99 epub.



