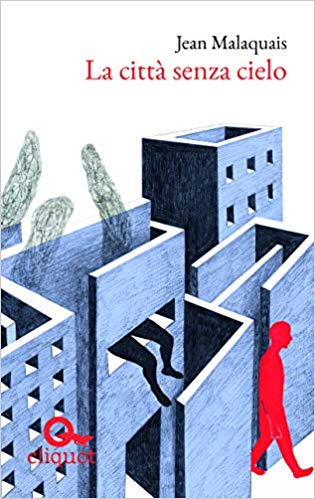La collana Biblioteca di Cliquot propone sempre titoli interessanti, alla riscoperta di classici fuori dalle rotte consuete. Oltre ai racconti di Fritz Leiber e le riedizioni di autori italiani come Stelio Mattioni e Livia De Stefani, spicca la nuova traduzione di un testo seminale del canone americano di Cesare Pavese, cioè Riso amaro di Sherwood Anderson. L’ultima proposta – che qui si recensisce – non è da meno: si tratta della prima edizione integrale di un romanzo distopico francese del 1953: Le Gaffeur. L’autore, Jean Malaquais (pseudonimo di Wladimir Malacki), era un ebreo polacco apolide che aveva lanciato la sua carriera letteraria tramite un sodalizio con André Gide e il cui esordio, I giavanesi, era stato insignito del premio Renaudot. La città senza cielo (questo l’adattamento italiano della traduzione di Garieri) è il suo ultimo romanzo prima dell’abbandono dell’attività letteraria. Nella versione di Cliquot è preceduto dalla prefazione di Norman Mailer all’edizione americana del 1974: Malaquais e Mailer si conoscevano perché il primo, nelle sue peregrinazioni, aveva vissuto anche a New York e aveva tradotto in francese l’esordio del secondo, ovvero Il nudo e il morto.
Il percorso biobibliografico di Malaquais è indubbiamente notevole e degno di una rispolverata: Le Gaffeur meritava sicuramente un’edizione integrale in italiano anche solo per colmare la lacuna di un romanzo in lingua francese derivato da 1984 e frutto di un autore slegato dalla produzione fantascientifica di massa. Eppure, a mio avviso, questo romanzo risente del peso degli anni e non riesce a soddisfare pienamente le aspettative create.
In breve, in una città del futuro (presumibilmente), descritta di sfuggita come un ammasso di parallelepipedi tutti identici, si dipana l’odissea di Pierre Javelin. Costui, un piazzista di prodotti cosmetici, dopo aver firmato in modo erroneo i documenti per un aumento salariale, si ritrova via via spogliato della propria vita, del suo ruolo nella società e della sua identità attraverso una serie di peripezie (la scomparsa della moglie, l’occupazione del proprio appartamento da parte di due personaggi surreali, l’interazione con vari altri personaggi della Città senza cielo), sempre rappresentate sotto una luce onirica venata di allegoria. Le modalità con cui questo avviene sono però difficilmente inquadrabili in una struttura coerente e la narrazione si distende a fatica nel monologo del protagonista. Il problema di questa sorta di pamphlet non sta tanto nella sua narrazione frammentaria (sembra quasi di trovarsi all’interno di un quadro cubista o metafisico) quanto nell’esito complessivo, soprattutto nelle caratterizzazioni dei personaggi, che risultano bidimensionali e inverosimili. Se ognuno di essi possiede un significato simbolico attribuito dall’autore all’interno della critica della tecnocrazia burocratica, difettano di troppe coordinate per risultare credibili, per quanto all’interno del gioco distopico. Ad esempio, le due figure diaboliche dei burocrati (Babitch e la signorina Limbert, superiore di Javelin presso l’Istituto nazionale per la bellezza e l’estetica) non sono in grado di suscitare quelle emozioni perturbanti che dovrebbero evocare. Perciò, anche l’eventuale critica sociale ne esce depotenziata né tanto meno riesce a toccare quei caratteri di universalità che raggiungono le fonti principali del romanzo di Malaquais (da Kafka a Orwell).
È paradossale, poi, come tutte le critiche fatte da Mailer dopo la sua prima lettura (smussate nella seconda parte della prefazione) risultino perlopiù corrette. Quello che alla rilettura di Mailer nel 1974 risultava come un motivo di rivalutazione dell’opera, cioè il carattere quasi profetico nella descrizione di una società totalitaria futura retta dalla burocrazia, oggi è meno rilevabile: la distopia di Malaquais rischia di apparire datata e ai nostri occhi riesce a risultare più angoscio qualsiasi episodio di The Twilight Zone, una serie di poco successiva a La città senza cielo.
Andando a ritroso, le due fonti principali dell’opera (Il processo di Kafka e 1984 di Orwell) sono due veri classici perché il gioco di sottrazione nella descrizione dell’universo narrativo risulta efficace e i pochi lampi offerti al lettore sono sufficienti a delineare un mondo coerente, mentre nel caso di Malaquais siamo davanti a un epigono che non gestisce pienamente il proprio materiale narrativo e le istanze relative. Se lo stile di Kafka od Orwell risulta misurato e cristallino, quello di Malaquais – con i suoi lunghi brani senza interruzione di paragrafo – rischia di sembrare troppo ampolloso e l’esperienza di lettura ne esce mortificata. In questo è incolpevole la traduzione di Garieri, la quale si impegna a restituire tutte le bizzarrie lessicali dell’autore. Un plauso quindi a Cliquot per le coraggiose scelte editoriali, ma La città senza cielo è, a mio avviso, una lettura immancabile solo per gli specialisti e gli appassionati.