Che il bombardamento di Dresda sia stato una grande tragedia nessuno può negarlo. Che fosse realmente una necessità militare pochi, dopo avere letto questo libro, lo crederanno. È stata una di quelle cose terribili che a volte accadono in tempo di guerra, causate da una sfortunata combinazione di circostanze. Coloro che l’approvarono non erano né malvagi né crudeli, ma può darsi benissimo che fossero troppo lontani dall’ amara realtà della guerra per comprendere pienamente il terrificante potere distruttivo dei bombardamenti aerei nella primavera del 1945. (Mattatoio n. 5, cap. 9)
I bombardamenti degli altri. Il bombardamento di Dresda non fa parte di questa categoria, non è uno dei bombardamenti degli altri. Il bombardamento di Dresda è roba nostra, è un crimine di guerra perpetrato dall’Occidente, una inutile strage che non aveva alcuna giustificazione, neanche da un punto di vista strettamente militare. I raid aerei degli Alleati, in 24 ore, con le loro bombe incendiarie, uccisero 250.000 persone e distrussero completamente la città di Dresda, la “Firenze dell’Elba”. Ah già, ma quelli erano nazisti…
Kurt Vonnegut, soldato statunitense fatto prigioniero dai tedeschi e rinchiuso in un mattatoio a Dresda nel febbraio 1945, sopravvisse al bombardamento e diventò uno scrittore, uno scrittore scomodo, dallo humor corrosivo, uno scrittore sempre dalla parte dei perdenti, dalla parte dei bombardati e non dalla parte di coloro che le bombe le sganciano. Il fatto di essere sopravvissuto al bombardamento di Dresda ha fatto di Kurt Vonnegut uno scrittore.
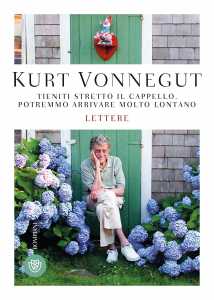
Kurt Vonnegut, Tieniti stretto il cappello. Potremmo arrivare molto lontano. Lettere, cura Vincenzo Mantovani e Dan Wakefield, tr. Andrea Asioli, Bompiani, pp. 555, euro 20,00 stampa, euro 12,99 epub
Questa nuova edizione Bompiani delle Lettere di Kurt Vonnegut raccoglie numerose lettere che Vonnegut scrisse nel corso della sua carriera letteraria a tutta una serie di amici, di agenti, di familiari, mettendosi a nudo come un essere umano fragile, ma sempre determinato a lottare per i perdenti, per gli sconfitti della storia. Sono lettere a volte amare, lettere dalle quali emerge una sorta di umorismo disperato, un umorismo che nasce dalle tante sconfitte subite, una sorta di humor nero. In una delle sue lettere Kurt ammette di essere stato influenzato da alcuni dei bravissimi comici che lavoravano alla radio negli Stati Uniti degli anni Cinquanta, e nelle sue battute sarcastiche troviamo spesso la stessa disperazione di fondo che caratterizzava l’umorismo di un altro grande della comicità americana: Lenny Bruce, uno dei pochi che riusciva a strappare il sorriso del pubblico anche quando parlava della guerra del Vietnam, della guerra nucleare e della distruzione totale dell’umanità.
Vonnegut dunque raccontava la realtà cruda così com’era, la realtà degli Stati Uniti profondi (era nato a Indianapolis, nello Stato dell’Indiana), e non sopportava quegli scrittori che passano la loro esistenza a rimirarsi l’ombelico, che non si impegnano per migliorare la società, che non si schierano mai con i perdenti e i bombardati. Scrive infatti in una delle sue lettere, a proposito degli scrittori: “continua pure a gingillarti mentre il mondo fa scorta di bombe all’idrogeno.”
È dura stare dalla parte dei perdenti, ma non c’è un’altra strada. Ecco dunque Vonnegut ricollegarsi a tutta quella tradizione di scrittori perduti e perdenti, sfigati, malati, drogati, separati, alcolizzati, che vivono sulla loro pelle le esperienze di cui scrivono, come Ernest Hemingway (che però Vonnegut rimproverava di non essere mai stato un soldato e di non aver mai ucciso un essere umano), come Raymond Carver, come Charles Bukowski, come il suo amico Richard Yates, come William T. Vollmann. Tutti gli scrittori che fanno parte di questa numerosa schiera possono dire come fa Bukowski: “Io, Charles Bukowski, lo scrittore, il fallito.” Vonnegut è estremamente consapevole di questo rischio continuo che corre lo scrittore, il rischio di fallire, anche economicamente, e infatti scrive: “Le persone che vogliono vivere di scrittura sono condannate al fallimento.”
 Le lettere degli anni Sessanta documentano la graduale affermazione di Vonnegut come scrittore di fantascienza, a partire da Le sirene di Titano (1959). Ma il libro che diede la notorietà vera a Vonnegut fu Mattatoio n. 5, pubblicato nel 1969. Questo libro, basato sulla sua esperienza di prigioniero a Dresda sotto le bombe, diventò un romanzo di culto, una delle letture preferite dei giovani contestatori degli anni Settanta, e sconvolse i confini convenzionali tra fantascienza e letteratura.
Le lettere degli anni Sessanta documentano la graduale affermazione di Vonnegut come scrittore di fantascienza, a partire da Le sirene di Titano (1959). Ma il libro che diede la notorietà vera a Vonnegut fu Mattatoio n. 5, pubblicato nel 1969. Questo libro, basato sulla sua esperienza di prigioniero a Dresda sotto le bombe, diventò un romanzo di culto, una delle letture preferite dei giovani contestatori degli anni Settanta, e sconvolse i confini convenzionali tra fantascienza e letteratura.
“Scoprii dai recensori di essere uno scrittore di fantascienza” scrive Vonnegut in una delle sue lettere. Il primo studio critico su Vonnegut fu The Fabulators, saggio che il critico Robert Scholes scrisse nel 1967 sull’opera di John Barth, John Hawkes, Iris Murdoch e Lawrence Durrell, oltre naturalmente a Vonnegut. Era il primo riconoscimento ed elogio che Kurt riceveva da un critico affermato, tranne forse un precedente saggio di Leslie Fiedler su “i nuovi mutanti” pubblicato sulla Partisan Review nel 1965. Proprio nel 1965, Vonnegut era andato a insegnare scrittura creativa all’Università dell’Iowa, dove era rimasto per un paio d’anni. Ma non poteva fare carriera accademica perché, a differenza di quasi tutti gli altri membri del corpo docente, non aveva una laurea. Provò a laurearsi in antropologia, con una tesi che metteva a confronto le narrazioni di società primitive e i racconti contemporanei, e nelle sue lettere si percepisce in continuazione questa prospettiva “antropologica” da cui giudica il comportamento folle dell’umanità, che continua ad autodistruggersi con le guerre e a inquinare il pianeta. Eppure, incredibilmente, la tesi in antropologia gli venne rifiutata. Quando poi divenne famoso, nel 1971, l’Università di Chicago gli conferì la laurea honoris causa per Ghiaccio-nove, un altro capolavoro.
La fama di Vonnegut e dei suoi libri continuò a ingrandirsi nel 1972, quando George Roy Hill trasse un eccellente film da Mattatoio n. 5. Kurt ne era entusiasta. Ma soprattutto in questo periodo Vonnegut viene ammesso nel sancta sanctorum dell’intellighenzia statunitense, la cerchia degli amici di George Plimpton, il leggendario fondatore ed editor della Paris Review, grande amico di Philip Roth, un punto di riferimento per tutti gli intellettuali di New York. Ma Vonnegut non è certo il tipo che si monta la testa, e scherzava con grande ironia sulla sua stessa notorietà: “Ora che ho conosciuto George Plimpton posso dire di aver raggiunto l’apice della mia carriera di animale mondano.” (Lettera a Sam Lawrence, 26 Febbraio 1971). La consacrazione definitiva avviene quando Kurt partecipa a una cena al ristorante Elaine’s a Manhattan, sull’Upper East Side, uno dei preferiti dall’intellighenzia newyorchese, con George Plimpton, l’artista Larry Rivers e altri (lettera a Jane Vonnegut, 7 Marzo 1971).
Ecco dunque che alla fine degli anni Sessanta, Kurt passò in un poco tempo dall’essere povero all’essere ricco e famoso. Mandò all’aria un matrimonio (con Jane Cox) che durava da quasi un quarto di secolo. La sua nuova compagna Jill Krementz, era una fotografa che lo aiutò a superare un momento difficile della sua esperienza di vita e della sua carriera professionale. Lo si evince da alcune delle lettere di questo periodo: “Jill è stata molto buona con me durante gli anni più devastanti della mia vita, e a devastarla non è stata lei. (…) tutto per me ha cominciato ad andare a pezzi molto prima che incontrassi Jill o arrivassi ai soldi e alla fama.” “Jill è stata molto brava ad aiutarmi a rimettermi in sesto. (…) Jill mi ha salvato dal suicidio e dal diventare un alcolizzato. Il matrimonio non l’ha rotto Jill, il matrimonio si è rotto molto tempo prima.” Vonnegut insieme alla Krementz vive alcuni anni di felicità, si trasferisce a Manhattan e successivamente compra addirittura una villa a Sagaponack, Long Island, diventando vicino di casa di alcuni suoi famosi amici scrittori.
Una sezione importante di questo volume documenta gli anni del successo e della consacrazione letteraria di Vonnegut. Eppure anche in questo periodo di consacrazione newyorchese Vonnegut continuò a collezionare stroncature. Per esempio il suo romanzo Slapstick (Comica finale) del 1976, fu massacrato dai recensori. A queste stroncature, che lo ferivano profondamente, reagiva sempre con l’arma dell’ironia: “Il mio romanzo ha ricevuto cattive recensioni solo sul New York Times, su Time, su Newsweek, sulla New York Review of Books, sul Village Voice e su Rolling Stone. Sono piaciuto molto a Medicine Hat.”
Eppure anche in quegli anni in cui viveva a Manhattan ed era ormai diventato uno scrittore famoso, la sua terribile esperienza di guerra continuava a tormentarlo: la depressione e l’abuso di alcool furono una presenza costante anche in questa fase della sua vita. Il 13 febbraio 1984, 39° anniversario del bombardamento di Dresda, Kurt fu ricoverato in ospedale per un’overdose di sonniferi e alcool. Non c’è niente da fare, l’esperienza della guerra non ti lascia mai… In seguito in alcune lettere ai familiari e nelle sue opere, Kurt descrisse se stesso come un “depresso unipolare discendente da depressi unipolari” (Cronosisma). Successivamente, si romperà anche il rapporto con la seconda moglie Jill, ormai stufa del suo caratteraccio e delle sue continue sbronze. In una lettera del dicembre 1999 alla figlia Nanny, Kurt confessa il deterioramento dei rapporti con la seconda moglie dopo l‘ennesimo incidente domestico, una brutta caduta dovuta all’abuso di alcool: “Io e Jill non ci parliamo più, grazie al cielo, e io sono in via di guarigione…”
Il nuovo millennio comincia male per lo scrittore. Nel gennaio 2000 Kurt, probabilmente ubriaco, rovescia un portacenere in casa scatenando un incendio. Viene subito portato all’ospedale, dove gli viene diagnosticata una grave intossicazione da fumo, ma dopo cinque giorni si riprende.
Queste lettere contengono anche alcuni sferzanti i commenti su alcuni mostri sacri della letteratura del Novecento: “Non esiste proprio che la sensibilità delle classi alte, per quanto sapientemente espresse, possano smuovermi qualcosa dentro. È una faccenda politica. Esempio: T.S. Eliot. Che vada a farsi fottere. Tutti sanno che è di St Louis – tutti tranne lui. “E ancora: “Perché non è stato cancellato dalla faccia della terra a suon di risate, quando ha deciso di tramutarsi magicamente in un inglese?” Commenti quantomeno ingenerosi, se si considera che sono rivolti a uno dei più grandi poeti del Novecento, se non il più grande. Altri giudizi impietosi Vonnegut li riserva ad alcuni dei più famosi scrittori americani, da sempre consacrati dalla critica accademica: “Confesso di non riuscire a leggere Henry James.” Troppo distanti da lui, questi scrittori laureati, da lui che non si era mai laureato ma si era creato la sua cultura da solo, leggendo e imparando dalla vita. In altre lettere Kurt si lamenta del “generismo”: la convinzione che chiunque scriva di fantascienza non sia realmente uno scrittore, ma piuttosto un freak, fenomeno da baraccone. Quando Kurt incontrò il grande scrittore di fantascienza Theodore Sturgeon nel 1958, “egli era smunto ed emaciato, sottopagato e non apprezzato al di fuori di quel ghetto che era allora la fantascienza.” Ecco come si riducono gli scrittori di fantascienza.
Nell’ultimo periodo della sua carriera scrive alcune brevi riflessioni raccolte in Un uomo senza patria (2005), un’opera che presenta una lucida analisi e alcuni sferzanti commenti sulla guerra (all’Iraq), sull’avidità umana e sulla distruzione del pianeta. Stranamente, nelle Lettere scritte dopo il settembre 2001 non c’è neanche un accenno agli attentati dell’11 Settembre, un argomento di cui Vonnegut si è occupato in quegli anni soltanto di sfuggita, soltanto in un’intervista con Christopher Kemp in cui Vonnegut paragona le esplosioni al World Trade Center all’eruzione del Vesuvio. In questa intervista lo scrittore di Indianapolis sembra voler ridimensionare la portata degli eventi relativi all’attacco alle Twin Towers e non aver compreso la gravità di quanto era accaduto. Evidentemente la salute precaria dello scrittore all’epoca non gli consentì di esprimere in modo esauriente le sue riflessioni su questa nuova manifestazione della follia umana, su questo nuovo tipo di guerra asimmetrica, che sicuramente sarebbero state molto interessanti.
In una delle sue ultime lettere, Vonnegut esprime un concetto che sembra contenere una terribile profezia per il nostro tempo: “…in tutta la storia un solo paese è stato abbastanza pazzo da far detonare delle armi atomiche in mezzo alla popolazione civile, trasformando uomini, donne e bambini disarmati in fuliggine e farina d’ossa radioattive. E ormai è successo tanto, tanto tanto tempo fa”. Eppure, alla luce degli eventi che stiamo vivendo in questi giorni – la sanguinosa Guerra in Ucraina – potrebbe succedere di nuovo.
Nel suo ultimo consiglio scritto per essere rivolto ad un pubblico, Kurt Vonnegut scrisse: “…come dovremmo comportarci durante l’Apocalisse? Dovremmo essere straordinariamente gentili gli uni con gli altri, certo. Ma dovremmo anche finirla di essere tanto seri. Le barzellette sono un grande aiuto. E trovatevi un cane, se non l’avete già. Io vado.”
E noi? Ce la facciamo a scherzare con l’Apocalisse? A raccontare barzellette mentre piovono le bombe, come fecero Vonnegut e gli altri suoi sodali prigionieri durante il bombardamento di Dresda?
Di lì a qualche tempo, Vonnegut se ne andò veramente. Nel 2007 ci fu una nuova brutta caduta dai gradini della sua casa di Manhattan. Morì in ospedale l’11 Aprile 2007.



