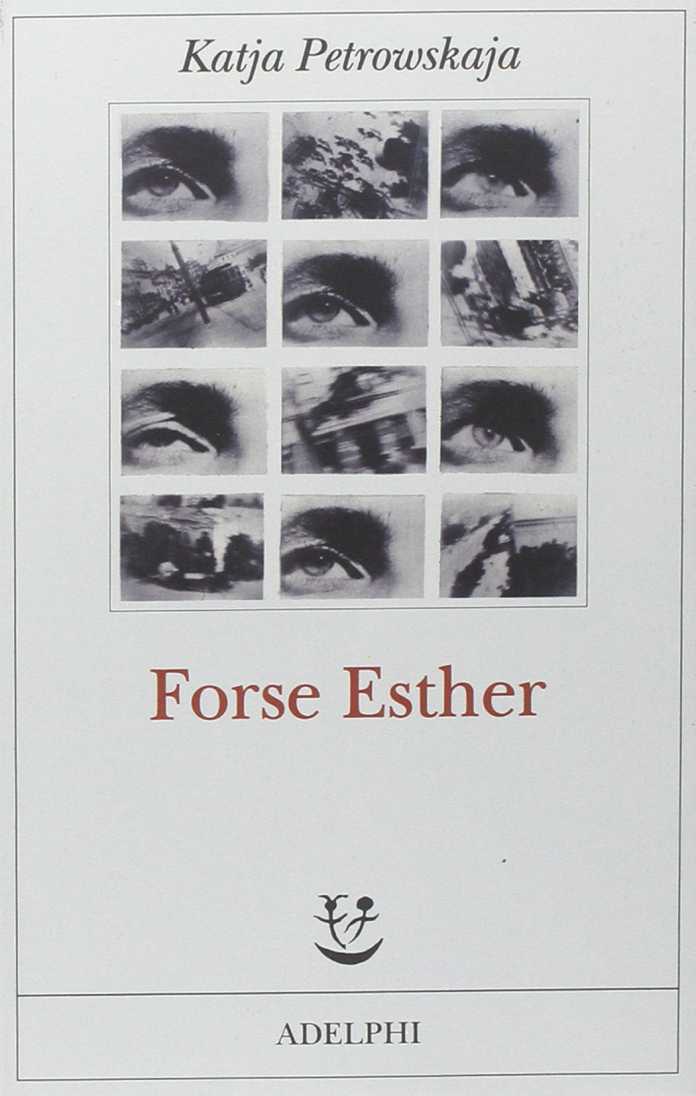Primo e finora unico romanzo pubblicato dall’autrice – nata a Kiev nel 1970, Katja Petrowskaja vive da tempo a Berlino, dove collabora con diverse testate giornalistiche russe e tedesche – Forse Esther (Premio Bachmann 2013, Premio Strega Europeo 2015) è la testimonianza di un profondo lavoro di scavo alla ricerca delle proprie radici. L’impresa, già di per sé complessa per una scrittrice di origine ebraica cresciuta nella Kiev sovietica degli anni Settanta, risulta ancora più ardua per la scelta di Petrowskaja di utilizzare “la lingua del nemico”, quel tedesco imparato “a proprio rischio e pericolo”, come ebbe a dire lei stessa in occasione di un’intervista. Petrowskaja si impone così un confronto continuo con la parlata d’adozione, confronto che si rivela però fruttuoso, come si legge in un passaggio contenuto nelle pagine iniziali del romanzo: “Pensavo in russo, cercavo i miei parenti jiddish e scrivevo in tedesco. Avevo la fortuna di potermi muovere nelle crepe della lingua, nello scambio e nella variazione continua dei ruoli e dei punti di vista”.
Il romanzo mostra in effetti i segni di queste crepe e di questi scambi continui, non solo per i termini stranieri (oltre che tedeschi, inglesi e russi) che costellano il testo, quanto per la natura stessa dell’opera, per la quale la scrittrice rinuncia a una precisione documentaria – peraltro impossibile – a favore di una narrazione composita, in una alternanza di toni (dal serio all’ironico, dal visionario al lirico-affettivo) che riproduce, formalmente, la complessità di una ricerca che deve affidarsi ai materiali più svariati, quando “non ci sono più persone alle quali poter domandare, ma solo fonti”. Tentando di ricostruire una genealogia famigliare, l’autrice è dunque costretta a interrogare queste fonti disperse e confuse, e lo fa con l’eclettismo tipico dell’individuo contemporaneo: alla ricerca in archivio si affianca così quella su internet; alle fotografie ingiallite dei parenti scomparsi (incastonate nel testo alla maniera di Sebald), le foto di profili Facebook scovati per caso; a una ricetta in russo scritta a mano da una zia deceduta da tempo, le mail spedite all’altro capo del mondo, in America, sempre con quello stesso obiettivo di trovare nuove fonti da interrogare, nuove informazioni, nuove crepe da cui poter sbirciare un passato di cui si crede di sapere tutto, ma che resta per lo più nascosto alla vista.
Ne risulta una forma originale di epica moderna in cui Petrowskaja non loda più le muse né Dio, ma Google, in cui non ci sono più eroi ma persone comuni, e nondimeno pur sempre eroiche. È questo il caso, per fare un solo esempio, della Esther che dà il titolo al romanzo, o meglio della “Forse Esther”, visto che il padre dell’autrice, che l’ha sempre chiamata semplicemente babuška, non ricorda quale fosse il suo vero nome. Ebrea come tutta la famiglia, “Forse Esther”, che per l’età non è quasi più in grado di camminare, avrebbe occasione di scampare al massacro di Babji Jar, non fosse per un senso del dovere che sfiora l’assurdo e che la costringe a obbedire al comando che le è stato imposto. Muore così fucilata con noncuranza da una coppia di ufficiali tedeschi a cui aveva domandato la strada per raggiungere la forra: anche questa, a suo modo, una forma di eroismo.
La storia di Forse Esther è tuttavia soltanto una delle molte che infondono al testo respiro epico. Non a caso il sottotitolo del romanzo, andato perduto nella traduzione italiana, recita Geschichten, al plurale, quasi ad avvertire il lettore che qui non si parla di Storia ma di storie, e quindi anche, implicitamente, di letteratura. Come si legge in un altro passo del romanzo, posto a chiosa del capitolo dedicato alla bisnonna: “Osservo questa scena, come fossi Dio, dalla finestra della casa dirimpetto. Forse si scrivono così i romanzi. Oppure anche le fiabe. Siedo in alto, e vedo tutto!”. Eppure basta un giro di frase perché l’apparente euforia venga mitigata da quest’altra affermazione, di tenore opposto: “A volte mi faccio coraggio e mi avvicino e mi metto alle spalle dell’ufficiale, per ascoltare di nascosto la conversazione. Ma perché mi voltano le spalle? Giro loro attorno, e ne vedo solo le spalle […] Non vedo i volti, non capisco, e i libri di storia tacciono”.
Proprio l’obbligato ricorso alla fantasia per colmare quei buchi (di nuovo, quelle crepe) lasciati aperti dalla storia, la stessa possibilità di immaginare che la congettura per sua stessa natura concede, è reso punto di forza del romanzo. Già a partire dal titolo, Petrowskaja non nasconde le lacune della sua ricerca, ne fa anzi uno dei temi principali della narrazione. In questo modo la testimonianza si fa letteratura capace di coinvolgere il lettore per l’umanità che la contraddistingue, per il suo incerto destreggiarsi tra memoria collettiva e memoria privata. Così, se la prima conduce nei luoghi più impregnati di storia di quella che una volta si era soliti definire Mitteleuropa (da Berlino a Kiev, ad Auschwitz, a Mauthausen, a Babji Jar), alla seconda dobbiamo le pagine più memorabili del romanzo, quelle dedicate ai ritratti degli altri membri della famiglia: la zia Lida, la babuška Rosa, il nonno fatto prigioniero e tornato dai gulag dopo quarant’anni, l’“essere fantomatico” Judas Stern, processato nel 1932 in seguito al tentato omicidio di un diplomatico tedesco. È un modo, per Petrowskaja, di confrontarsi con un ebraismo rimosso a forza dall’assimilazione, principio cardine e vera e propria condicio sine qua non del mondo globalizzato. Per il lettore, di rivivere alcune delle tappe più tragiche e salienti del Novecento da un’angolatura privata che non fa però fatica a percepire come propria.