Inumana appare la terra dei soviet a Józef Czapski nel breve periodo (1941-1942) in cui “a caldo sul posto” (p. 13) prende i suoi appunti. Quanti anni sono trascorsi dall’Ottobre?
“Avevo dimenticato quanto fosse cambiata nel frattempo la situazione. Nel 1918 non esisteva ancora l’attuale legislazione sovietica, che avrebbe portato la gente a perdere la libertà di movimento persino all’interno del proprio paese – un paese dove gli alti funzionari si sorvegliano a vicenda, dove gli stranieri, inclusi i comunisti, sono sottoposti a un controllo attento, costante, e dove passare la frontiera illegalmente è un crimine per il quale centinaia di miei conoscenti in fuga dall’occupazione nazista son stati puniti con pene da tre a otto anni di carcere” (p. 160).
Dove sono finiti le “molte personalità eminenti e originali” di allora e quel “linguaggio comune” che rendeva possibile il “rapporto umano” tra diversi? (p. 160) Com’è potuto accadere che dopo appena un quarto di secolo di quegli anni non ci sia più traccia?
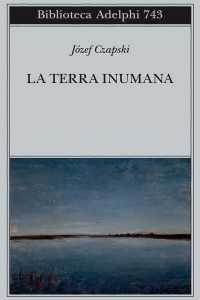 È per esperienza diretta che Czapski ne parla. Tra il 1941 e il 1942, dopo ventitré mesi dietro un filo spinato, ha attraversato in lungo e in largo la Russia sovietica viaggiando in treno e incrociando a ogni passo “migliaia di volti chiusi in se stessi o addirittura ostili” (p. 181), letteralmente una fauna umana ben impacchettata in vagoni selezionati gerarchicamente che tanto ci ricordano quelli della saga di Snowpiercer, il treno del Signor Wilford, qui la “volontà brutale e sistematica” (p. 181) del compagno Stalin. Certo, “il chiamarsi tovarišc funziona ancora bene e crea una sorta di cortina fumogena che impedisce di vedere chiaramente le profonde diseguaglianze sociali presenti in Unione sovietica” (p. 185). Ma tant’è. Tutti tovarišc: quelli che viaggiano in prima classe col posto assegnato, quelli di seconda classe che il posto devono cercarselo e quelli di terza classe che il posto proprio non ce l’hanno. Per non parlare della qualità del servizio offerto nei tre casi.
È per esperienza diretta che Czapski ne parla. Tra il 1941 e il 1942, dopo ventitré mesi dietro un filo spinato, ha attraversato in lungo e in largo la Russia sovietica viaggiando in treno e incrociando a ogni passo “migliaia di volti chiusi in se stessi o addirittura ostili” (p. 181), letteralmente una fauna umana ben impacchettata in vagoni selezionati gerarchicamente che tanto ci ricordano quelli della saga di Snowpiercer, il treno del Signor Wilford, qui la “volontà brutale e sistematica” (p. 181) del compagno Stalin. Certo, “il chiamarsi tovarišc funziona ancora bene e crea una sorta di cortina fumogena che impedisce di vedere chiaramente le profonde diseguaglianze sociali presenti in Unione sovietica” (p. 185). Ma tant’è. Tutti tovarišc: quelli che viaggiano in prima classe col posto assegnato, quelli di seconda classe che il posto devono cercarselo e quelli di terza classe che il posto proprio non ce l’hanno. Per non parlare della qualità del servizio offerto nei tre casi.
È questo continuo scendere e salire di stazione in stazione da un treno all’altro che ha permesso a Czapski di abitare ogni volta uno scompartimento e osservarne i viaggiatori. Qua un agente del NKVD e la direttrice di una fabbrica di cioccolato, là “un povero soldatino con un cappotto lacero e un braccio fasciato” (p. 188) oppure “un giovane dal volto concentrato, occhiali «americani» con la montatura spessa e mani delicate” (p. 191); e il vecchio attivista di partito diretto “a una delle linee ferroviarie oltre gli Urali per eseguire una purga di elementi sospetti” (p. 196). Ma Czapski ha conosciuto le ferrovie russe prima della rivoluzione. Per questo è in grado di cogliere l’enorme differenza tra questi russi “e i russi di allora, quando in ogni vicolo, in ogni stazione, in ogni locanda o vagone di treno si potevano incontrare persone, fossero intellettuali o analfabeti, che si interrogavano su tutto, comprese le questioni ultime” (p. 191). Ancora nel ’18 “la rivoluzione era un uragano scatenato, mentre oggi bastava guardare le facce della gente sui treni, nelle stazioni, per strada, le bandiere sovietiche appese ovunque, sporche, sbiadite, non più rosse ma violacee, per capire che in Russia la magia rivoluzionaria era svanita da tempo, proprio come il colore di quelle bandiere” (p. 154).
Perché la gente e non la storia? Perché solo questa – si pensa – avrebbe potuto spiegare a Czapski quello che era accaduto nel lasso di tempo che lo separava da quell’anno, le cause endogene ed esogene della grande trasformazione. E poco importa che questa idea del presente come storia sia relativamente recente. Se poi lui alla storia ha preferito le facce della gente, i gesti, le parole, i silenzi della gente, mal gliene incolse perché al più – e qui riconosciamo subito il monito edificante di certa sinistra – è di un diario di bordo che si tratta, solo di un diario di bordo. Ma Czapski con la sua scelta ha aperto una strada che altri percorreranno in momenti altrettanto drammatici della storia russa[1].
Di necessità La terra inumana è anche un libro di incontri. Fortuiti e non. Intanto con polacchi di tutte le età dopo che l’amnistia del ’41 aveva dato la stura a prigioni e campi di internamento dove nel ’39 erano stati rinchiusi 230.000 soldati dell’armata polacca in rotta. Czapski, appena liberato dal campo di Grjazovec, ne incontra a centinaia in qualità di coordinatore dell’Ufficio assistenza di Tockoe. Il primo incontro è con corpi disfatti, volti scheletriti, sguardi spenti, appena coperti da stracci e giacconi logori, a fiumi nelle stazioni in attesa di un treno che non arriva, per partire non si sa per dove. Czapski interroga questi corpi, li fa parlare e li ascolta. Noi grazie a lui torniamo oggi ad ascoltarli. Come non prestare loro fede? Come non pensare che quel “Ricordati di noi!” (p. 121) che Kotynia rivolge al tenente Sołczyński ci riguardi?
Appena un anno prima, sotto la minaccia di venire consegnato ai nazisti, Benjamin ci metteva in guardia dal voler conoscere il passato “proprio come è stato davvero”. Piuttosto, per articolarlo al meglio dovremmo trattenerne, scriveva, “un’immagine nel modo in cui s’impone imprevista nell’attimo del pericolo”[2]. È esattamente quello che ha fatto per noi Czapski dando la parola a quegli uomini e a quelle donne.
Ci sono anche incontri non fortuiti, costruiti a fatica come responsabile della ricerca dei prigionieri di guerra dispersi, circa quindicimila uomini tra ufficiali e soldati. Ad esempio con il generale Nasedkin, “padrone della vita e della morte di qualcosa come venti milioni di persone” (pp. 127-128) e con il comandante del distretto di Čkalov, Bzyrin, due burocrati delle galere e dei campi, due criminali ben pasciuti abituati a trattare le loro vittime come animali da macello. Oppure quello con Ėrenburg, allora il giornalista più famoso di Radio Mosca, a proprio agio nella “luminosa, lussuosa stanza in uno dei sedici piani dell’hotel Moskva” (p. 165) e anche letterato di successo, che non sarebbe stato quello che era se non avesse sempre girato la testa dall’altra parte.
Un abisso li separa dai reduci dei gulag. Continuare a chiamarli ancora vittime, a pensarle finanche come le loro vittime, sarebbe però un errore. «Vittima» vale per la vita nei gulag dove è più difficile per un corpo smunto messo al lavoro progettarsi diverso da ciò che è. Fuori dal campo è più facile e l’amnistia (dopo l’invasione tedesca e la conseguente rottura del patto Molotov-Ribbentrop) in questo senso ha dato una mano. Le vittime polacche dei gulag hanno rotto con l’identità di vittima nel momento in cui, piene di entusiasmo, si sono proposte di raggiungere il neonato esercito polacco. Usciti dai campi e in odio dei campi è da questo amor patrio che hanno attinto la forza di non essere più le vittime di Berija e di Stalin.
Czapski vede queste cose, lo storico che dice di attenersi solo ai fatti e non ascolta la gente, no. Lui è interessato al numero dei campi di prigionia russi, al luogo della loro dislocazione (la Siberia, preferibilmente), alla quantità di prigionieri che questi campi hanno ospitato e per quanto tempo, al numero dei morti e a quello dei sopravvissuti, etc. etc. Sì, lo storico dei campi di sterminio nazisti si muove allo stesso modo cosicché alla fine agli occhi di chi li legge lager e gulag pari sono.
Cosa è inaccettabile in questo procedimento storico? La visione etica che lo sostiene, l’idea cioè che tutto debba ruotare attorno alla vittima[3]. Ne sa qualcosa il lettore di Šalamov (forse meno quello di Solženicyn). Legge I racconti di Kolyma e, sua sponte, comincia a solidarizzare con la vittima, quel freddo e quella fame se li sente addosso anche lui e sue sono anche le emozioni buone e cattive che quello prova. Semplice empatia? È indubbio che senza l’indicibile sofferenza della vittima difficilmente sarebbe scattato questo co-sentire automatico e irriflesso. Una pietas che ovviamente non prova l’aguzzino verso il quale il lettore si erge a giudice.
Provo a immaginarmi il lettore de La terra inumana tra i giurati in un processo accusatorio all’americana, intento a valutare la fondatezza delle prove raccolte dall’accusa, il nostro storico. Sul banco dei testimoni Józeƒ Czapski, che l’accusa ha convocato a proprio carico. Su quello degli imputati, il Male ovvero il Comunismo, ovvero il ’17 bolscevico da cui tutto sarebbe partito: l’orrore delle sevizie, dei maltrattamenti, delle torture, delle carestie, delle persecuzioni, delle migrazioni forzate. Un incubo, si badi, che è stato reale, una sofferenza che era dei più, che si vedeva, che il testimone Czapski ha visto e che noi, grazie a lui, possiamo tornare a vedere. Noi, cioè i giurati, cioè l’opinione pubblica[4]. Su questa evidenza l’accusa costruisce la sua arringa e fonda la forza di convinzione delle sue conclusioni. Se non bastasse, per avvalorare la tesi della rivoluzione di Lenin e del comunismo come il Male assoluto, avrebbe dalla sua anche il numero dei morti accertati e di quelli che – forse vivi forse morti – mancano all’appello. Che Czapski non lesina.
Ma non vogliamo dimenticare l’avvocato della difesa. Non ha prove a contrario da mostrare ai giurati e neppure è interessato a smentire quelle avanzate dall’accusa. In nome di che, poi? Della Rivoluzione? Solo che non gli va, semplicemente trova inaccettabile, la visione etica che in questo processo ha abbagliato un po’ tutti. D-i-s-u-m-a-n-o è proprio quel partire dalle vittime, r-i-p-u-g-n-a-n-t-e è pensare che il “Male è ciò a partire da cui si dispone il Bene”[5], perché la “prosopopea della vittima rafforza i potenti e indebolisce i subalterni. Svuota l’agency. Perpetua il dolore. Coltiva il risentimento. Alimenta identità rigide e spesso fittizie. Inchioda al passato e ipoteca il futuro. Scoraggia la trasformazione…”[6]
Lo vogliamo di dura cervice, il nostro avvocato e bastian contrario. Tipo: Cari giurati, parto dal Bene, cioè dall’indignazione degli ultimi che poi sono sempre gli sfruttati e dalla loro rivolta che è sempre giusta. Penso il Male a partire da questo Bene. E il Male è questa realtà, perfettamente visibile, dello scatenamento degli egoismi, della scomparsa delle politiche di emancipazione, della moltiplicazione delle violenze «etniche» e dell’universalità della concorrenza selvaggia. Šalamov ci ha mostrato che nei gulag carnefici e burocrati hanno potuto fare quello che hanno fatto perché le vittime glielo hanno permesso. Le vittime non hanno compiuto quello sforzo inaudito che solo rompe con l’identità della vittima, non hanno osato lo sguardo che sfida quello del boia e la parola che si nega all’obbedienza. Gesti, questi, umani troppo umani che dicono di una resistenza incomprensibile per le condizioni del gulag e però disarmante. Ciò che fa della vittima una bestia ben più resistente dei cavalli, non è il suo corpo fragile, ma la sua ostinazione a restare ciò che egli è, cioè, precisamente, qualcos’altro che una vittima, qualcos’altro che un essere-per-la morte[7].
Ma torniamo alla Rivoluzione. Czapski non ce la fa desiderare. Non solo quella d’Ottobre, troppo presto trasformatasi in tragedia, ma anche di riflesso tutte le altre che nel Novecento l’hanno seguita. Indigeribile resta la figura della vittima, non a caso la sola a svelare il lato oscuro delle rivoluzioni vittoriose del secolo. Quante sono state? Vagonate, a leggere Il libro nero del comunismo[8]. Ma “questa macabra aritmetica della morte”[9] non ci porta da nessuna parte. Semplicemente bisogna volgere lo sguardo altrove, pensare la rivolta finalmente matura, emancipata dallo stato di minorità in cui il pensiero della rivoluzione per troppo tempo l’ha cacciata.
È forse il caso di pensarla al sicuro dalle rivoluzioni perché spesso sono state proprio le rivoluzioni a distruggerne – come ci ricorda Toni Negri – il potere ontologico, annichilendone così il potenziale liberatore[10].
[1] S. Aleksievič, Ragazzi di zinco, edizioni e/o, Roma 2003; Tempo di seconda mano, Bompiani, Milano 2014.
[2] W. Benjamin, Sul concetto di storia VI, Einaudi editore, Torino 1997, p. 27.
[3] Convincenti in proposito ci sembrano le considerazioni di A. Badiou in L’etica. Saggio sulla coscienza del male, Nuova Pratiche Editrice, Parma 1994, § I.
[4] Ivi p. 13: “nome decisamente paradossale, [questo di] «opinione pubblica»”.
[5] Ibidem.
[6] D. Giglioli, Critica della vittima, nottetempo, Roma 2014, p. 107.
[7] Ivi, p. 15 liberamente chiosata.
[8] S. Courtois, N. Werth, J-L. Panné, A. Paczkowski, K. Bartosek, J-L. MargolinIl libro nero del comunismo, Mondadori Editore, Milano 2000.
[9] M. Revelli, Oltre il Novecento, Einaudi editore, Torino 2001, p. 229.
[10] T. Negri, L’évènement soulèvement, in Soulèvements, a cura di G. Didi-Huberman, Gallimard/Jeu de Paume, Paris 2019, p. 43.



