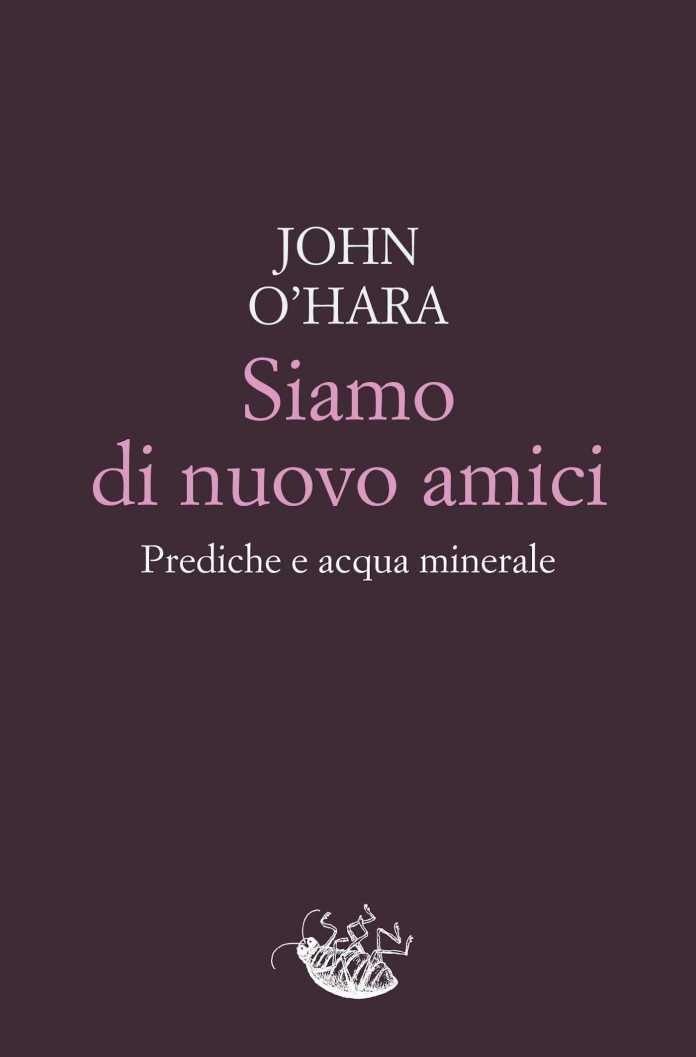John O’Hara (Pennsylvania 1905 – New Jersey 1970), scrittore d’eccellenza del New Yorker dal 1928, ma vilipeso e disprezzato per un caratteraccio poco raccomandabile, e forse per le sue opere le cui tirature da bestseller suscitavano invidie a manciate. Si sa l’invidia, ma i suoi atteggiamenti da furfante non gli impedivano di scrivere ritratti formidabili dell’America degli “anni ruggenti”, al pari e forse più di autori che rispondono al nome – fra altri – di Francis Scott Fitzgerald. Certo, O’Hara poteva essere simpatico a Mr Hemingway, ma non poteva scampare a quella critica che lo riteneva, oltre che insopportabile, fautore di vedute conservatrici seminate a manciate nelle rubriche firmate su riviste degli anni Cinquanta e Sessanta.
Il realismo americano passa nei suoi racconti, più di quattrocento, tre quarti dei quali pubblicati dal New Yorker in oltre quarant’anni. Si vantava di riuscire a scrivere una storia nuova di zecca nel giro di un paio d’ore. Le sue sceneggiature, in quel di Hollywood, andavano per la maggiore, come non ricordare certi film come Venere in visone (tratto da BUtterfield 8, romanzo del 1935) che fruttò a Elizabeth Taylor l’Oscar, e qualche pettegolezzo in più scaturito da una pellicola passata per reazionaria ma con suggestiva fotografia Cinemascope. Senza contare il grandissimo successo del 1958 di From the Terrace (Dalla terrazza), milioni di copie vendute grazie (ma non soltanto) al film omonimo interpretato da Paul Newman. Anche Broadway lo corteggiò allestendo una versione teatrale del romanzo Pal Joey, interpretata da Gene Kelley: musical magistrale portato in seguito sugli schermi dalla Columbia Pictures e consacrato, pur nello sdolcinato adattamento, da star seduttive come Frank Sinatra, Rita Hayworth e Kim Novak.
Le raffinatezze di O’Hara, e i sapori canaglieschi di personaggio e scritti, non gli portarono riconoscimenti, tranne qualche critica favorevole dai pochi che riuscivano a collocare nel giusto modo le sue storie. Amante delle risse, certo, probabilmente non il solo all’epoca a dotarsi di queste incantevoli maniere, ma anche amante dei quattrini quando pretendeva il compenso, e non le chiacchiere, se la pubblicazione decadeva. Senza contare le reazioni di fronte a recensioni negative, soprattutto dedicate ai romanzi. L’epitaffio, da lui stesso dettato, recita: “Meglio di chiunque altro disse la verità sul suo tempo”. Possibile fratello maggiore di Truman Capote? Forse.
 Notizie e aneddoti possono ritrovarsi nelle amabili note di Stefano Friani e Vincenzo Mantovani (magnifico traduttore) che accompagnano La ragazza nel portabagagli, primo racconto della trilogia Prediche e acqua minerale (Sermons and Soda-Water) pubblicata in tre volumetti da Racconti Edizioni e giunta alla conclusione con questo Siamo di nuovo amici. Meritoria attenzione editoriale verso storie di qualità clamorosa che striglia alcuni gusti alquanto comatosi. Ma le eccezioni, fra sapori e stagionature un po’ perverse, ci sono. Ricordiamo l’inserimento di un romanzo del 1934, Appointment in Samarra, nel proprio Canone occidentale da parte di un altro caratteraccio eccelso, il critico Harold Bloom.
Notizie e aneddoti possono ritrovarsi nelle amabili note di Stefano Friani e Vincenzo Mantovani (magnifico traduttore) che accompagnano La ragazza nel portabagagli, primo racconto della trilogia Prediche e acqua minerale (Sermons and Soda-Water) pubblicata in tre volumetti da Racconti Edizioni e giunta alla conclusione con questo Siamo di nuovo amici. Meritoria attenzione editoriale verso storie di qualità clamorosa che striglia alcuni gusti alquanto comatosi. Ma le eccezioni, fra sapori e stagionature un po’ perverse, ci sono. Ricordiamo l’inserimento di un romanzo del 1934, Appointment in Samarra, nel proprio Canone occidentale da parte di un altro caratteraccio eccelso, il critico Harold Bloom.
 Le storie di O’Hara contengono esemplari di fauna umana d’ogni genere, vi si annusano mirabilia e un profluvio di dettagli riguardanti fanciulle estroverse e etiliche, poco di buono e brutti ceffi legati ai commerci loschi avvolti di paillettes e euforiche gelatine cinematografiche, dive sul viale del tramonto o definitivamente tramontate, amanti soprattutto attente ai tagli degli smoking e ai tagli delle banconote contenute nei portafogli altrui. Frequentatori di bar casalinghi fornitissimi, e sempre pronti a vivandare al soldo di impiegati delle agenzie pubblicitarie.
Le storie di O’Hara contengono esemplari di fauna umana d’ogni genere, vi si annusano mirabilia e un profluvio di dettagli riguardanti fanciulle estroverse e etiliche, poco di buono e brutti ceffi legati ai commerci loschi avvolti di paillettes e euforiche gelatine cinematografiche, dive sul viale del tramonto o definitivamente tramontate, amanti soprattutto attente ai tagli degli smoking e ai tagli delle banconote contenute nei portafogli altrui. Frequentatori di bar casalinghi fornitissimi, e sempre pronti a vivandare al soldo di impiegati delle agenzie pubblicitarie.
Lo stile di O’Hara segue alla lettera ogni disperazione come fosse parte di un copione scritto da Chandler, e ogni clamore infingardo come fosse scritto da Shakespeare. Se guardiamo lo scrittore nelle sue studiate pose ci rendiamo conto quanto l’affettazione e il pregiato carattere turbinoso siano puri figli di un’età dello scontento imbevuta di scotch e sonorizzata dai ticchettii notturni delle macchine da scrivere. Età d’oro per sceneggiatori strapagati o consumati in una stagione, e per grandi scrittori camuffati da giornalisti di costume sempre in attesa di gloria non postuma. O’Hara è tutto questo, e molto altro, e finalmente possiamo vantarci di averlo letto.