Si può scrivere della poesia astratta? Negli anni Cinquanta, già Wallace Stevens scriveva che “all poetry is experimental poetry”. È quanto ha tentato di fare John Ashbery, uno dei più grandi poeti americani del Novecento, scomparso nel 2017, fin dai suoi esordi negli anni Cinquanta. Quella di Ashbery si potrebbe definire una flat poetry, una poesia che sceglie deliberatamente di rimanere superficiale, per evitare di essere consumata dalle interpretazioni.
Se riprendiamo la poetica del grande precursore di Ashbery, il più grande poeta americano del Novecento, Wallace Stevens, la poesia astratta non deve essere una poesia che fa degli accostamenti strani, sul modello della nonsense poetry di Edward Lear, di Lewis Carroll o di alcuni surrealisti, per intenderci, bensì deve essere una poesia che, per utilizzare le stesse parole di Ashbery, “resists the intelligence almost completely”. È quanto scrive il critico John Hollander – uno dei migliori esegeti di Ashbery – proprio a proposito del Self-Portrait in a Convex Mirror (Autoritratto in uno Specchio Convesso), la raccolta poetica del 1975 che è stata recentemente riproposta da Bompiani con la traduzione di Damiano Abeni, con una leggera variazione nel titolo: Autoritratto entro uno specchio convesso. Il fascino del Self-Portrait – scrive Hollander – è il fascino della distorsione, la riproposizione in letteratura della tecnica pittorica della prospettiva anamorfica, come nel quadro Gli Ambasciatori (1533) di Hans Holbein il Giovane, una tecnica che esalta la deformazione della realtà, un complicato artificio per rivelare un significato nascosto (la Morte che incombe su tutto). Jurgis Baltrusaitis, nel suo fondamentale studio intitolato appunto Anamorfosi (1984), rivela come questo artificio stilistico pittorico mostri il lato assurdo della prospettiva, una prospettiva degenerata, per così dire, schiacciata su sé stessa. Secondo Baltrusaitis, l’anamorfosi è un sotterfugio ottico in cui l’apparenza eclissa la realtà: la prospettiva anamorfica annienta l’ordine naturale delle cose, applicando il principio della distorsione delle forme fino alle sue estreme conseguenze.
L’interesse di Ashbery per le arti visive e per le avanguardie si può far risalire alla metà degli anni Cinquanta, quando egli si trasferì in Francia grazie a una borsa di studio Fulbright, e vi rimase per circa dieci anni. Questa raccolta, e in particolare il poemetto conclusivo dal titolo omonimo, di più di 500 versi, rappresentò un approdo importante nella carriera di Ashbery. La sua pubblicazione nel 1975 gli fece guadagnare una grande notorietà nel panorama poetico statunitense e mondiale, con la ulteriore risonanza dovuta al fatto che il libro ottenne l’anno dopo il Premio Pulitzer, il National Book Award e il National Book Critics Circle Award per la poesia. Lo stile particolare del Self-Portrait segnò inoltre un ulteriore passo avanti nella eterna lotta tra la poesia e la critica, tra il poeta che cerca in tutti i modi di sfuggire alle caselle nelle quali il critico cerca di dargli scacco, e il critico che cerca perennemente di incastrarlo, di infilare il poeta con uno spillo per aggiungerlo alla sua collezione di trofei. Con il Self Portrait, per la prima volta in epoca moderna, si riproponeva la critica d’arte come un vero e proprio genere letterario (come già in Baudelaire, vedi il suo saggio “Le peintre de la vie moderne”), con l’aggiunta della spinta eversiva del Surrealismo, del Dadaismo e dell’Espressionismo astratto sulla poesia americana e inglese contemporanea.
È rimasto celebre l’incipit del Self-Portrait, in cui la poesia si maschera da illustrazione in forma di parole di un dipinto, da pura e semplice descrizione dell’immagine deformata del celebre quadro del pittore manierista Francesco Mazzola, detto il Parmigianino, che escogitò l’espediente – all’epoca modernissimo – di riprodurre se stesso utilizzando uno specchio convesso:
As Parmigianino did it, the right hand
Bigger than the head, thrust at the viewer
And swerving easily away, as though to protect
What it advertises. A few leaded panes, old beams,
Fur, pleated muslin, a coral ring run together
In a movement supporting the face, which swims
Toward and away like the hand
Except that it is in repose.

L’opera si trova tuttora esposta al Kunsthistorische Museum di Vienna, ed è uno dei capolavori del manierismo, che secondo questa interpretazione diventa uno dei più importanti precursori del modernismo in pittura e in letteratura, e in ultima analisi di tutte le avanguardie storiche del Novecento. Il poemetto di Ashbery prosegue con una citazione letterale dal testo di Giorgio Vasari, che descrive l’espediente utilizzato dal Parmigianino per realizzare il suo dipinto. La carica innovativa dell’Autoritratto, che si colloca in un’epoca apparentemente così distante dalla nostra, ci fa intravvedere, secondo Ashbery, una possibile via d’uscita dal vicolo cieco in cui si è cacciata l’arte contemporanea, sempre in bilico tra i due estremi di una sovversione impossibile (Duchamp) e di un richiamo all’ordine (Jean Cocteau). L’analisi dell’opera del Parmigianino permette inoltre ad Ashbery di cogliere un momento particolare nella storia dell’arte, il manierismo, in cui si andava affermando un modo nuovo di vedere le cose, un nuovo realismo, una nuova tecnica che distorceva la realtà per coglierne meglio la superficie, proprio come è accaduto negli anni Quaranta e Cinquanta con l’espressionismo astratto, e negli anni Sessanta e Settanta con la Pop Art. Da questo impulso d’avanguardia del Parmigianino nasce, secondo Ashbery, l’operazione eversiva di ritrarre la propria immagine riflessa in uno specchio convesso.
L’operazione tentata da Ashbery ha pochi precedenti, almeno in epoca moderna. Senza scomodare gli illustri precedenti di Orazio (Ars Poetica, 13 a.C.) e di Nicolas Boileau (Art poétique, 1674), senza dimenticare in epoca moderna la tradizione tipicamente francese di scritti sull’arte a opera di grandi poeti e scrittori, che ha i suoi esponenti più importanti in Charles Baudelaire (su Constantin Guys), Paul Valéry (su Edgar Degas), Jean Cocteau (su Pablo Picasso), fino a Michel Leiris (su Francis Bacon) e Michel Butor (su Mark Rothko). Un altro precedente importante è certamente il saggio di Gertrude Stein su Picasso (Picasso, 1938).
Tra i precursori di questa operazione di scrivere un poemetto che è anche un saggio di critica, si potrebbe citare uno dei maestri e mentori di Ashbery, Wystan Hugh Auden, l’Auden nella sua fase più matura e “americana”, che con The Sea and the Mirror ha scritto una sorta di saggio critico in versi su The Tempest di Shakespeare, una sorta di Ars Poetica contemporanea. The Sea and the Mirror (1944) rappresenta un precedente importante del Self-Portrait, così come The Man with the Blue Guitar (1937) di Wallace Stevens, esempio di poesia cubista, una sorta di Ars poetica in versi in cui l’opera di Picasso è poco più di un pretesto. Stevens ci teneva a precisare che la poesia non era direttamente ispirata al dipinto di Picasso, non era affatto una descrizione o una spiegazione del dipinto di Picasso, ma era un tentativo di adeguare lo stile della poesia contemporanea lanciando la stessa sfida che il cubismo aveva lanciato alle modalità di rappresentazione pittorica tradizionali. Si spiega così il rifiuto di Ashbery di riprodurre l’Autoritratto del Parmigianino nelle prime edizioni della sua opera, proprio per sottolineare il fatto che il dipinto è in ultima analisi un pretesto.
Dunque la tradizione dell’avanguardia americana, la cosiddetta “tradizione del nuovo”, (Harold Rosenberg) è costretta a fare i conti con una sorta di angoscia dell’influenza da cui deriva un’angoscia di rappresentazione. Il poeta e l’artista modernisti o contemporanei sono ben consapevoli di essere arrivati tardi, e reagiscono trasformando la propria belatedness in una paradossale originalità, che nasce dalla citazione e dal “saccheggio” della tradizione. Vale lo stesso per i manieristi? Anche loro erano consapevoli di essere arrivati tardi rispetto ai loro grandi predecessori del Rinascimento?
Già nel 1949 Maurice Blanchot affermava che la scomparsa del Surrealismo rappresentava la sua più grande vittoria. Si trattava in fondo di quello stesso fenomeno paradossale evidenziato da Oscar Wilde, della realtà che imita l’arte. Inoltre il Surrealismo rifletteva all’epoca quel fenomeno della “dissociation of sensibility” descritta da Eliot nel suo saggio sui “Metaphysical Poets” (Selected Essays, 1951). Successivamente la mentalità dissociata dei poeti metafisici si trasformò in vera e propria dissociazione mentale, o schizofrenia. Il dissociato mentale diventa, in epoca modernista e poi contemporanea, il paradigma di una realtà completamente altra che la ragione si è rifiutata per secoli di riconoscere. E, paradossalmente, il dissociato mentale è l’unico in grado, grazie proprio a questa sua personalità dissociata, di affrontare l”immense panorama of futility and anarchy” (“Ulysses, Order and Myth”, 1923) della nostra epoca contemporanea di cui parlava Eliot.
Ashbery è ben consapevole del cul de sac in cui si è cacciata l’Avanguardia: il gesto eversivo contro l’arte di Dada non può essere ripetuto all’infinito. Come diceva Marcel Duchamp, l’arte è una droga che dà assuefazione. È impossibile continuare a destabilizzare l’Arte all’infinito, è impossibile continuare a produrre per più di cinquant’anni una pittura e una poesia che “resistono all’intelligenza quasi completamente”. Ecco perché Marcel Duchamp, a un certo punto della sua carriera, smise di produrre opere d’arte per dedicarsi completamente al gioco degli scacchi. Evidentemente, si era reso conto che il gesto eversivo dell’Arte, ripetuto all’infinito, diventa esso stesso una tradizione, cioè proprio quello che si voleva distruggere. In epoca più recente, la soggettività sviluppata dagli artisti new dada, precursori della Pop Art, è una soggettività del tutto “piatta” e “superficiale”, che si presta molto a un confronto con il postmodernismo di Ashbery. Nei new dada c’è un esplicito rifiuto di individuare o suggerire significati profondi, significati che rischiano di banalizzare l’opera una volta che è stata spiegata. Ecco perché l’Autoritratto del Parmigianino si ritrae e si nasconde dietro la mano enorme deformata, proprio per evitare di essere consumata dall’interpretazione critica, e ciò ne fa un’opera modernissima nella sua concezione e realizzazione. Nella poesia di Ashbery c’è proprio questa strategia difensiva, simile al mostrarsi nascondendosi dell’Autoritratto del Parmigianino: un continuo sforzo per risultare sfuggente, inclassificabile, incomprensibile. Per questo è inutile continuare a lamentarsi della “perdita dell’aura” dell’opera d’arte descritta da Walter Benjamin (L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 1936), fenomeno che tra l’altro non provoca nessuna angoscia nell’artista contemporaneo. Si tratta di una nuova estetica, una Estetica dell’Indeterminazione, quella che Geoffrey Hartman ha definito “Xthetics” (La Critica nel Deserto, 1991), che trova uno dei suoi precedenti più notevoli proprio nel “gesto” eversivo/difensivo del Parmigianino.
Come nei manieristi e nei tardi epigoni dell’avanguardia, le epifanie di Ashbery sono sempre parziali e confuse, il rimando alla tradizione è sempre obliquo e parodico. Il poeta contemporaneo può soltanto tentare di trasformare le sue sconfitte in apparenti vittorie, la sua tardività in una felicità disperata. Bisogna sempre lavorare ai margini della comprensione, rischiare continuamente di rimanere incomprensibili ai lettori, se vogliamo conquistare un nuovo significato, la possibilità di esprimere un nuovo significato. È il trionfo dell’immaginazione, come diceva Stevens, ma anche la sua più terribile sconfitta. Ormai è impossibile distinguere tra “high” e “low”, tra cultura alta e cultura bassa, tra poesia elitaria e poesia per il grande pubblico, ma soprattutto è diventato quasi impossibile distinguere il messaggio “vero” dalle informazioni completamente inutili e dalle fake news.
Esiste ormai una consolidata tradizione di poeti americani espatriati che hanno saputo trasformare la loro condizione di esuli in un’occasione di arricchimento culturale. Ciò ha generato la falsa contrapposizione tra i due stereotipi del poeta americano: da una parte il bardo whitmaniano che lancia il suo “barbaric yawp”, dall’altra il sofisticato poeta modernista e cosmopolita che rifiuta in blocco la volgarità della società americana, si trasferisce in Inghilterra e ne prende la cittadinanza (T. S. Eliot).
 Eppure Eliot, soprattutto Eliot dei Four Quartets (1941), è molto più americano e whitmaniano di quanto egli stesso volesse far credere. Rispetto al saggio di Eliot, “Tradition and the Individual Talent” (1919), uno dei caposaldi del modernismo, Ashbery è ormai consapevole del fatto che non esiste più una tradizione autorevole, un solido punto di riferimento per i giovani poeti, ma soltanto la “tradizione del nuovo” dell’Avanguardia, il cui unico precetto è “make it new” (Ezra Pound). L’unica differenza è che di solito – ma non sempre – l’allusione letteraria nella Waste Land (1922) rimanda a una tradizione culturale “alta”. In Ashbery, invece, il frammento è fine a se stesso e può provenire indifferentemente dalla tradizione alta come da quella bassa degli slogan pubblicitari, delle canzonette o delle semplici espressioni che magari il poeta ha ascopltato casualmente mentre passeggiava per le strade di Manhattan. È la riproposizione di quella “estetica del frammento” inaugurata da Eliot e da Pound, ma in questo caso il riferimento letterario molto spesso è gratuito, superficiale… Si tratta, in fondo, di un testo che va inteso come fedele trascrizione di un environment uditivo e visivo in cui le citazioni letterarie si confondono con le banalità ascoltate per strada. Anche la poesia di Eliot, in fondo – o almeno la poesia della sua prima fase più sperimentale – è una poesia che trae i propri significati profondi da accostamenti apparentemente superficiali. L’artista d’avanguardia rifiuta in blocco la tradizione, riparte ogni volta da zero, oppure “saccheggia” la tradizione, cita liberamente dai testi della tradizione senza alcun riguardo per i suoi precursori. Egli sa bene che destino dell’artista, come dice Ashbery, è quello di essere frainteso, di essere letto con gli occhi del presente, “until no part / Remains, that is surely you. (Self-Portrait ).
Eppure Eliot, soprattutto Eliot dei Four Quartets (1941), è molto più americano e whitmaniano di quanto egli stesso volesse far credere. Rispetto al saggio di Eliot, “Tradition and the Individual Talent” (1919), uno dei caposaldi del modernismo, Ashbery è ormai consapevole del fatto che non esiste più una tradizione autorevole, un solido punto di riferimento per i giovani poeti, ma soltanto la “tradizione del nuovo” dell’Avanguardia, il cui unico precetto è “make it new” (Ezra Pound). L’unica differenza è che di solito – ma non sempre – l’allusione letteraria nella Waste Land (1922) rimanda a una tradizione culturale “alta”. In Ashbery, invece, il frammento è fine a se stesso e può provenire indifferentemente dalla tradizione alta come da quella bassa degli slogan pubblicitari, delle canzonette o delle semplici espressioni che magari il poeta ha ascopltato casualmente mentre passeggiava per le strade di Manhattan. È la riproposizione di quella “estetica del frammento” inaugurata da Eliot e da Pound, ma in questo caso il riferimento letterario molto spesso è gratuito, superficiale… Si tratta, in fondo, di un testo che va inteso come fedele trascrizione di un environment uditivo e visivo in cui le citazioni letterarie si confondono con le banalità ascoltate per strada. Anche la poesia di Eliot, in fondo – o almeno la poesia della sua prima fase più sperimentale – è una poesia che trae i propri significati profondi da accostamenti apparentemente superficiali. L’artista d’avanguardia rifiuta in blocco la tradizione, riparte ogni volta da zero, oppure “saccheggia” la tradizione, cita liberamente dai testi della tradizione senza alcun riguardo per i suoi precursori. Egli sa bene che destino dell’artista, come dice Ashbery, è quello di essere frainteso, di essere letto con gli occhi del presente, “until no part / Remains, that is surely you. (Self-Portrait ).
Il fatto di essere isolati, “out of fashion”, lontani dall’attenzione dei mass media e del grande pubblico, rappresenta secondo Ashbery un vantaggio per il poeta contemporaneo. L’isolamento gli fornisce la possibilità di portare avanti la propria ricerca in modo indipendente, senza farsi influenzare dalle mode come dovrebbe fare ogni artista degno di questo nome. Ashbery si è spesso descritto come un “Principe che viaggia in incognito”, un monarca assoluto che sceglie deliberatamente di uscire dalla sua reggia o torre d’avorio e di confondersi anonimo tra la folla, per tentare di “purificare il linguaggio della tribù” (Mallarmé) oppure per evitare seccature, per evitare di essere braccato ovunque vada da “signore anziane benpensanti in scarpe da tennis” a caccia di un autografo. Nessuno meglio di Ashbery sa che uno dei peggiori nemici dell’arte è proprio il successo. Il successo è una malattia, una malattia subdola: quando lo ottieni, quando ti accorgi di averlo raggiunto, ormai non c’è più niente da fare, sei spacciato. Farai qualsiasi cosa per mantenerlo, compreso la cosa peggiore che un artista possa fare: ripetere all’infinito la propria “maniera”, e in definitiva diventare il falsario di se stesso, come è accaduto a un grandissimo pittore come Giorgio De Chirico.
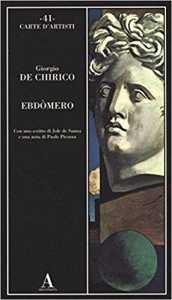 Giorgio de Chirico è il pittore che ha saputo fondere perfettamente la realtà e il sogno. Nella sua pittura – ma anche nel suo straordinario romanzo del 1929, Hebdòmero (Abscondita, 2016), possiamo riscontrare il predominio assoluto degli elementi immaginari e fantastici sugli elementi reali, in una narrazione che si snoda da un sogno all’altro, in un mondo completamente artificiale, ma che proprio per questo risulta più reale della realtà stessa, surreale. Il pittore o il poeta, se necessario, devono voltare le spalle e rinnegare la stessa élite che li ha sostenuti fino a quel momento, come fece de Chirico quando prese le distanze perfino dai surrealisti che lo idolatravano come un loro grande precursore. De Chirico, nella fase tarda della sua carriera, dopo la fase metafisica, ebbe una pesante involuzione accademica, un ritorno a un classicismo oramai impossibile nell’epoca contemporanea, con conseguente ripudio del suo periodo metafisico. Forse era l’unico modo per evitare di rimanere intrappolato nelle stesse categorie artistiche che lui stesso aveva contribuito a creare. Il paradosso dell’arte contemporanea è proprio questo: il vero artista contemporaneo deve cercare in tutti i modi di essere inaccettabile, se vuole che la sua opera sopravviva alle effimere mode del momento, al “quarto d’ora di celebrità” teorizzato da Andy Warhol. È l’eterna dialettica tra sovversione e tradizione, tra sovversione e accettazione, tra modernità e classicità. L’artista modello è costretto a interpretare il ruolo dell’eterno ribelle, e proprio per questo continua a essere mantenuto e coccolato dall’establishment. In una società che è riuscita a fagocitare perfino atteggiamenti di totale rifiuto come la ribellione del punk, le provocazioni dell’artista contemporaneo (vedi Catttelan) sembrano ben poca cosa. Il poeta moderno è letteralmente tormentato da questa pressante esigenza di essere sempre assolutamente moderni e originali (Baudelaire), di “tuffarsi nell’abisso dell’ignoto alla ricerca del nuovo”. Di qui il gesto difensivo della mano enorme nell’Autoritratto del Parmigianino, di qui la necessità per il poeta e l’artista contemporanei di essere per forza di cose revisionista, di operare una sovversione continua della tradizione, una rivoluzione permanente dell’arte e della letteratura che finisce essa stessa, suo malgrado, per trasformarsi in una tradizione.
Giorgio de Chirico è il pittore che ha saputo fondere perfettamente la realtà e il sogno. Nella sua pittura – ma anche nel suo straordinario romanzo del 1929, Hebdòmero (Abscondita, 2016), possiamo riscontrare il predominio assoluto degli elementi immaginari e fantastici sugli elementi reali, in una narrazione che si snoda da un sogno all’altro, in un mondo completamente artificiale, ma che proprio per questo risulta più reale della realtà stessa, surreale. Il pittore o il poeta, se necessario, devono voltare le spalle e rinnegare la stessa élite che li ha sostenuti fino a quel momento, come fece de Chirico quando prese le distanze perfino dai surrealisti che lo idolatravano come un loro grande precursore. De Chirico, nella fase tarda della sua carriera, dopo la fase metafisica, ebbe una pesante involuzione accademica, un ritorno a un classicismo oramai impossibile nell’epoca contemporanea, con conseguente ripudio del suo periodo metafisico. Forse era l’unico modo per evitare di rimanere intrappolato nelle stesse categorie artistiche che lui stesso aveva contribuito a creare. Il paradosso dell’arte contemporanea è proprio questo: il vero artista contemporaneo deve cercare in tutti i modi di essere inaccettabile, se vuole che la sua opera sopravviva alle effimere mode del momento, al “quarto d’ora di celebrità” teorizzato da Andy Warhol. È l’eterna dialettica tra sovversione e tradizione, tra sovversione e accettazione, tra modernità e classicità. L’artista modello è costretto a interpretare il ruolo dell’eterno ribelle, e proprio per questo continua a essere mantenuto e coccolato dall’establishment. In una società che è riuscita a fagocitare perfino atteggiamenti di totale rifiuto come la ribellione del punk, le provocazioni dell’artista contemporaneo (vedi Catttelan) sembrano ben poca cosa. Il poeta moderno è letteralmente tormentato da questa pressante esigenza di essere sempre assolutamente moderni e originali (Baudelaire), di “tuffarsi nell’abisso dell’ignoto alla ricerca del nuovo”. Di qui il gesto difensivo della mano enorme nell’Autoritratto del Parmigianino, di qui la necessità per il poeta e l’artista contemporanei di essere per forza di cose revisionista, di operare una sovversione continua della tradizione, una rivoluzione permanente dell’arte e della letteratura che finisce essa stessa, suo malgrado, per trasformarsi in una tradizione.
Il tema del “quadro nel quadro”, o dell’ “art about art”, che nell’Autoritratto del Parmigianino esprime uno dei suoi capolavori, è ormai diventato un cliché dell’arte moderna e contemporanea ed è un tema molto caro ad Ashbery, che ha sempre mostrato di preferire un tipo di arte, come direbbe Eliot, autotelica, un’arte che rimanda ossessivamente a se stessa, come il famoso quadro di Van Eyck, I Coniugi Arnolfini (1434), in cui l’artista ritrae se stesso nell’atto di dipingere, grazie al riflesso di uno specchio convesso che si trova alle spalle dei coniugi. Si potrebbero moltiplicare gli esempi – il quadro di Vermeer in cui viene riprodotto un interno in cui è presente un altro quadro dello stesso Vermeer, oppure Las Meninas di Velazquez (1656), La Condition Humaine I (1933) di Magritte, le opere di De Chirico, opere che non si limitano a riflettere su se stesse, ma che mostrano la realtà come quadro, opere che invadono e mettono in crisi il nostro modo di vedere la realtà, denunciando apertamente lo status di fiction del reale. Ma l’opera d’arte nella quale questa componente è più evidente è proprio l’Autoritratto del Parmigianino, un classico esempio di opera d’arte auto-referenziale, l’opera d’arte che parla e riflette su se stessa, che si nasconde nel momento in cui si rivela, dal Manierismo fino ai giorni nostri.
Se è vero, come ha affermato Ashbery in un’intervista, che è impossibile gettare un secchio di parole sulla pagina, così come Jackson Pollock gettava un secchio di vernice sulla tela, se è vero che la poesia deve per forza di cose essere composta seguendo quella che Ferdinand De Saussure definiva come la “linearità del significante” se non vogliamo che diventi illeggibile, è anche vero che esistono alcune tecniche di composizione che possono rendere la poesia altrettanto astratta e arbitraria del gesto che diede origine all’Action Painting.
Secondo William Carlos Williams la poesia dovrebbe riprodurre la realtà così com’è, “things as they are”. Ma, nella nostra società contemporanea, che cos’è la realtà? Inutile negare che le cose che attraggono di più l’attenzione e rimangono più impresse nella mente sono le insegne pubblicitarie, i nomi delle ditte multinazionali o dei prodotti commerciali. Su questo caos, su questo coacervo di informazioni, la maggior parte completamente inutili se non del tutto false e inattendibili, su questo per così dire “inconscio consumistico” che sembra avere ormai completamente colonizzato le nostre menti, il poeta interviene con un rapidissimo lavoro di editing, un procedimento che permette di evitare l’automatismo puro dei surrealisti, nel quale Ashbery sembra non credere fino in fondo. È un modo per “purificare il linguaggio della tribù” in modi che Mallarmé non avrebbe mai potuto condividere, eppure questa operazione ci permette per un momento di riflettere sulla nostra lingua di tutti i giorni, su quanto essa sia infarcita di cliché e di luoghi comuni che Ashbery pazientemente decostruisce e ritrasforma in poesia. Ashbery ha sempre affermato di non credere nella scrittura automatica, semmai nell’editing automatico. Egli preferisce affidarsi a una macchina, a un automa scrivente, simile agli automi di Vaucanson o alla macchina per dipingere inventata da Louise Montalescot nelle Impressions d’Afrique (1910) di Raymond Roussel, un altro grande precursore dei surrealisti. È il sogno di una scrittura impersonale, completamente indipendente dal suo autore. È il cosiddetto procédé rousseliano: lasciarsi trasportare dal significante, senza preoccuparsi del significato, anzi lasciando che il significante produca un suo significato, per quanto assurdo e paradossale esso possa sembrare. Si tratta di una scrittura che si affida completamente a quella che Jacques Lacan definirebbe la “deriva del significante”. Si tratta di un procedimento letterario che aspira a produrre un testo totalmente impersonale e “meccanico”, come i celebri automi del Settecento.
Nella poesia di Ashbery torna dunque a farsi sentire la poetica dell’impersonalità meccanica, contrapposta all’impersonalità, per così dire, “chimica” di T. S. Eliot (“Tradition and the Individual Talent”), reinterpretato prendendo a modello il genere secondario del saggio di art criticism – da Giorgio Vasari a Sydney Freedberg, di cui vengono ripresi letteralmente alcuni brani del suo saggio sul Parmigianino – che viene elevato alla dignità di una vera e propria opera letteraria. Per la prima volta il recensore non ha alcun timore di citare alcuni suoi illustri predecessori, di appropriarsi delle loro parole generando un nuovo testo poetico, e utilizza un linguaggio commisurato allo stile dell’artista.
Oscar Wilde, De Chirico, Roussel e lo stesso Ashbery non si stancano mai di ricordarci che l’arte crea una realtà artificiale superiore alla realtà vera. La realtà artificiale è rappresentata, nella società americana contemporanea, da Anaheim, il grande parco divertimenti della Disneyland a Los Angeles, trionfo supremo dei simulacri (Jean Baudrillard), predominio assoluto dell’artificiale sulla realtà. Nelle poesie di Ashbery l’artificio prevale sul reale, e ritorna ad affermarsi quella estetica metropolitana dello choc che caratterizzava già la Parigi di Charles Baudelaire e successivamente di Walter Benjamin. In questa Waste Land in technicolor si aggira il poeta contemporaneo, come Alice nel Paese delle meraviglie, in un tourbillon di immagini, suoni, colori, che bombardano continuamente il flaneur contemporaneo. Ma come possiamo identificare questa nuova incarnazione del dandy, il flaneur contemporaneo? Qual’è la sua incarnazione più attuale? È forse il serial killer amante dell’arte come Hannibal Lecter? È forse il Joker, l’uomo che trasforma il delitto in un’opera d’arte? È forse il terrorista contemporaneo, l’unico che ormai guarda con la necessaria attenzione i monumenti delle nostre città d’arte, proprio perché sogna di farli saltare in aria? La poesia di Ashbery rappresenta l’approdo finale di questa attenzione deformata e intermittente che caratterizza colui che si aggira per la metropoli contemporanea, quel processo di deformazione della realtà che ha avuto inizio proprio con l’intuizione geniale del Parmigianino e ci ha portato, dopo una serie di passaggi, all’odierno regno dei simulacri. Un’arte autotelica, che riflette se stessa, che riflette su se stessa, un ideale che è stato realizzato da alcuni esponenti della pop art come Roy Lichtenstein, quando dipinge con grande dettaglio – ma utilizzando i retini tipici dei fumetti – una pennellata (Big Painting VI, 1965). Come non vedere in questa operazione la realizzazione del sogno impossibile del modernismo, il sogno di Cezanne, Picasso, Mondrian, Kandinsky, il sogno di un’arte astratta e assolutamente autoreferenziale.
Nel Self-Portrait di Ashbery la critica d’arte finisce per contemplare l’immagine distorta di se stessa. Il Self-Portrait è una sorta di saggio di critica d’arte in versi, che mostra una ambiguità di fondo e una difficoltà che derivano soltanto dalla sofisticatezza e dall’allusività del ragionamento. Ma dove porta tutto questo gioco a nascondino del poeta, questo vero e proprio meccanismo di difesa? Ancora una volta ci viene in soccorso il Divino Oscar, che diceva: “La critica è l’unica forma decente di Autobiografia.” Descrivendo l’opera del Parmigianino, Ashbery sta in realtà rivelando se stesso, alcuni aspetti essenziali della sua personalità. Inoltre non bisogna dimenticare che Ashbery ha lavorato per molti anni scrivendo recensioni di mostre per la Paris Edition dell’International Herald Tribune e per la rivista Art News. Di qui nasce la sua straordinaria sensibilità per i paradossi dell’Avanguardia. Questa originale mescolanza di poesia, arti visive, fumetti e pop culture, di cultura d’élite e cultura di massa, traspare dunque anche dai suoi articoli di art criticism, raccolti in Reported Sightings.
Grazie al genere apparentemente minore del saggio di critica d’arte, della recensione di una mostra, Ashbery riesce a esprimere significati nuovi nella sua poesia. Ora che il secolo delle avanguardie, il Novecento, si è concluso, Ashbery ha trovato nuovi modi di risultare difficile e sperimentale senza risultare illeggibile.
Ciò accade nell’Autoritratto del Parmigianino: esso non rispecchia affatto la realtà, ma rivela l’opera nel momento stesso del suo farsi, rivela e nasconde la propria alterità, anche se per un momento lo spettatore si illude di guardare la propria immagine riflessa in uno specchio convesso:
The hand holds no chalk
And each part of the whole falls off
And cannot know it knew, except
Here and there, in cold pockets
Of remembrance, whispers out of time.
Autoritratto entro uno specchio convesso era stato già tradotto da Aldo Busi per l’edizione Garzanti del 1983. Si propone un confronto tra le differenti scelte effettuate dai due traduttori: Aldo Busi e Damiano Abeni



