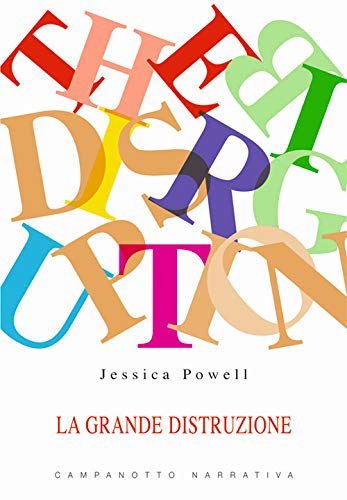Se un quarto di secolo fa per i Microservi di Douglas Coupland (Feltrinelli, 1995) il neonato Web bastava a evocare un punto di fuga dal guscio soffocante e normaloide di Microsoft e di Bill Gates, per le orde di ingegneri approdati nella Silicon Valley degli Anni Dieci il mantra è ora avere una visione per rendere il mondo un posto migliore. Vale a dire essere disruptive, parola chiave nel gergo di qualsiasi Venture Capitalist, remotamente ispirata a Schumpeter e puntualmente richiamata dal titolo del libro.
Ad Anahata, una corporate digitale immaginaria che richiama in tutto e per tutto le sembianze di Google, la società dove l’autrice, Jessica Powell, ha ricoperto fino a due anni fa il ruolo di Vice President per la comunicazione, il mondo dei comuni mortali (a cominciare dai colleghi del marketing e delle vendite “con un QI appena superiore alla media”) va stretto da sempre ai teorici dell’innovazione, tanto da accarezzare l’idea di abbandonare il pianeta Terra al suo destino per fondare una colonia lunare di ingegneri dove la civiltà umana potrà finalmente ripartire da capo senza impicci.
Nel mondo di Anahata ogni ingegnere ha in mente un sogno meraviglioso, da sviluppare nel tempo riservato ai progetti personali, come “sostituire le gabbie dell’oppressione mondiale (anche note come zoo) con dei rifugi per animali robotizzati.” In un mondo quasi perfetto dove “Il fallimento non è un’opzione,” perché “I geni non fallivano mai, anche quando non era così”, puoi chiamare “ingegneri delle pulizie” i comuni addetti e, in spregio alle stantie regole del vecchio mondo analogico, magari anche assumerne uno particolarmente svitato come Product Manager, nella convinzione di sottrarre una preziosa risorsa umana alla concorrenza. Del resto “dove altro mai si potrebbero avere delle qualifiche quali ‘Evangelista,’ ‘Guerriero della sicurezza,’ ‘Protettore di tutte le cose di Internet,’ e ‘Debuggatore’?”
Malgrado fiumi di parole sulla diversity aziendale il mondo di Anahata è rimasto scientificamente misogino e sessista, e riserva alle donne le sole funzioni di staff e, all’occorrenza, di intrattenimento del brufoloso personale tecnico. Jennie, l’unico personaggio femminile del romanzo, con una passione per il femminismo e i biopic di grandi imprenditori, si convincerà di fottere finalmente il patriarcato trasformando le colleghe in escort. La sua fede nel management del resto non vacilla anche davanti all’evidenza: “stava dando delle fallite alle donne in generale, non a Jennie in particolare, e per lei il suo ego era molto più importante di qualsiasi altro più vasto movimento sociale”.
Al centro di questo universo eliocentrico il sole ruota attorno a Bobby, il founder ultra-visionario, ora CEO intimamente tormentato dalla paura di scoprirsi presto o tardi a sua volta obsoleto, dopo dieci anni (“che nella Silicon Valley sono un secolo per un’azienda normale”) di trimestrali dorate.
Tra un colpo di gong e un saluto al sole, Bobby – un incrocio tra il Galvin Belson di Silicon Valley (la serie tv) e un prontuario di Wired del 1996 – indica ai suoi collaboratori la Via con frasi ispirazionali immancabilmente paracule (“Non ora. Solo grandi idee, Grandi Idee”). Per primo al fido CTO (Chef Technology Officer), Gregor, l’expatriat austriaco a capo degli ingegneri, perfetto esemplare di carnefice psicopatico frustrato nei suoi affetti più profondi e meno contraccambiati. Gregor è un fanatico del controllo in un campus tecnologico dove anche il prato ogni mattina viene settato su una precisa tonalità RGB: nulla ha senso ma nessun dettaglio è lasciato al caso, dalla composizione degli smoothie a disposizione dei dipendenti ai risvolti delle t-shirt aziendali.
Il libro di Jessica Powell usa spudoratamente il registro comico, facendo esplodere come un palloncino il lato più folle dell’ideologia californiana, rinunciando in partenza a denunciare la parabola distopica delle Internet Company che attraversa invece, ad esempio, la riflessione di The Circle (Mondadori, 2014) di Dave Eggers o, su un altro piano, oggi, il pentitismo banale di un documentario come The Social Dilemma (Netflix, 2020). In questo modo riesce a raggiungere il pubblico trasversale alla massa di quanti “stanno fuori” dai giochi o li subiscono come comuni utenti, e a non parlare soltanto ai lettori acculturati di Shoshana Zuboff. Senza limiti narrativi posti a priori, il racconto fantozziano decolla felicemente, potendo giocare finalmente alla pari con i sogni escatologici dei colossi FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google). E, non da ultimo, con le loro megagalattiche e sempre più lampanti responsabilità sociali.