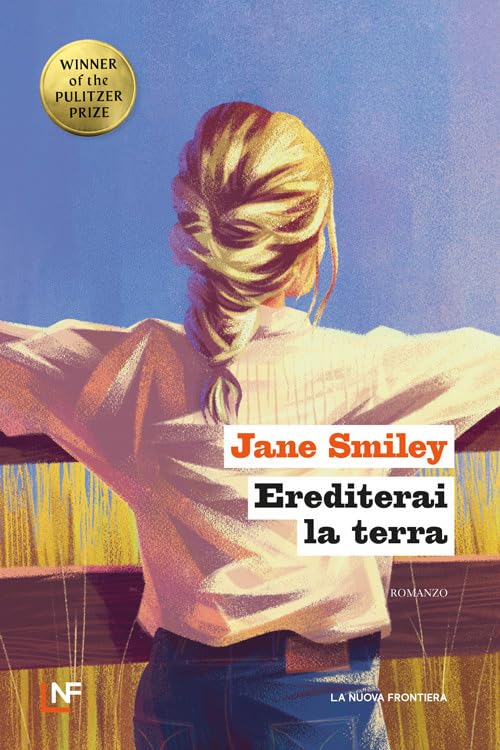Non è esattamente un libro nuovo, Erediterai la terra di Jane Smiley. Era stato pubblicato negli Stati Uniti nel 1991 e aveva vinto il premio Pulitzer nel 1992. La ripubblicazione, e ritraduzione, in Italia alla fine del 2024, rende il romanzo, quasi paradossalmente, ancora più attuale che se fosse appena stato pubblicato. I “mille acri” del titolo originale, la proprietà agricola che è l’orgoglio della famiglia Clark, ci porta in quel mondo americano poco conosciuto che è tornato alla ribalta per il sostegno a Trump nelle ultime elezioni. Dovremmo dire “supposto sostegno” a Trump, dato che il voto è segreto. Ma sappiamo anche con ragionevole certezza che l’America rurale, l’America bianca povera, l’America tradizionale si sente ben rappresentata da Trump.
I mille acri della famiglia Clark, che da orgoglio diventano la causa del disfacimento della famiglia e dei suoi legami, sono in realtà un’eredità sporca, inquinata metaforicamente dal dispotismo e dalla violenza del padre/padrone, e inquinata realmente dai pesticidi e dagli altri veleni chimici utilizzati per far rendere la terra sempre di più.
Siamo in una contea immaginaria dello Iowa, uno stato culturalmente insignificante che però è da sempre il granaio degli Stati Uniti. E siamo negli anni settanta/ottanta. Larry Clark, agricoltore di successo, decide all’improvviso di ritirarsi e di cedere la terra alle tre figlie. Ginny e Rose sono sposate e vivono vicino al padre; mentre i mariti lavorano la terra con il suocero, loro cucinano, curano la casa, i figli, gli animali. La figlia minore, Caroline, è invece un avvocato che ha lasciato la campagna e si è trasferita a Des Moines: sono state le sorelle, molto più grandi di lei, a incitarla a scegliere una strada diversa. La cessione della proprietà, che non è chiaro se sia l’ennesima trovata del despota Larry oppure una decisione ponderata ma di cui si è subito pentito, porta alla luce le tensioni presenti da sempre nella famiglia e un passato pieno di violenza, di umiliazioni, di prevaricazioni, di dolore. Per le donne la vita di campagna è una prigione: non solo sono costrette a lavori di casa e intorno alla casa particolarmente pesanti e ripetitivi, ma hanno intorno un mondo piccolo e ristretto, relazioni solo di vicinato, anch’esse pesanti e ripetitive, mai scelte liberamente.
All’inizio del racconto Ginny, la voce narrante, ci sembra sostanzialmente contenta della sua vita. Certo, il padre è un tipo difficile, ma il marito è tranquillo e gentile e affidabile. Certo la sorella Rose è spigolosa, e ha due figlie che Ginny, al quinto aborto spontaneo, le invidia moltissimo. Ma cerca di tenere tutto e tutti insieme, chiude gli occhi e vede solo quello che vuole vedere, è compiacente e conciliante e pensa che in questo modo si possa andare avanti. C’è la terra, che è quella del nonno e del padre, che chiede sacrifici e lavoro.
Poi un giorno arriva Jess, il figlio dei vicini che era fuggito in Canada per evitare di andare a combattere in Vietnam. Jess torna a casa e spariglia le carte. Jess viene da fuori, ed è chi viene da fuori, chi ha uno sguardo diverso, che ci fa aprire gli occhi. E quando li abbiamo aperti, non possiamo più richiuderli.
Così Ginny, suo malgrado, comincia un percorso di conoscenza e di consapevolezza. Accetta e dà spazio ai ricordi degli abusi sessuali del padre su di lei e sulla sorella Rose, con il silenzio complice della madre e con l’acquiescenza di tutto il vicinato. Non può più ignorare i racconti di Rose, la paura, la vergogna, il disgusto. Non può più negare che ci sia un nesso tra il cancro di Rose, i suoi aborti e l’acqua dei pozzi avvelenati. Non può più ignorare che la terra, sfruttata in modo intensivo ed eccessivo, resa più produttiva a forza di chimica, cominci a ribellarsi.
Nessuna delle convinzioni e delle relazioni di Ginny resiste al nuovo sguardo con cui vede la sua vita e il suo mondo. In un crescendo di scontri personali, di scoperte e disvelamenti, Ginny decide di andarsene. Lascia il marito, lascia la fattoria, la sorella e si rifugia poco lontano, in una vita minimale e quasi monacale: un lavoro da cameriera, un monolocale e poi una casetta con il giardino, la lettura. Una nuova pace, una solitudine benedetta.
Ginny è la vera e l’unica sopravvissuta di questa tragedia che è una sorta di riscrittura contemporanea del Re Lear. Ma è una tragedia senza nobiltà e senza enfasi. È una tragedia americana e contadina, il precipitare di un mondo che si credeva potesse essere migliore e migliorare costantemente. Precipita il mito della terra che arricchisce, basta averne tanta, tantissima, lavorarla con le macchine più sofisticate, e con pesticidi e fertilizzanti sempre più potenti. Precipita il mito della famiglia, dei patriarchi che hanno sempre ragione, delle donne che sono sempre disponibili, dell’eredità di padre in figlio, dei fratelli e delle sorelle che passano sopra i contrasti pur di conservare la terra. Precipita anche il mito della divisione del lavoro “naturale”, gli uomini nei campi e le donne a casa. E precipita anche quella struttura sociale che era stata esportata in America dall’Europa, con l’illusione che con più terra da sfruttare, senza le zavorre della nobiltà, senza le tasse e le gabelle di una società rigidamente organizzata, tutto avrebbe funzionato. In realtà niente funziona, e l’agricoltura finirà nelle mani delle multinazionali, che ne intensificheranno lo sfruttamento e l’inquinamento.
Alla fine, da quei mille acri se ne andranno tutti, sconfitti dalla storia oltre che dalle proprie personali incapacità. Se ne andranno però a cominciare un’altra vita. Perché se l’America ha qualcosa che ancora ci seduce e le invidiamo, è la possibilità di reinventarsi altrove, di chiudere una porta perché più in là, a est o a ovest, si può aprire un portone.