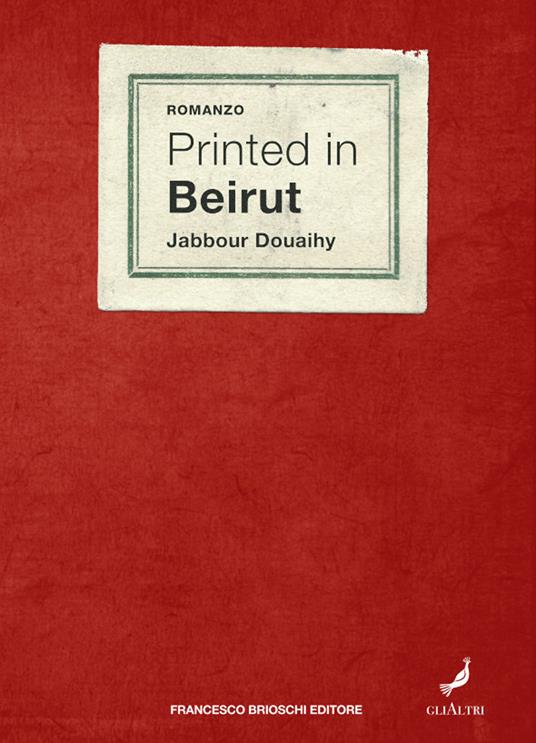Il vuoto lasciato il 23 luglio scorso dalla morte di Jabbour Douaihy è difficilmente spiegabile all’interno degli strettissimi confini dell’editoria italiana. Adagiato nel comodo solco delle “primavere arabe”, infatti, il nostro mercato culturale ha fatto incetta di autori, attivisti e intellettuali libanesi solo in seguito allo scoppio della Rivoluzione dei Cedri[1], nel 2005. E non è un caso.
Il mito del Davide beirutino che insorge e caccia il Golia siriano propiziò allora l’opportuna entrata in scena, nelle nostre librerie, di scrittori come Douaihy – mentre nei nostri cinema giunsero registe come Nadine Labaki e nelle nostre cronache politiche comparvero attiviste come Joumana Haddad. Prima di allora il Libano era istintivamente ritratto in forma di cumuli di macerie, condannato in eterno alla feroce archeologia della guerra civile, pur conclusasi nel 1990.
Davanti a questa scenografia di cartone, anche i numerosi scrittori già espatriati e trapiantati nella ville lumière godevano di sostanziale indifferenza dalle nostre parti. Un peccato originale che in tempi recenti ha generato l’infantile sindrome della compensazione tardiva: basti pensare alla pletora di opere di Amin Maalouf stampate e ristampate voracemente in Italia negli ultimi tre anni (un rapido controllo sui vostri siti di acquisto prediletti potrà confermarvelo). E anche se la “Rivoluzione dei Cedri” pare proseguire imperterrita – basti pensare alle vastissime, quotidiane mobilitazioni del biennio 2019-2020[2] – la nostra attenzione sulla società libanese è rientrata in letargo, o almeno in una strana condizione di narcolessia incorniciata dal fatalismo.
Printed in Beirut non viene quindi pubblicato da Feltrinelli, come i due precedenti lavori di Douaihy (Pioggia di Giugno, 2006 e San Giorgio guardava altrove, 2012) bensì dal coraggioso editore Brioschi. Che per paradosso ha reso reale, con questa uscita, il tema portante del romanzo stesso: non sono le sirene narcisistiche a sollecitare ogni desiderio di pubblicazione, quanto la volontà di sconfiggere il tempo dell’anonimato (quindi della morte) attraverso l’illusoria eternità della stampa. Unica tra le tecniche umane a non potersi ancora consumare interamente nel virtuale e perciò capace di infondere nobiltà culturale anche a chi dal mondo virtuale proviene.
Farid Abu Sha’ar, scrittore naif impegnato nella spasmodica ricerca del primo editore, vive la sua condizione di paria squattrinato vagando per le strade di Beirut con un manoscritto (etimologicamente redatto a penna, da amanuense) e con la prospettiva di tornare a casa dalla madre al termine di ogni sterile giornata. Questo finchè non si imbatte nell’insegna della “Tipografia F.lli Karam, fondata nel 1908”, il cui titolare, Abdallah Karam, dopo avergli rifiutato la pubblicazione, lo assume come correttore di bozze per le stampe in arabo.
“Mentre lo accompagnavano alla scrivania del correttore, si disse che non si sarebbe mai abituato all’odore dell’inchiostro. E invece ci si abituò”.
La famiglia Karam è di tradizione cristiano maronita, perciò incollata a una mastodontica stampatrice digitale nuova di zecca, Farid vide una piccola icona della Beata Vergine. Anche la moglie di Abdallah, però, si rivela progressivamente al giovane come un’autentica apparizione divina: Persefone Melki, è una Venere di stirpe greca, costretta a barattare la laurea in Architettura e la fascinazione per le Belle Arti con la condizione di borghese agiata, moglie annoiata e madre di due gemelle.
Grazie a questa elementare fusione tra mondo musulmano, cristiano ed ellenico, Douaihy costruisce la trama di un finto “giallo poliziesco amoroso” – non a caso, sono i generi di romanzi prediletti da Persefone – scandito e dominato dalle ombre degli avi dei protagonisti, dalla narrazione delle loro (s)fortune, sempre coincidenti con le profonde ferite storiche della terra libanese.
Lo stridore potenziale tra le tonalità pop e quelle drammatiche del romanzo viene magistralmente armonizzato dall’uso dell’ironia, che Douaihy si preoccupa di dosare come fosse un witz, attingendo da un lato allo stile lapidario di autori come Karl Kraus (Era un bel ragazzo, Farid, non pareva uno che lavora in tipografia né, d’altronde, uno che lavora), dall’altro a quella assurdità delle convenzioni sociali per noi indissolubilmente legata alle figure di Kafka e Camus. Come quando in uno dei suoi monologhi onirici proiettati nel futuro, Farid pensa che “non avrebbe voluto una sinossi in quarta di copertina perchè la sua scrittura non si presta alla sintesi e, anzi, è essa stessa la quintessenza della coincisione, nè tantomeno vorrebbe che ci fosse un estratto, certo che no, non permetterà che la lingua e il contenuto del suo testo si disvelino al primo colpo d’occhio […] la quarta del suo libro rimarrà intonsa, non ci sarà scritto nemmeno il prezzo”.
Dietro le vicende storiche delle famiglie Karam e Abu Sha’ar non si nasconde soltanto il secolare conflitto tra la borghesia e il proletariato. Si cela invece soprattutto quello tra il carattere industriale della stampa e il valore artistico della scrittura: quindi tra la serialità del capitalismo e l’artigianato. Il passato libanese diventa anch’esso, forse per la prima volta nella letteratura, degno di essere osservato tramite la lente di Gutenberg. Così, mentre il bisnonno di Abdallah, Fu’ad Karam, imbroglia le truppe turche rubando da un convento i macchinari per la stampa necessari a fondare la futura azienda di famiglia, il capostipite della stirpe di Farid viene ribattezzato “Abu sha’ar” (“capellone”) perché dopo aver offeso un emiro con una scritta allusiva si ritrova completamente rasato, a titolo di punizione. I successori della famiglia tenteranno il riscatto da quell’infamia seguendo quasi tutti le vie della letteratura aulica e della ricerca linguistica araba, ma sempre con esiti disastrosi, finchè la nuova generazione, sia in diaspora sia in patria, si è dedicata all’informatica, al marketing e alla pubblicità.
A fungere da sintesi hegeliana tra questi due destini opposti sarà proprio la classicità greca incarnata da Persefone: curiosa e insonne, la donna viene colta quasi sempre mentre scende (come angelica deus ex machina) dall’attico di famiglia agli inferi della tipografia sottostante[3]. È grazie a lei che il fascino puramente estetico del manoscritto di Farid – “ricomincia a leggere e di nuovo non capisce, insiste ma ancora niente, le pagine sono scritte in una calligrafia molto bella, la lingua le sfugge, le parole ondeggiano davanti ai suoi occhi” – si trasforma nel sapore magico dell’oggetto misterioso, che verrà sottratto di nascosto e stampato in caratteri preziosi per semplice vezzo da padrona. Quindi a totale insaputa del suo autore.
Farid troverà l’opera poggiata miracolosamente sulla scrivania, la addebiterà alle preghiere dell’anziana madre, ma ne godrà soltanto per un tempo brevissimo, perché lo splendido manufatto sarà sequestrato durante una retata della polizia. E ogni riferimento a La lettera rubata di Poe è puramente casuale.

La parodia comica del racconto di Poe emerge quasi in modo esplicito. Quando Farid interroga i colleghi di lavoro circa la scomparsa del manoscritto, ad esempio.
– Quelle pagine sono parte della mia essenza
– Chi vuoi che rubi un manoscritto di poesie, qui da noi?
– Le ho forse detto di essere un poeta?
– No, ma un po’ ci somigli…
Non potendo obiettare, lasciò che continuasse.
E poi quando il libro è finalmente stampato e giunge la polizia per una retata.
– Abbiamo l’ordine di requisirlo
– Ma questo è un libro di poesie!
Adesso, per sminuire l’importanza del suo libro, era lui a dire che si trattava di poesie.
Nel climax conclusivo del romanzo, Douaihy si diverte a prendersi gioco del lettore, cancellando repentinamente i toni rosa che avrebbero potuto/dovuto trionfare nel finale ed esasperando al contrario i termini dell’ingiustizia di classe. Lo fa per rimarcare in modo grottesco la vittoria definitiva dell’avidità borghese, certamente, quanto dell’opportunismo economico che gli fa da matrioska, soprattutto nella lottizzazione del potere tipica di Paesi come il Libano. O forse con la malinconica sconfitta finale di Farid, l’autore ha voluto omaggiare – in un ringraziamento di congedo – quella “infelicità araba” superbamente teorizzata dal compianto connazionale Samir Kassir, ucciso da un’autobomba, sempre a Beirut, sempre in quel fatidico 2005, che ancora pare un incipit imprescindibile.
[1] https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_del_Cedro
[2] https://it.wikipedia.org/wiki/Proteste_in_Libano_del_2019-2020
[3] Nel mito greco Persefone è la moglie di Ade.