Con la “rivelazione” finale de “L’Espresso” riguardo al suo autore, il caso editoriale di Ipnocraia (Tlon, 2024), passa ora al livello successivo. Il breve saggio dello pseudo Jianwei Xun, che in questi mesi ha scalato classifiche, collezionato ristampe e richieste di traduzioni, è attualmente già disponibile in edizione inglese, spagnola e francese. Sappiamo ora che Xun, accreditato “giovane filosofo di Hong Kong, formato in Europa, a metà strada tra Baudrillard e Byung-Chul Han”, senza lasciare traccia di sé, non è mai esistito, o meglio, è lo studiato nom de plume del presunto traduttore, Andrea Colamedici, docente, saggista ed founder delle Edizioni Tlon. Il testo di Ipnocrazia, come il titolo stesso, nasce da un duplice progetto che il giovane filosofo ha sviluppato e poi unificato nel corso dell’ultimo anno, in conversazione con alcune piattaforme di intelligenza artificiale (Anthropic Claude e Chat GPT nello specifico). Non meno improbabili, come del resto già precedentemente appurato, anche alcuni autori (Hiroshi Tanaka, Marcus Heidemann) e riferimenti accademici (“l’esperimento di Berlino”) contenuti nel saggio e parimenti inventati di sana pianta.
A farla semplice, abbiamo un’operazione alla Luther Blissett, il nome multiplo usato negli anni ’90 dal collettivo bolognese che divenne Wu-Ming, per beffare l’establishment mediatico del suo tempo. Non a caso, il Luther Blissett Project è anche, insieme a Darko Maver, uno dei rari esempi che Colamedici cita, come possibili precursori di resistenza all’odierna Ipnocrazia. Tale è infatti definito il regime – psichico e governamentale prima che politico – in cui ci troveremmo immersi in questo momento storico, dacché il potere avrebbe smesso di controllare o di reprimere i nostri comportamenti e ha imparato invece a condizionare direttamente i nostri stati di coscienza. Lungi dall’indebolire le tesi del libro, le nuove rivelazioni sui fakes, sulla scrittura con le IA, ecc., sembrano piuttosto aver sovrapposto un ulteriore strato memetico al puro contenuto del saggio, rilanciandolo nuovamente nella curva della viralità e della conversazione collettiva.
 Il saggio ipotizza come noto che “le piattaforme social non vendono pubblicità, vendono stati alterati di coscienza. L’intelligenza artificiale non emula l’intelligenza umana, perfeziona tecniche di induzione ipnotica” (p. 14). L’ipotesi prende le mosse dalla filosofia della mente per planare, attraverso una serie di manovre linguistiche e di neologismi (trance algoritmica, ipnosi probabilistica), verso concettualizzazioni più riconoscibilmente politiche. Ad esempio la sovranità percettiva, ovvero la capacità del soggetto di operare stando “simultaneamente dentro e fuori la trance” (p. 26). Per farlo dovrà rinunciare a molte cose, e in primo luogo alla purezza e alla presunta autenticità del proprio sé, accettando che la verità nell’epoca digitale è “meno questione di fatti e più funzione di reti di significato interconnesse e autovalidanti” (p.20). In pratica, rinunciare all’illusione di un attivismo social polarizzato e valorizzato dall’algoritmo o alla tentazione illuministica del fact checking, inutile quando non apertamente controproducente.
Il saggio ipotizza come noto che “le piattaforme social non vendono pubblicità, vendono stati alterati di coscienza. L’intelligenza artificiale non emula l’intelligenza umana, perfeziona tecniche di induzione ipnotica” (p. 14). L’ipotesi prende le mosse dalla filosofia della mente per planare, attraverso una serie di manovre linguistiche e di neologismi (trance algoritmica, ipnosi probabilistica), verso concettualizzazioni più riconoscibilmente politiche. Ad esempio la sovranità percettiva, ovvero la capacità del soggetto di operare stando “simultaneamente dentro e fuori la trance” (p. 26). Per farlo dovrà rinunciare a molte cose, e in primo luogo alla purezza e alla presunta autenticità del proprio sé, accettando che la verità nell’epoca digitale è “meno questione di fatti e più funzione di reti di significato interconnesse e autovalidanti” (p.20). In pratica, rinunciare all’illusione di un attivismo social polarizzato e valorizzato dall’algoritmo o alla tentazione illuministica del fact checking, inutile quando non apertamente controproducente.
Nessuno oggi vive nello stesso mondo, condivide la stessa dimensione percettiva o si affida ai medesimi protocolli per validare la realtà che scorre attorno a sé, ma è portato invece ad abitare universi completamente diversi. Parafrasando Jean Baudrillard, “la simulazione non imita più il reale, lo precede” (p. 55). Dopo le filter bubble degli anni ’10, il multiverso social ha creato per ciascuno di noi un microcosmo parallelo di affetti e di valori che siamo indotti ad abitare e a personalizzare. L’Ipnocrazia, lungi dal governare, reprimere o censurare le nostre opinioni alimenta l’intimità e la molteplicità di questi nuovi mondi, dentro a cui nuotano come pesci le nostre identità liquide. Il gesto febbrile con cui aggiornando i nostri feed facciamo doomscrolling su Instagram e TikTok, mentre il sistema ottimizza i nostri picchi di dopamina, è in fondo lo stesso già noto alle vecchie slot machine. La manipolazione dell’anticipazione (p. 63), la nostalgia algoritmica (p. 67), la sindrome del protagonista (p. 68) sono solo alcuni dei motori cognitivi che, nell’era della coscienza digitalmente mediata, il saggio ci segnala in una vera e propria profusione di marketing speculativo. In questo maelstrom, qualsiasi narrazione non è vera o falsa in sé ma può essere vissuta come vera nel tempo della piattaforma, che mescola indifferentemente il rimpianto per un passato mai vissuto e insussistente con l’ansia per un futuro fittizio e costantemente differito.
Come ogni costruttivismo, più o meno temperato, anche quello dello pseudo Xun non annuncia affatto “la fine della realtà” ma soltanto che la realtà sociale, basata sul linguaggio, grazie all’automazione dell’intelligenza, ha occupato la sfera dell’ontologia, in cui si agitano oggi, come nella caverna di Platone, le ombre della politica e della morale. Il titolo completo del libro è infatti Ipnocrazia. Trump, Musk e la nuova architettura della realtà. Ma anche Trump e Musk in fondo sono solo “i profeti di questo regime (…) sono dispositivi narrativi. Le loro narrazioni non cercano la verità, ma lo stupore” (p. 46). Se Freud – autore che il saggio non contempla, a differenza di Messner – all’alba del ventennio nazifascista, in Psicologia delle masse e analisi dell’Io (1921) metteva in relazione il “contagio mentale” rilevato nell’orientamento delle masse con “i fenomeni d’ordine ipnotico”, nell’attuale regime ipnocratico cambia anche il rapporto tra ipnotizzatori e ipnotizzati. Esso non è univoco o di mera subalternità, ma piuttosto di seduzione, “un campo di risonanza dove gli stati alterati si alimentano e si amplificano a vicenda” (p. 47).
Il paradigma dell’Ipnocrazia è infatti l’ipertrofia del messaggio. Esso non consiste tanto nel controllo predittivo dei dati o nell’economia del “capitalismo della sorveglianza” quanto nella saturazione di ogni possibile discorso. O, a dirla in prosa con Steve Bannon, in una meccanica che letteralmente “flood the zone with shit“, inonda la stanza di merda. Contrariamente alle speranze dei benintenzionati, non riguarda soltanto la strategia comunicativa di un movimento iper-reazionario come MAGA ma il panorama mediatico che l’automa cibernetico tende oggi a riprodurre ovunque all’infinito, nella sfera pubblica come in quella privata, con la nostra partecipazione più o meno attiva e consapevole.
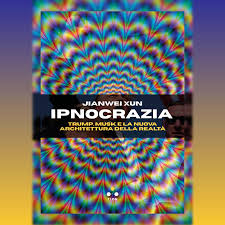 Nondimeno la partnership con le IA e le tecnologie cognitive non può essere demonizzata o respinta a priori ma piuttosto agita in funzione di una resistenza invisibile che, al di sotto del livello dei radar, sfrutti i glitch e gli interstizi offerti involontariamente dal sistema, prendendo esempio dal sogno, facendo emergere e proliferare realtà parallele e contraddittorie (p. 97). Se da un lato, infatti, l’ipnocrazia ha reingegnerizzato il nostro piacere e trasformato anche questa manipolazione in una fonte di godimento artificiale (p. 91), dall’altro il suo crollo appare nel lungo termine persino inevitabile (p. 114), a mano a mano che l’estetica della simulazione si avvita ricorsivamente su sé stessa. Tanto più se le tecnologie e i medium, che oggi vediamo manipolare con successo gli stati alterati di coscienza, sono solo la versione perversa e degradata, che prelude a un salto evolutivo molto più ampio verso “un piano molto più antico e più profondo prova a manifestarsi” (Epilogo). Non è chiaro se questo ritorno dell’irriducibile comprenderà o meno anche una resurrezione dei corpi che per l’Ipnocrazia, come del resto per il saggio stesso, sembra già solo e interamente sussunta nel regime della virtualità.
Nondimeno la partnership con le IA e le tecnologie cognitive non può essere demonizzata o respinta a priori ma piuttosto agita in funzione di una resistenza invisibile che, al di sotto del livello dei radar, sfrutti i glitch e gli interstizi offerti involontariamente dal sistema, prendendo esempio dal sogno, facendo emergere e proliferare realtà parallele e contraddittorie (p. 97). Se da un lato, infatti, l’ipnocrazia ha reingegnerizzato il nostro piacere e trasformato anche questa manipolazione in una fonte di godimento artificiale (p. 91), dall’altro il suo crollo appare nel lungo termine persino inevitabile (p. 114), a mano a mano che l’estetica della simulazione si avvita ricorsivamente su sé stessa. Tanto più se le tecnologie e i medium, che oggi vediamo manipolare con successo gli stati alterati di coscienza, sono solo la versione perversa e degradata, che prelude a un salto evolutivo molto più ampio verso “un piano molto più antico e più profondo prova a manifestarsi” (Epilogo). Non è chiaro se questo ritorno dell’irriducibile comprenderà o meno anche una resurrezione dei corpi che per l’Ipnocrazia, come del resto per il saggio stesso, sembra già solo e interamente sussunta nel regime della virtualità.
Se la pars construens, a cui è dedicata la seconda parte del saggio, risulta (come sempre in questo casi) meno potente della prima, il piano stesso della falsificazione, che fa ora seguito alla scoperta del fake e dell’inesistente del filosofo cinese dal nome cool, fornirà nuove e ulteriori munizioni al progetto di Colamedici? I nostri due cent che il libro, grazie alla beffa, fiorirà adesso al di là e oltre il suo epilogo, nell’anello che unisce la teoria al suo possibile svolgimento. E alle istruzioni per l’uso che, a saper cogliere gli indizi, il saggio suggeriva già dalla sua comparsa.



