Gianfranco Calligarich è una di quelle figure letterarie che bisogna tenersi care, una di quelle già classiche, per naturale predisposizione, come non se ne fanno più in un mondo che ha troppa fretta: il lettore si scelga una bella poltrona comoda, si conceda un attimo di raccoglimento e si immerga nel suo stile adamantino ed elegante per lasciarsi portare via dal racconto come da un flusso di marea. Chi non cederebbe al fascino di alcuni fra gli incipit più perfetti della nostra letteratura recente? “Del resto è sempre così. Uno fa di tutto per starsene in disparte e poi un bel giorno, senza sapere come, si trova dentro una storia che lo porta dritto alla fine. Quanto a me avrei fatto volentieri a meno di mettermi in gara. Avevo conosciuto gente di ogni genere, gente arrivata e gente che non era neanche riuscita a partire ma tutta prima o poi con la stessa faccia insoddisfatta per cui ero giunto alla conclusione che la vita fosse meglio limitarsi a osservarla, non avevo però fatto i conti con una sfigatissima mancanza di soldi in un giorno di pioggia all’inizio della primavera dell’anno scorso. Tutto il resto venne come vengono queste cose, da sé. Sia chiaro subito che non ce l’ho con nessuno, ho avuto le mie carte e le ho giocate. Ecco tutto.”, questo è tratto da L’ultima estate in città, il suo romanzo d’esordio. Oppure: “Un giorno di vento quando il mondo era ancora un posto immenso, stupendo e semplice da vivere, in un pomeriggio di febbraio dell’anno millenovecentouno, ventottesimo della sua lunga vita, settantunesimo di quella ancora più lunga del suo Imperatore, quattordicesimo prima di quel Primo Grande Massacro Mondiale che lo avrebbe dichiarato disertore e ultimo nella sua città dove non avrebbe mai più fatto ritorno, un uomo con gli occhi grigi chiuso dentro un nero cappotto da marinaio e brevi sorrisi che erano solo un balenare di denti perennemente stretti si era imbarcato su una nave da carico di ferro scura come il destino per raggiungere il porto di Massaua dove non sarebbe mai arrivato.”, questo invece da La malinconia dei Crusich. Due passi a caso fra i preferiti di chi scrive queste righe; a chi legge invece il piacere di proseguire, di non staccarsi dalla pagina fino alla parola fine: a questo servono gli incipit.
Calligarich è per di più una persona affabile e amabilissima che coltiva l’arte e il piacere del racconto anche nella conversazione. E cose da raccontare ne ha parecchie. Ha vissuto la Roma della Dolce Vita negli anni del mito e della sua decadenza; affiancato personaggi come Natalia Ginzburg, Giancarlo Fusco, Giuseppe Berto o Ennio De Concini; attraversato il giornalismo, il cinema, la televisione, il teatro, senza mai abbandonare il suo amore più grande: la letteratura. I suoi romanzi stanno vivendo in questi ultimi anni una particolare fortuna internazionale e si susseguono le traduzioni in varie lingue.
Come ti presenteresti, Gianfranco, a un aspirante lettore che ancora non ti conosce? Pensi sia utile chiarire a questo potenziale lettore, cos’è per te la letteratura e cosa significa per Gianfranco Calligarich essere uno scrittore? E dal momento che se il lettore cerca lo scrittore, il processo avviene sempre nei due sensi: qual è il lettore che vorresti, cosa chiedi a lui in cambio di quello che tu gli offri ?
Non ricordo, nella mia infanzia, che qualcuno mi abbia mai raccontato una favola. Ultimo di tre fratelli più grandi di me di dieci e tredici anni la mia infanzia è stata una sorta di prigione comandata da mio padre, uscito da sei anni di prigionia nel deserto egiziano, e accudita da mia madre, alle prese con quattro maschi in casa in una vita resa per tutti difficile da un mondo da ricostruire dopo la distruzione provocata dalla Seconda guerra mondiale. Per cui non c’era tempo per le favole e la mia solitudine di ultimo arrivato era totale e piena di paure. Poi i miei fratelli più grandi avevano cominciato a portare a casa degli oggetti misteriosi e in cui si immergevano assenti da tutto quello che li circondava prima di riporli in uno scaffale. Si chiamavano libri ed era stato intorno i dieci anni e steso a letto per una influenza che ne avevo preso uno e mi ero messo a leggerlo. Era Come era verde a mia vallata di Richard Lewellyn e, totalmente preso da quello che leggevo, quando lo avevo finito mi ero ritrovato così smarrito nel mio mondo abituale che immediatamente lo avevo ricominciato da capo. Era stata la mia prima favola e si chiamava letteratura. Da quel momento avrei deciso di raccontarmi favole, vale a dire mi ero messo a scriverne anch’io dando un corso tumultuoso alla mia vita marinando la scuola per chiudermi alla Biblioteca Nazionale di Milano a leggere e scrivere come un pazzo.
 Il tuo primo romanzo, L’ultima estate in città, uscì nel 1973 per Garzanti ottenendo un plauso generale e l’ammirazione in particolare di Natalia Ginzburg. Oggi, a distanza di tanti anni, il libro sta ottenendo ancora un grande interesse internazionale in Europa e fuori d’Europa. Puoi parlarci di questo romanzo, della sua continuità nel tempo e della forza particolare che lo caratterizza. Come nacque e cosa rappresenta per te ancora adesso?
Il tuo primo romanzo, L’ultima estate in città, uscì nel 1973 per Garzanti ottenendo un plauso generale e l’ammirazione in particolare di Natalia Ginzburg. Oggi, a distanza di tanti anni, il libro sta ottenendo ancora un grande interesse internazionale in Europa e fuori d’Europa. Puoi parlarci di questo romanzo, della sua continuità nel tempo e della forza particolare che lo caratterizza. Come nacque e cosa rappresenta per te ancora adesso?
Da poco superati i vent’anni e in rotta con la famiglia, a causa della mia scioperataggine che mi aveva fatto smettere di andare a scuola, dove, del resto, ero stato regolarmente bocciato, mi ero trasferito a Roma per fare il giornalista, venendo letteralmente travolto dalla sua bellezza e dalla libertà della città al punto di rifiutarmi di tornare a Milano, dove il giornale mi aveva richiamato e venendo licenziato, regalandomi due anni di fame e di pressoché totale povertà. Ma avevo deciso di scrivere un romanzo sulla città e così era nato L’ultima estate in città. Rifiutato da tutti gli editori, una sera lo avevo lasciato nella portineria di Natalia Ginzburg che mi aveva telefonato la mattina dopo dicendomi che lo aveva letto durante la notte e che le era piaciuto molto. Era stata lei, facendomi vincere il Premio Inedito, a farlo pubblicare da Garzanti. Il libro, uscito in piena estate, in due mesi aveva venduto 17.000 copie ma non era stato ristampato e io, deluso e necessitante di soldi, avevo cominciato a fare lo sceneggiatore, prima come negro del grande sceneggiatore Ennio De Concini, premiato con un Oscar , e poi per la Rai, dove, per circa quindici anni, avrei scritto uno sceneggiato dopo l’altro. Intanto L’ultima estate in città viveva una sua sopravvivenza grazie a una consorteria di lettori che, dopo averlo comprato sulle bancarelle, se lo prestavano a vicenda come degli ostinati carbonari, finché, nel 2010, lo aveva ripubblicato Aragno, raffinatissimo e riservatissimo editore, facendolo, a oltre quarant’anni dalla sua uscita, esplodere sui giornali come un incredibile caso editoriale. Ripubblicato per la terza volta da Bompiani, adesso, grazie a Gallimard che lo ha acquistato per pubblicarlo in Francia, lo vogliono tutti, ed è stato comprato da Spagna, Olanda, Germania, Austria Israele, oltre che Inghilterra e Stati Uniti. Insomma un’altra favola nella mia vita.
Parte del fascino del testo è dato dall’aderenza perfetta tra protagonista e ambiente circostante, tra personaggi e, se così vogliamo dire, Zeitgeist, spirito dell’epoca. Non si può fare a meno di provare nostalgia per la Roma descritta, la Roma della Dolce vita, non proprio quella iniziale di Federico Fellini, ma quella immediatamente successiva, il crepuscolo del boom che si sfiatava,“non con un urlo, ma con un sospiro”, nella crisi incombente del decennio successivo. Come ti poni nei confronti della tua città di adozione, Roma, la Roma favoleggiata e mitica di allora, ma anche – ahimè – la Roma presente?
Roma non perde fascino neanche oggi. È una grande città abbandonata a se stessa e piena di sventrati cassonetti traboccanti di immondizia e gli alberi, i magnifici pini romani, cadono e si spezzano per colpa dell’incuria. Ma il suo fascino resiste se non è addirittura aumentato proprio grazie alla sporcizia. Dopo duemila anni siamo davanti al definitivo sfascio dell’Impero Romano. Mica è poco.
C’è una scena nella prima parte de L’ultima estate in città che, tra le tante, mi ha profondamente colpito. È il twist – direbbe uno sceneggiatore americano – dinamico e geniale con cui disinneschi il possibile luogo comune della scena madre amorosa: in pieno centro di Roma, nei pressi di Piazza di Spagna, il protagonista dice ti amo alla sua bella, ma proprio in quell’istante un fiume di arance, sfuggite da una busta rotta, si sparge per strada e i due ragazzi s’interrompono per correre a raccogliere i frutti tra i piedi della folla. Direi che non c’è niente di più cinematografico. Era inevitabile che il cinema si accorgesse di te. Quando è avvenuto il tuo primo coinvolgimento con la narrazione per immagini? Ed è stato un flirt o un amore?
È stato un flirt. Una cosa è il cinema, un’altra la TV e un’altra ancora la letteratura. L’amore vero e l’ultimo e che continua a sedurmi ancora adesso.
In ogni caso hai prodotto anche in questo campo cose che sono rimaste. Ritratto di donna velata è stato uno di quegli sceneggiati RAI che hanno fatto la storia: quel gotico nazionalpopolare che – dopo il successo de Il segno del comando – avrebbe imperversato per vari anni sugli schermi. Parapsicologia, thriller, misteri etruschi, ma nel tuo caso conditi, in più, anche con una bella dose di ironia e con personaggi più vissuti e meno “legnosi” di quelli a cui ci avevano abituati gli sceneggiati tradizionali. Vuoi parlarcene un po’?
Fare Ritratto di Donna velata è stato semplice. È bastato costruire un protagonista che non credeva nei fantasmi, la storia dello sceneggiato, ed era alle prese con la mancanza di soldi per fare benzina alla sua macchina. Credo sia stato proprio quello a rendere un po’ più verosimile la storia. Un po’ ridevi e un po’ ti spaventavi. Come nella vita.
Anche nel cinema propriamente detto hai realizzato, nei primi anni Settanta, sceneggiature per film interessanti, legati in qualche modo a quel fortunato (e oggi giustamente rivalutato) sottogenere che all’epoca si definiva “poliziottesco”. Ricordo La polizia ha le mani legate di Luciano Ercoli, ma soprattutto Città violenta di Sergio Sollima, regista tra i miei preferiti, che realizzò una trilogia di Spaghetti Western con Tomàs Milian di grande valore (anche politico) e che in seguito portò sugli schermi Sandokan con Kabir Bedi. Cosa ricordi di questo periodo e di queste figure artistiche e umane ?
Ricordo Sollima come un bravo regista, ma quello che ricordo con più affetto e anche nostalgia di quel cinema è l’attore protagonista de La polizia ha le mani legate, Claudio Cassinelli. Eravamo molto amici e lui era un vitalista, bellissimo e simpaticissimo che poi è morto per il suo vitalismo. In Sudamerica per girare un film, aveva paura di salire su un elicottero che doveva passare sotto un ponte, poi c’era salito ed era sceso eccitato e molto divertito al punto di risalire sull’elicottero per alcune scene che non necessitavano della sua presenza a bordo. Quella seconda volta l’elicottero aveva urtato il ponte ed era precipitato uccidendo sia lui che il pilota.
Il “poliziottesco” ci riporta al noir, genere che so ami particolarmente come lettore, ma che hai anche attraversato – sempre alla tua maniera naturalmente – come autore: sto parlando di un altro tuo romanzo più recente che mi ha coinvolto con particolare intensità, si tratta di Principessa pubblicato da Bompiani nel 2013. Un testo in cui giochi con i tòpoi del genere – a cominciare dalla femme fatale, dalla coppia maledetta, dalla narrazione in “soggettiva”, ecc. – per sconvolgerli, parafrasarli ed eluderli. Esiste un Calligarich Noir, dunque?
Mi piacciono i noir e ho molto amato Raymond Chandler sopratutto per il suo Il Lungo Addio. C’è dentro, oltre che il senso dell’amicizia, quello della fine che è qualcosa che mi porto dentro e che mi esce in tutto quello che scrivo. Mi è piaciuto molto scrivere Principessa. Scrivevo di Milano, che amando Roma ho sempre trattato poco, e ho amato i personaggi, sia il duro corriere della droga sia il tenerissimo e commovente travestito che la sera va a battere il marciapiede con un cappotto di pelle nera. E nel libro il senso della fine è coniugato con il rimorso. Sì, mi è piaciuto molto scriverlo.
Un altro tuo inusitato excursus nella pratica dei generi letterari poi, è un libro particolarissimo che recupera la grande tradizione – settecentesca e preromantica soprattutto – del romanzo epistolare. Posta prioritaria, uscito nel 2002 con Garzanti e ristampato nel 2014 da Bompiani, però, pur guardando a una solida e consolidata tradizione, non lo fa in termini nostalgici o retrò, ma resta un testo assolutamente moderno e ancorato a personaggi e situazioni del tutto contemporanei. Com’è nata questa scelta così inattuale e come hai risolto l’apparente sfasamento fra la complessità della materia trattata e la rinuncia ad un ritmo narrativo diretto ?
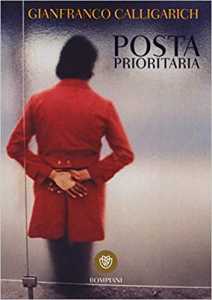 Posta prioritaria è senza dubbio il mio libro più felice. L’ho scritto quando, occupandomi di teatro, ero del tutto convinto che non avrei ma più scritto narrativa. Poi, la donna di cui ero innamorato e con cui avevo litigato, aveva risposto a una mia lettera ma scrivendomi a sua volta una lettera e a farmi rendere conto che le due lettere, una dietro l’altra, costituivano un racconto d’amore rapido e coinvolgente. Era fantastico. Non c’era bisogno né di dialoghi né di descrizioni e tutto era rapido ed emozionante. Così, dopo anni e anni che non lo facevo, ed ero del tutto scomparso dall’editoria, avevo ricominciato a scrivere lettere su lettere prendendo spunti dalla vita e perfino dai giornali o da qualche ricordo. Poi le telefonavo e glieli leggevo e anche lei era impazzita e mi spingeva a scrivere e scrivere finché era nato un libro che, dopo i soliti rifiuti degli editori, era capitato nelle mani di Giovanni Piccioli, direttore di Garzanti, che mi aveva telefonato dicendomi che, solo in casa e in un giorno di pioggia, stava leggendo i miei racconti divertendosi moltissimo e perfino commovendosi per cui lo avrebbe pubblicato. Non posso fare a meno di riportare la recensione di Antonio D’Errico sul Sette de Il Corriera della Sera il cui stupefacente titolo era “Inaudito: Uno scrittore. Italiano e addirittura troppo bravo”. E così avrei ripreso a scrivere il libro che da anni cercavo di scrivere e che di tanto in tanto tiravo inutilmente fuori dal cassetto. Privati Abissi.
Posta prioritaria è senza dubbio il mio libro più felice. L’ho scritto quando, occupandomi di teatro, ero del tutto convinto che non avrei ma più scritto narrativa. Poi, la donna di cui ero innamorato e con cui avevo litigato, aveva risposto a una mia lettera ma scrivendomi a sua volta una lettera e a farmi rendere conto che le due lettere, una dietro l’altra, costituivano un racconto d’amore rapido e coinvolgente. Era fantastico. Non c’era bisogno né di dialoghi né di descrizioni e tutto era rapido ed emozionante. Così, dopo anni e anni che non lo facevo, ed ero del tutto scomparso dall’editoria, avevo ricominciato a scrivere lettere su lettere prendendo spunti dalla vita e perfino dai giornali o da qualche ricordo. Poi le telefonavo e glieli leggevo e anche lei era impazzita e mi spingeva a scrivere e scrivere finché era nato un libro che, dopo i soliti rifiuti degli editori, era capitato nelle mani di Giovanni Piccioli, direttore di Garzanti, che mi aveva telefonato dicendomi che, solo in casa e in un giorno di pioggia, stava leggendo i miei racconti divertendosi moltissimo e perfino commovendosi per cui lo avrebbe pubblicato. Non posso fare a meno di riportare la recensione di Antonio D’Errico sul Sette de Il Corriera della Sera il cui stupefacente titolo era “Inaudito: Uno scrittore. Italiano e addirittura troppo bravo”. E così avrei ripreso a scrivere il libro che da anni cercavo di scrivere e che di tanto in tanto tiravo inutilmente fuori dal cassetto. Privati Abissi.
 Il romanzo epistolare, non so perché, dato che l’associazione non è scontata, risuona per me di echi teatrali, e questo rimanda a un altro importante momento della tua attività artistica: la carriera parallela di drammaturgo, regista teatrale e conduttore negli anni Novanta di un prestigioso teatro in uno dei luoghi più magici di Roma. È quello che, più o meno, racconti anche nel tuo romanzo più recente Quattro uomini in fuga del 2018, uscito per Bompiani. Cosa puoi aggiungere ?
Il romanzo epistolare, non so perché, dato che l’associazione non è scontata, risuona per me di echi teatrali, e questo rimanda a un altro importante momento della tua attività artistica: la carriera parallela di drammaturgo, regista teatrale e conduttore negli anni Novanta di un prestigioso teatro in uno dei luoghi più magici di Roma. È quello che, più o meno, racconti anche nel tuo romanzo più recente Quattro uomini in fuga del 2018, uscito per Bompiani. Cosa puoi aggiungere ?
Aggiungo che è andata proprio così. Dopo avere fondato e gestito un teatro off all’interno del Fontanone del Gianicolo, ho vissuto i dieci anni più adrenalinici e divertenti della mia vita con le avventure più disparate, e tutto quello che avviene nel romanzo è realmente accaduto nel teatro. Solo il prologo con l’avventura del rapimento del toro Short Horn è inventato e l’ho scritto per raccontare la barlordaggine dei protagonisti della storia.
Un altro fra i tuoi romanzi più significativi, vincitore del Premio Viareggio nel 2017, è La malinconia dei Crusich (pubblicato da Bompiani nel 2016), in cui ti confronti con la grande eredità del romanzo mitteleuropeo e, riscoprendo e ripercorrendo le tue radici familiari, ci conduci in un grande affresco storico che parte dal primo Novecento e, attraversando l’esperienza coloniale e le due guerre mondiali, approda alla contemporaneità: un romanzo tutto italiano ma su cui per me aleggia il respiro di Mann, Roth o Musil, forse per la malinconia che lo caratterizza – è presente anche nel titolo – o, meglio ancora, la sehensucht, parola che in italiano non esiste. Forse un tuo commento in proposito è necessario.
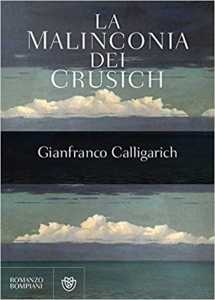 La malinconia dei Crusich è il romanzo più importante che abbia scritto. Importante per me, intendo, visto che è l’esatta storia mia e della mia vasta e avventurosa famiglia durante tutto il Novecento. E il fatto sia stato accostato a Cent’anni di Solitudine e ai Buddenbrook mi ha fatto a lungo andare in giro, contro la mia abitudine, con la schiena ritta e la testa alta. Se poi, camminando a testa alta, schiacciavo quello che è meglio non schiacciare camminando, non me ne fregava niente, visto che i cani sono la miglior compagnia che si possa desiderare nella vita e li amo moltissimo.
La malinconia dei Crusich è il romanzo più importante che abbia scritto. Importante per me, intendo, visto che è l’esatta storia mia e della mia vasta e avventurosa famiglia durante tutto il Novecento. E il fatto sia stato accostato a Cent’anni di Solitudine e ai Buddenbrook mi ha fatto a lungo andare in giro, contro la mia abitudine, con la schiena ritta e la testa alta. Se poi, camminando a testa alta, schiacciavo quello che è meglio non schiacciare camminando, non me ne fregava niente, visto che i cani sono la miglior compagnia che si possa desiderare nella vita e li amo moltissimo.
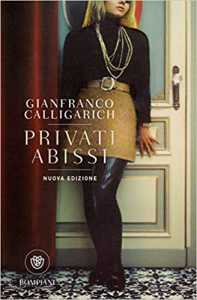 Abbiamo per ora trascurato Privati abissi, il tuo romanzo che vinse il Premio Bagutta nel 2011. È azzardato, secondo te, definirlo un melodramma esistenzialista ? A te la parola.
Abbiamo per ora trascurato Privati abissi, il tuo romanzo che vinse il Premio Bagutta nel 2011. È azzardato, secondo te, definirlo un melodramma esistenzialista ? A te la parola.
Si, esistenzialista, se vogliamo. Ed è un romanzo che amo in modo particolare. Me lo sono portato dentro per anni e riuscire alla fine a scriverlo e pubblicarlo è stato come rinascere un’altra volta.
E per concludere la domanda classica: a cosa stai lavorando adesso?
Sto lavorando a un romanzo, non una biografia, su un esploratore dell’Africa di fine ottocento, Vittorio Bottego. La sua è stata una vita all’estremo ed è morto a soli trentasette anni, fatto uccidere dall’Imperatore di Etiopia Menelik irritato dalle sue esplorazioni. Mi ha affascinato la sua breve e sfrenata brama di vivere, che è la cosa che da sempre mi interessa raccontare. I miei romanzi vogliono infatti essere relazioni sull’essere vivi e al mondo, tutto qui. E, come credo di averti scritto, considero la vita un viaggio su un treno affollato in corsa verso un’unica stazione coi passeggeri che si scannano per occupare i posti migliori, ma anche chiacchierando amichevolmente e passandosi magari qualche sandwich o qualcosa da bere. Io me ne sto appartato vicino a un finestrino e ogni tanto passo qualcosa da leggere. Tutto qui.
Grazie Gianfranco per la disponibilità e la franchezza. Ti salutiamo e ti auguriamo buon lavoro.
Narrativa
L’ultima estate in città (Milano, Garzanti, 1973; Milano, Bompiani, 2016)
Posta prioritaria (Milano, Garzanti, 2002; Milano, Bompiani, 2014)
Privati abissi (Roma, Fazi, 2011; Milano, Bompiani, 2018)
Principessa (Milano, Bompiani, 2013)
La malinconia dei Crusich (Milano, Bompiani, 2016)
Quattro uomini in fuga (Milano, Bompiani, 2018)
Testi per il teatro
Grandi balene
Sceneggiatura per il cinema
Città violenta regia di Sergio Sollima (1970)
Lo stato d’assedio regia di Romano Scavolini (1969)
La polizia ha le mani legate regia di Luciano Ercoli (1974)
Grosso guaio a Cartagena regia di Tommaso Dazzi (1987)
Sceneggiatura per la TV
ASSICURAZIONE SULLA MORTE regia di Carlo Lizzani con Patricia Millardet
MARTIN EDEN regia di Giacomo Battiato con Christopher Connelly, Vittorio Mezzogiorno, Mimsy Farmer
STORIA DI ANNA regia di Salvatore Nocita con Laura Lattuada, Flavio Bucci, Tino Schirinzi
FREDDO DA MORIRE regia diMario Cajano con Luc Merenda e Catherine Spaak
INCONTRARSI E DIRSI ADDIO regia di Mario Foglietti con Bruno Corazzari, Lorenza Guerrieri
PICCOLO MONDO ANTICO regia di Salvatore Nocita con Laura Lattuada, Alida Valli, Tino Carraro
PICCOLO MONDO MODERNO regia di Daniele D’Anza con Aldo Reggiani, Valentina Fortunato
NATA D’AMORE regia di Duccio Tessari con Massimo Ranieri, Mattia Sbragia, Tullio Solenghi
LA PROMESSA di Frederich Durrenmatt regia di Alberto Negrin con Rossano Brazzi, Raymond Pellegrin
GELOSIA regia di Leonardo Cortese con Arnoldo Foà, Lorenza Guerrieri
UN UOMO IN TRAPPOLA regia di Vittorio De Sisti con Ugo Pagliai, Lorenza Guerrieri
LA CASA ROSSA regia di Luigi Perelli con Alida Valli, Ray Lovelock
TUTTA UNA NOTTE con Eros Pagni, Paola Pitagora
TRE ANNI regia di Salvatore Nocita con Giulio Brogi, Tino Carraro, Giancarlo Dettori, Renato De Carmine, Paola Pitagora
IL COLPO regia di Sauro Scavolini con Fabio Testi, Lorenza Guerrieri, Raymond Pellegrin
ETERNA GIOVINEZZA regia di Vittorio De Sisti con Barbara De Rossi, Adalberto Maria Merli, Franc Souvignon
LA RAGAZZA DELL’ADDIO regia di Daniele D’Anza con Ray Lovelock, Maddalena Crippa, Giancarlo Dettori
RITRATTO DI DONNA VELATA regia di Flaminio Bollini con Nino Castelnuovo, Daria Nicolodi
UNA DEVASTANTE VOGLIA DI VINCERE regia diSauro Scavolini conFrancesco Carnelutti, Ugo Cardea
L’INSEGUITORE regia di Mario Foglietti con Claudio Cassinelli, Stefania Casini
TUTTA UNA NOTTE di Harmon Coxe con Eros Pagni e Paola Pitagora
DOPO VENT’ANNI di O.Henry con Bruno Corazzari e Carlos De Carvalho
SENZA TREGUA di Raoul Whitfield con Sergio Castellitto
LA MATITA di Raymond Chandler con Renato Scarpa e Daniela Surina
MORTE AL PICCO DELL’AQUILA di Frank Gruber con Franco Savarone e Enrico Papa



