[testo pubblicato originalmente su Machina]
In cerca di altre mappe è una rassegna bimestrale sul fantastico femminista curata da Giuliana Misserville. «Prevede quattro appuntamenti sulle sovversioni dell’immaginario, quattro percorsi nella narrativa fantastica di questi anni.
La fine dell’antropocene richiede la messa a punto di nuovi paradigmi ma è un lavoro che le scrittrici hanno iniziato da tempo. Come sottolineava Ursula Le Guin nel lontano 1982 “Sembra che l’immaginazione utopica sia intrappolata, come il capitalismo e l’industrialismo e la popolazione umana, in un futuro a senso unico fatto solo di crescita” anche a costo della distruzione del pianeta. Secondo l’autrice di The Left Hand of Darkness, l’utopia euclidea (organizzata geometricamente, con le parti etichettate, un modello perfettamente riproducibile) è giunta al capolinea e ora, se vogliamo rigettare il dannato binarismo della scelta tra felicità e libertà che ci ha condotto sull’orlo dell’abisso, dobbiamo percorrere sentieri non mappati, i sentieri del coyote, difficili da individuare, ancora più difficili da percorrere. Sentieri che ritroviamo in Chthulucene di Donna Haraway: “abbiamo bisogno di storie (e di teorie) abbastanza grandi da contenere le complessità e mantenere gli argini e i confini aperti e affamati di nuove e vecchie connessioni capaci di sorprenderci”. Riprendiamo dunque in mano gli attrezzi approntati da Le Guin e Haraway e andiamo oltre per “tracciare attivamente una serie di sentieri da e verso storie perpetue e condivise”. Narrative in grado di proporre «futuri prossimi, futuri possibili, e presenti poco plausibili ma reali”.
Il primo itinerario riguarda come Decolonializzare la fantascienza. Da Ursula Le Guin a N.K. Jemisin la narrativa è portatrice di istanze che smontano l’ordine costituito e richiedono a chi legge di prendere posizione contro il potere, l’ingiustizia e l’ipocrisia. Sono quelli che Jemisin chiama pugni in faccia, salutari e liberatori e che si concretizzano in storie che riescono a cambiare il modo in cui percepiamo le cose.
Io non scrivo afrofuturismo è il secondo itinerario. Il passaggio dall’afrofuturismo all’africanfuturismo, teorizzato e messo a fuoco da Bernardine Evaristo e Nnedi Okorafor, nella cui scia si inseriscono varie altre scrittrici, scrittori e artist*, ricolloca il continente africano con uno spostamento epistemico che mette a punto cartografie sovversive e riempie i polmoni di nuovo ossigeno.
Non è più il sangue l’ossessione delle nostre vampire quotidiane. Piuttosto lo è la riflessione su che ne è dell’umano in un mondo che, travolto dal disagio della postmodernità, allestisce nuove barriere e nuove ferali contrapposizioni. In Gotiche postumane, le vampire messe in scena da Jewelle Gomez, Octavia Butler, Chiara Palazzolo e altre più a noi vicine, abbattendo nuovi e vecchi confini, declinano altre modalità d’essere femministe, lesbiche, vegetariane, intersezionali, poliamorose, transgender e postumane.
Ultimo itinerario Tout se tient è una perlustrazione delle narrative che mettono al centro gli animali. “Mai in sé, sempre con, le specie compagne si riconoscono parziali e aperte e si rendono capaci (respons-abili) a vicenda, e poiché scongiurano – come afferma Federica Timeto – il mito dell’origine, sono in grado di affrontare la propria finitudine. Non si può fare la conta dei morti, dei non morti, dei mai nati, degli scomparsi separando le specie (…) tout se tient”. Da Mary Shelley a Olga Tokarczuk, storie antispeciste per dismettere una perversa catena alimentare» (Giuliana Misserville, aprile 2022).
* * *
Dove ci stiamo dirigendo? gli ho chiesto.
Dipende dalla storia in cui credi, mi ha risposto
(Jeanette Winterson, FRANKISSSTEIN)
Potrebbe sembrare un’acrobazia azzardata avvicinare una scrittrice come Ursula Le Guin al pensiero decoloniale. Lei, donna bianca, eterosessuale, fornita di tutti i privilegi che cultura e famiglia le regalavano, sembrerebbe abitare su un pianeta assai distante da quello di chi riflette su quanto il colonialismo sia implicito ancora oggi nel sistema-mondo cui apparteniamo. Potrebbe risultare completamente estranea. O invece, mostrare sorprendenti anticipazioni, se si accostasse la sua opera a quella di una scrittrice afroamericana come Nora K. Jemisin. Il confronto riuscirebbe a estrarre dai romanzi di Ursula Le Guin, dai racconti e dai saggi, una trama in grado di inserirsi all’interno della riflessione decoloniale che si sta sviluppando ora in Europa e comincia a intravvedersi anche in Italia.
Sono un primo e sommario tentativo queste righe, per quel che mi concerne, di rileggere l’opera di Ursula Le Guin alla luce della riflessione decoloniale. Le narrazioni antirazziste di Le Guin cercano di coniugare le azioni dirette con la non violenza sempre all’insegna della presa di coscienza dei rapporti di forza asimmetrici di tutti i tipi esistenti nell’organizzazione sociale; e dell’assunzione di responsabilità verso gli squilibri che relegano l’altro, sia esso alieno, nero, donna, animale, natura vegetale, fuori dal contesto della «civiltà». Intendendo cogliere, soprattutto, i passaggi attraverso cui i ragionamenti sull’utopia di Le Guin possono aprire il cammino verso un futuro decolonializzato.
Come ha detto nel suo discorso a Roma, al Festival delle letterature, Elaine Castillo:
Sono figlia di una diaspora […] e come a tanti altri simili a me, così mi arrivavano le storie: butterate di vuoti, silenzi, bugie. Che le nostre vite ci siano spesso incomprensibili non è solo un fatto umano, una parte del mistero dell’essere vivi, dello stare al mondo; è anche un elemento fondamentale del retaggio della colonialità. Tra noi c’è chi ha visto le proprie storie rimosse, cancellate o disperse, e mai si è pensato che dovesse rimetterle insieme, tutte quelle cose scheggiate e deformate [1].
 Le cose scheggiate e deformate sono frutto dell’oppressione epistemica agita dall’occidente nei confronti del mondo colonizzato, un imprinting culturale, inscritto nelle nostre cellule, di cui fatichiamo a renderci conto perché come femministe bianche ci siamo preoccupate tanto dei diritti delle donne o di alcune di esse e poco del rapporto tra colonizzatori e colonizzati che ha informato di sé l’occidente. «Facendo della loro esperienza, spesso quella delle donne della classe borghese, un universale, contribuiscono alla divisione del mondo in due: civili/barbari, donne/uomini, bianchi/neri, e la concezione binaria del genere diviene universale» accusa pesantemente Françoise Vergès [2].
Le cose scheggiate e deformate sono frutto dell’oppressione epistemica agita dall’occidente nei confronti del mondo colonizzato, un imprinting culturale, inscritto nelle nostre cellule, di cui fatichiamo a renderci conto perché come femministe bianche ci siamo preoccupate tanto dei diritti delle donne o di alcune di esse e poco del rapporto tra colonizzatori e colonizzati che ha informato di sé l’occidente. «Facendo della loro esperienza, spesso quella delle donne della classe borghese, un universale, contribuiscono alla divisione del mondo in due: civili/barbari, donne/uomini, bianchi/neri, e la concezione binaria del genere diviene universale» accusa pesantemente Françoise Vergès [2].
Come sfuggire a questo immaginario allora, come decolonializzare il proprio sapere? Prendo il termine da Rachele Borghi che nel suo testo sul pensiero decoloniale ci sollecita a una revisione del nostro pensare e agire:
Un’altra grammatica è necessaria per capire dove siamo ora, visualizzare la situazione nel sistema-mondo e immaginare scenari diversi a cui tendere. Questa grammatica c’è e si chiama
teoria/pensiero/critica/approccio/proposta decoloniale. Il pensiero decoloniale non fa riferimento alla decolonizzazione dal colonialismo: fa riferimento alla colonialità. E non riguarda un periodo passato ma ha la forma del presente [3]

Uso gli attrezzi che lei ha approntato e ripercorro l’opera di Ursula Le Guin, un’autrice che – ricordiamolo – ha firmato un romanzo contro la concezione binaria del genere e che sulla razza e sul potere ha avuto, come vedremo, molto da dire. Prova di come a volte la fantascienza sappia farsi portatrice di istanze nuove e nuovi schemi di pensiero. In particolare Ursula Le Guin e Nora K. Jemisin, versano nelle loro pagine l’inchiostro della sovversione, sì sovversione, chiedendo a chi legge di riflettere e prendere posizione rispetto alle asimmetrie che governano il mondo, per immaginare altre utopie.
Guardo alla fantascienza e al fantasy come la spinta aspirazionale dello Zeitgeist: noi creatori siamo gli ingegneri delle possibilità. E poiché questo genere alla fine, per quanto a malincuore, riconosce che i sogni degli emarginati contano e che tutti noi abbiamo un futuro, così andrà il mondo. (Presto spero.) [4]
Leggendo l’opera di Ursula Le Guin ormai arrivata al suo termine e quella di Nora K. Jemisin ancora in corso, è possibile dunque rilevare una strana e singolare affinità, una sorta di dialogo a distanza agito naturalmente dall’autrice afroamericana ma a cui Le Guin non si sottrae [5] grazie alla sua scrittura in grado di sormontare gli anni e i diversi contesti culturali. È soprattutto attorno alle ambiguità del pensiero utopico e sulle questioni del potere e del suo smantellamento, delle differenze di razza e genere, dell’esistenza dell’ingiustizia e di come e se sia possibile eliminarla, che questo dialogo si dipana.
Omelas e il paradosso della tolleranza
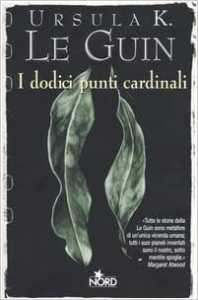 Non solo per ragioni anagrafiche è opportuno partire da “The Ones Who Walk Away from Omelas” [6], un racconto pubblicato da Ursula Le Guin nel 1973. Le Guin ha 44 anni, è nel bel mezzo della ideazione e scrittura del ciclo hainita, che arriverà a comprendere ben otto romanzi e vari racconti. Dal 1966 al 1973 ha scritto cinque romanzi, di cui due segneranno per sempre la SF: nel 1969 The Left Hand of Darkness [7] e nel 1972 The Word for World is Forest [8]. Il 1973 è un anno importante: Le Guin pubblica il racconto “The Ones Who Walk Away From Omelas” mentre è intenta a scrivere il romanzo The Dispossesed: an Ambiguous Utopia [9] che verrà pubblicato l’anno successivo. Il racconto è un apologo, la storia della città felice di Omelas, che però fonda la sua fortuna sulla prigionia di un bambino lasciato a marcire in una oscura cella. Tutti sanno della sua sofferenza ma i più fanno finta di niente; solo qualcuno si ribella e lascia la città. Per andare dove?
Non solo per ragioni anagrafiche è opportuno partire da “The Ones Who Walk Away from Omelas” [6], un racconto pubblicato da Ursula Le Guin nel 1973. Le Guin ha 44 anni, è nel bel mezzo della ideazione e scrittura del ciclo hainita, che arriverà a comprendere ben otto romanzi e vari racconti. Dal 1966 al 1973 ha scritto cinque romanzi, di cui due segneranno per sempre la SF: nel 1969 The Left Hand of Darkness [7] e nel 1972 The Word for World is Forest [8]. Il 1973 è un anno importante: Le Guin pubblica il racconto “The Ones Who Walk Away From Omelas” mentre è intenta a scrivere il romanzo The Dispossesed: an Ambiguous Utopia [9] che verrà pubblicato l’anno successivo. Il racconto è un apologo, la storia della città felice di Omelas, che però fonda la sua fortuna sulla prigionia di un bambino lasciato a marcire in una oscura cella. Tutti sanno della sua sofferenza ma i più fanno finta di niente; solo qualcuno si ribella e lascia la città. Per andare dove?
Gli abitanti di Omelas sanno che la loro felicità ha un costo altissimo e che, come il bambino, non sono liberi.
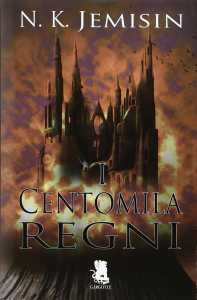 Il secondo racconto, “The Ones Who Stay and Fight” [10], è stato scritto da N.K. Jemisin nel 2018 e per ammissione dell’autrice stessa, è una diretta risposta al racconto di Ursula Le Guin, che Jemisin definisce «una delle ragioni per cui sono oggi una scrittrice» [11]. Jemisin, classe 1972, ha lavorato a lungo come psicologa fino a quando nel 2004 ha esordito nel mondo letterario con alcuni racconti di fantascienza e fantasy. Nel 2010 vince il premio Hugo e Nebula per il racconto “Non-Zero Probabilities” e poi nel 2011 il premio Locus per il miglior romanzo d’esordio con The Hundered Thousand Kingdoms. Tra il 2015 e il 2017 pubblica The Broken Earth Series [12], in italiano tradotta come Trilogia della Terra Spezzata.
Il secondo racconto, “The Ones Who Stay and Fight” [10], è stato scritto da N.K. Jemisin nel 2018 e per ammissione dell’autrice stessa, è una diretta risposta al racconto di Ursula Le Guin, che Jemisin definisce «una delle ragioni per cui sono oggi una scrittrice» [11]. Jemisin, classe 1972, ha lavorato a lungo come psicologa fino a quando nel 2004 ha esordito nel mondo letterario con alcuni racconti di fantascienza e fantasy. Nel 2010 vince il premio Hugo e Nebula per il racconto “Non-Zero Probabilities” e poi nel 2011 il premio Locus per il miglior romanzo d’esordio con The Hundered Thousand Kingdoms. Tra il 2015 e il 2017 pubblica The Broken Earth Series [12], in italiano tradotta come Trilogia della Terra Spezzata.
Anche il racconto di Jemisin descrive una città utopica, felice e magnifica, chiamata Um-Helat, una città i cui abitanti, semplicemente, si prendono cura gli uni degli altri. Una città concepita non solo per generare entrate, energia o prodotti, ma per proteggere e nutrire le persone, perché così è il sentire comune. Ma questa città felice ha il diritto di difendere la propria esistenza?
Nel racconto Jemisin cita esplicitamente Le Guin a proposito del paradosso della tolleranza:
Questo è il paradosso della tolleranza, il tradimento della libertà di parola: esitiamo ad ammettere che alcune persone sono solo fottutamente malvagie e devono essere fermate.
Questa è Um-Helat, dopotutto, e non quella barbara America. Questa non è Omelas, una zecca di città, grassa e felice con la testa sepolta in un bambino torturato [13]
 Il testo di Jemisin, a sua volta pieno di ambiguità di cui poi discuteremo, sposta improvvisamente la nostra lettura di Le Guin poiché illumina di una luce diversa la scelta di abbandonare Omelas: la decisione fortemente etica di lasciare la città per lo sdegno dettato dalla sofferenza impartita al bambino, vero e proprio capro espiatorio, ci appare adesso inadeguata. Jemisin sembra colpire al cuore il pacifismo e la non violenza di Le Guin. Il suo è un ragionamento sul valore e sui limiti dell’utopia svolto in un periodo storico in cui prende corpo l’attivismo politico di Black Lives Matter, perché la parabola del primo presidente nero degli USA, Barak Obama, non è servita a purgare l’America dal suo razzismo. Anni che hanno reso imprescindibile la lettura di un saggio come quello di Judith Butler Can One Lead A Good Life in Bad Life? [14] del 2012, le cui parole ci hanno interpellato direttamente a proposito delle vite che non contano. È avendo questo scenario attorno che scrive Jemisin.
Il testo di Jemisin, a sua volta pieno di ambiguità di cui poi discuteremo, sposta improvvisamente la nostra lettura di Le Guin poiché illumina di una luce diversa la scelta di abbandonare Omelas: la decisione fortemente etica di lasciare la città per lo sdegno dettato dalla sofferenza impartita al bambino, vero e proprio capro espiatorio, ci appare adesso inadeguata. Jemisin sembra colpire al cuore il pacifismo e la non violenza di Le Guin. Il suo è un ragionamento sul valore e sui limiti dell’utopia svolto in un periodo storico in cui prende corpo l’attivismo politico di Black Lives Matter, perché la parabola del primo presidente nero degli USA, Barak Obama, non è servita a purgare l’America dal suo razzismo. Anni che hanno reso imprescindibile la lettura di un saggio come quello di Judith Butler Can One Lead A Good Life in Bad Life? [14] del 2012, le cui parole ci hanno interpellato direttamente a proposito delle vite che non contano. È avendo questo scenario attorno che scrive Jemisin.
Non erano certo più facili gli anni Sessanta di Ursula Le Guin. Gli anni di Richard Nixon, che nel 1969 si insedia alla presidenza degli Stati Uniti [15]; anni che vedono gigantesche manifestazioni, cui la stessa Le Guin prende parte, contro la guerra del Vietnam; e sempre nel 1969 Neil Armstrong mette piede sulla luna e per tre giorni, durante l’estate, la protesta di Stonewall porta alla ribalta i movimenti lgbtq.
I due racconti risentono quindi fortemente dei rispettivi contesti politici e tuttavia ciò che le due scrittrici pongono davanti ai nostri occhi riguardano le questioni scottanti che coinvolgono la nostra sete di speranza e il prezzo che siamo dispost* a pagare. Quali costi emotivi, sociali, economici, etici comporta l’agire utopico? Quali rischi? Perché la distopia non è solo una componente intima del pensiero utopico [16] ma è stata un risvolto tragico che la storia spesso ci ha riservato.
«Pugni in faccia alla fantascienza»
Il testo di Jemisin chiama in causa le differenze di razza, di religione e di genere; le rovine attorno a Um-Helat raccontano di un tempo passato in cui le divergenze di opinioni o aggettivi come grasso, sordo o nero comportavano differenze di rispetto. Perché una volta il valore e l’umanità venivano attribuiti ad alcune persone, e ad altre no.
La metafora di Le Guin tratta della sofferenza e del dolore alludendo direttamente alle nostre vite. Il tema del razzismo e i guasti del colonialismo sono stati sviluppati da Le Guin in vari passaggi della sua opera. In The Word for World is Forest del 1972, il razzismo dei terrestri che hanno invaso un altro pianeta, New Tahiti, per depredarlo non ha argini e il capitano Davidson sa bene come trattare i nativi, i creechie che prima dell’invasione vivevano in sintonia col mondo vegetale:
 – Preferirei togliermeli dai piedi, capitano
– Preferirei togliermeli dai piedi, capitano
– I creechie? Che cosa intendi dire, Ok?
– Semplicemente di lasciarli andare. Non riesco a ottenere abbastanza lavoro da loro, alla segheria, per compensare quello che mangiano. O per compensare il maledetto grattacapo che sono. Non lavorano, e basta.
– No, lavorano se sai farli lavorare. Hanno costruito il campo.
Il volto di ossidiana di Oknanawi era arcigno.
– Be’, voi dovete avere il tocco magico con i creechie, credo. Io non l’ho. – Tacque. – In quel corso di Storia Applicata che ho fatto nell’addestramento per Oltre-spazio, dicevano che lo schiavismo non ha mai funzionato. Era antieconomico.
– Giusto, ma qui non si tratta di schiavismo, Ok, ragazzo mio. Quando allevi mucche, lo chiami schiavismo? No. E il sistema funziona.
Impassibile, il caposquadra annuì; ma disse: – Sono troppo piccoli. Ho cercato di affamare quelli più intrattabili. Ma si limitano a starsene immobili e a lasciarsi morire di fame.
– Sono piccoli, certo, ma non devi lasciarti fregare da loro, Ok. Sono duri; hanno una resistenza terribile; e non provano il dolore come gli uomini. Questa è la parte che tu dimentichi, Ok. Tu pensi che colpirne uno sia come colpire un bambino, più o meno. Credimi, è invece come colpire un robot, per quello che sentono. Senti, tu ti sei fatto qualcuna delle femmine, e sai che ti danno l’impressione di non provare nulla, né piacere né dolore, si limitano a starsene lì come materassi, qualunque cosa uno faccia. E tutti i creechie sono uguali. Probabilmente hanno nervi più primitivi di quelli dell’uomo. Come i pesci [17].
Il passaggio esemplifica il pensiero di Le Guin sul razzismo e anche l’equiparazione tra creechie e bestiame rimanda alla teoria antispecista su cui si è soffermata anche Rachele Borghi: «La definizione di specismo come il dare diverso valore e status morale agli individui in base unicamente alla loro specie di appartenenza mi appare in tutta la sua violenza, non solo verso le persone non umane ma anche umane»[18]. Il personaggio di Lyubov, l’antropologo che cerca di cogliere la visione del mondo dei nativi, dimostra che la loro cultura si basa su categorie differente da quelle dei terresti ma non per questo ha meno valore; anzi i nativi vivono la natura come un ecosistema di cui fanno parte e che struttura la loro società, al contrario dei terrestri per cui la natura è solo un oggetto da predare.
Tornando a Jemisin, grande è la sua capacità di giocare coi diversi piani entrando e uscendo dal racconto per rivolgersi direttamente a noi. Ci tira dentro Jemisin, per farci realizzare quanto in noi possa essere radicato e interiorizzato il razzismo, il sessismo, l’omofobia, la crudeltà e la paura al punto che potremmo sentirci minacciat* dall’idea di uguaglianza (prendere coscienza dei nostri privilegi, ci raccomanda il pensiero decoloniale) realizzata a Um-Helat. È un passaggio potente che parla della realtà che abbiamo attorno e che implica anche un’analisi impietosa sul mondo della fantascienza troppo bianco e machista per lungo tempo. Occorrono quindi nuovi paradigmi e nuove rappresentazioni che mettano in scena personagge non bianche e non etero – afferma Jemisin in un dialogo rintracciabile su youtube [19] – «Pugni in faccia alla fantascienza», li definisce Jemisin, rivoluzionari, se guardati dal punto di vista delle donne nere.
 Su questo Ursula Le Guin, che ha messo un nero, il terrestre Genly Ai, al centro del romanzo The Left Hand of Darkness ed era il 1969, è più volte intervenuta ricordando come dovesse battersi a ogni nuova copertina per non far rappresentare i suoi personaggi con la pelle bianca [20].
Su questo Ursula Le Guin, che ha messo un nero, il terrestre Genly Ai, al centro del romanzo The Left Hand of Darkness ed era il 1969, è più volte intervenuta ricordando come dovesse battersi a ogni nuova copertina per non far rappresentare i suoi personaggi con la pelle bianca [20].
Che il significato dei due racconti sia molto più ampio di quanto appaia a una prima lettura è sottolineato da Nora K. Jemisin secondo la quale Le Guin non sostiene che l’unica soluzione sia allontanarsi da Omelas: «Non è proprio quello che sta dicendo, nello specifico, ma è ciò che molte persone hanno concluso»; d’altra parte sul significato del racconto di Le Guin, studiose e studiosi si sono accapigliati a lungo. La voluta ambiguità del racconto si replica nell’ambiguità di Um-Helat anche se in tutt’altra forma. Perché siamo sempre di fronte allo stesso quesito: può tenere l’utopia alla prova della realtà a costo di trasformarsi in una distopia? E poi l’ambivalenza tra utopia/distopia, non scaturisce soprattutto da dove collochiamo il punto di vista, dal nostro posizionamento?
Essere la rivoluzione
![I sogni si spiegano da soli: Immaginazione, utopia, femminismo (BIGSUR) di [Ursula K. Le Guin, Veronica Raimo]](https://m.media-amazon.com/images/I/41rfNDd1wsL.jpg) Come uscire da queste trappole epistemiche diventa l’oggetto di “A Non-Euclidean View of California as a Cold Place to Be” [21], un saggio del 1982 in cui Le Guin esplicita come dietro al suo racconto ci siano reminiscenze di Dostoevskij [22] e come sia necessario cercare di evadere dalla dicotomia felicità/libertà del grande inquisitore.
Come uscire da queste trappole epistemiche diventa l’oggetto di “A Non-Euclidean View of California as a Cold Place to Be” [21], un saggio del 1982 in cui Le Guin esplicita come dietro al suo racconto ci siano reminiscenze di Dostoevskij [22] e come sia necessario cercare di evadere dalla dicotomia felicità/libertà del grande inquisitore.
Una variante di quella dicotomia viene da Jemisin e riguarda la liceità di usare la forza per difendersi (ricordate il paradosso della tolleranza?), per difendere la città felice di Um-Helat. Per garantire il perdurare di questa felicità, occorre che alcune persone, i custodi, si prendano la briga di difendere la comunità e gli abitanti di Um-Helat sono talmente pragmatici da riconoscere questa necessità. C’è un giardino dove vengono ospitati (sepolti) coloro che hanno infranto la legge. «Solo perché devono morire come deterrenza non significa che non possano essere onorati per il sacrificio». Così scrive Jemisin e ci tende la mano alla fine del racconto perché anche noi, come la bambina che ha assistito all’esecuzione del padre, dobbiamo essere educati. Jemisin ha costruito per noi quella che chiama «un’utopia postcoloniale con i denti insanguinati»; ci chiede di guardarla, per capire e lavorare assieme.
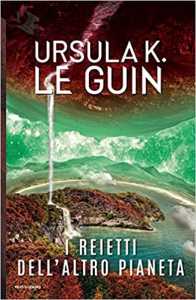 Torna di continuo l’idea di non compiutezza, imperfezione, ambiguità quando si parla di utopia perché sembrerebbe il solo modo di farla esistere. The Dispossessed del 1974 è forse il testo in cui maggiormente Le Guin ha riflettuto sull’utopia politica per eccellenza, l’anarchia:
Torna di continuo l’idea di non compiutezza, imperfezione, ambiguità quando si parla di utopia perché sembrerebbe il solo modo di farla esistere. The Dispossessed del 1974 è forse il testo in cui maggiormente Le Guin ha riflettuto sull’utopia politica per eccellenza, l’anarchia:
Con l’anarchismo (pacifista e nonviolento) ero completamente in sintonia, proprio come mi era sempre successo con il taoismo (tra i due un rapporto c’è, quantomeno di affinità). L’anarchismo è l’unico pensiero politico che mi faccia sentire a mio agio, e in questi tempi si ricollega in maniera sempre più interessante con l’etologia e con la psicologia animale (proprio come aveva previsto Kropotkin) [23].
Più che ambigua, l’utopia di The Dispossessed appare a Darko Suvin una utopia dinamica, aperta, che dimostra l’utopicità di Anarres non nella raggiunta perfezione ma nell’ammissione di fallibilità, nel continuo (in prospettiva incessante) procedere verso un orizzonte in costante ridefinizione [24]. Un moto dello spirito, come del resto la rivoluzione predicata da Shevek: «Non potete prendere ciò che non avete dato, e dovete dare voi stessi. Non potete comprare la Rivoluzione. Non potete fare la Rivoluzione. Potete soltanto essere la Rivoluzione. È nel vostro spirito, oppure non è in alcun luogo» [25].
Essere la rivoluzione. Mentre il mondo va in pezzi, cercare nuove ragioni per essere comunità. Quando Jemisin impugna la penna la sua visionarietà è ancora più radicale e del resto ne ha tutte le ragioni. Come precisa Nicoletta Vallorani:
 Jemisin appartiene a un segmento della società statunitense che è dovuta pervenire alla consapevolezza di essere stata e di restare una componente minoritaria, meno protetta dalla legge (anzi, come hanno dimostrato ancora una volta eventi recenti, abusata da essa), messa nella condizione di subire un trattamento poco equo senza poter invocare protezione, considerata, in sintesi, come meno che umana. Quando evoca il 13° emendamento come un obiettivo ancora non realizzato, la scrittrice intende dimostrare appunto che per gli afroamericani la società statunitense di oggi è ancora una distopia [26].
Jemisin appartiene a un segmento della società statunitense che è dovuta pervenire alla consapevolezza di essere stata e di restare una componente minoritaria, meno protetta dalla legge (anzi, come hanno dimostrato ancora una volta eventi recenti, abusata da essa), messa nella condizione di subire un trattamento poco equo senza poter invocare protezione, considerata, in sintesi, come meno che umana. Quando evoca il 13° emendamento come un obiettivo ancora non realizzato, la scrittrice intende dimostrare appunto che per gli afroamericani la società statunitense di oggi è ancora una distopia [26].
La trilogia de La terra spezzata racconta una schiavitù che è ancora tra noi e non solo perché come occidentali l’abbiamo interiorizzata. Anche qui abbiamo una città felice, Syl Angist, costruita su una razza sfruttata (gli orogeni) e utilizzata per tentare di tenere sotto controllo il pianeta che si sta ribellando con continui e sempre più devastanti terremoti. Anzi piccoli orogeni sono tenuti prigionieri in stato vegetativo nei fulcri disseminati per il pianeta, per controllare, anche ridotti allo stremo, l’attività sismica. Sono corpi che non contano e il pensiero corre immediatamente a Omelas, anche se Jemisin riconosce che
E anche se all’epoca non me ne rendevo conto, la gente mi ha fatto notare che la saga di Broken Earth è fondamentalmente “The Ones Who Walk Away from Omelas” ampliato. La sua influenza è in tutto il mio lavoro, emerge in modi che non ho nemmeno notato fino a molto tempo dopo [27].
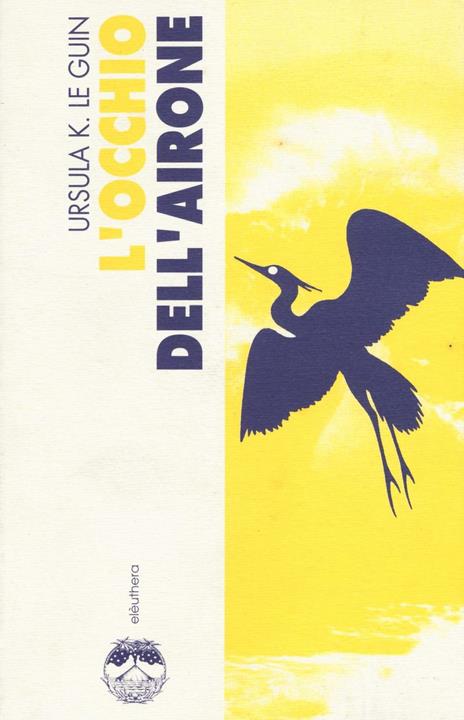 Non starò a inoltrarmi nella trilogia di Jemisin rimandando per questo allo splendido saggio già citato di Vallorani. Solo vorrei far notare quanto fertile e seminale sia stato il lavoro di Ursula Le Guin, che non si stancava di riflettere e rimuginare sulla sua narrativa e sui legami che questa intratteneva con la realtà. Ho già detto di “A Non-Euclidean View …” In quelle pagine, la scrittrice di Portland torna a distanza di alcuni anni al ciclo dell’Ecumene – una sorta di intertesto sulle varie forme di utopia – le cui storie si articolavano sulla giustizia (“The Ones Who Walk Away From Omelas”, 1973), sul razzismo (The Word for World is Forest, 1972) sulla non violenza (The Eye of the Heron [28], 1978; questo romanzo si pone anche in maniera esemplare a dimostrare come «le reti di affetti tra soggetti subalterni diventano strumenti di resistenza» [29]) e sull’anarchismo (The Dispossessed e The Day Before the Revolution [30] del 1974), e infine sul rifiuto di una società strutturata sui binarismi di genere (The Left Hand of Darkness, 1969).
Non starò a inoltrarmi nella trilogia di Jemisin rimandando per questo allo splendido saggio già citato di Vallorani. Solo vorrei far notare quanto fertile e seminale sia stato il lavoro di Ursula Le Guin, che non si stancava di riflettere e rimuginare sulla sua narrativa e sui legami che questa intratteneva con la realtà. Ho già detto di “A Non-Euclidean View …” In quelle pagine, la scrittrice di Portland torna a distanza di alcuni anni al ciclo dell’Ecumene – una sorta di intertesto sulle varie forme di utopia – le cui storie si articolavano sulla giustizia (“The Ones Who Walk Away From Omelas”, 1973), sul razzismo (The Word for World is Forest, 1972) sulla non violenza (The Eye of the Heron [28], 1978; questo romanzo si pone anche in maniera esemplare a dimostrare come «le reti di affetti tra soggetti subalterni diventano strumenti di resistenza» [29]) e sull’anarchismo (The Dispossessed e The Day Before the Revolution [30] del 1974), e infine sul rifiuto di una società strutturata sui binarismi di genere (The Left Hand of Darkness, 1969).
Le Guin mischia nel suo saggio critica letteraria, pensiero antropologico, critica sociale e utopia: ci mette sotto il naso gli studi di suo padre Alfred Kroeber sui popoli nativi della California per dimostrare quanto arbitraria sia la nostra concezione dello spazio sociale e delle strutture politiche che pensiamo naturali, di come il centro del mondo sia un bluff e la sua circonferenza sia ovunque, cosa che ricorda la descrizione della cultura su New Tahiti.
Secondo Ursula Le Guin l’utopia euclidea (l’utopia dalle geometrie chiare, organizzate razionalmente, e perfettamente riproducibili) è giunta al capolinea. È un’argomentazione che risuona stranamene simile alla riflessione di Rachele Borghi:
Il pensiero cartesiano occidentale, infatti si fonda su binomi quali cultura/natura, buono/cattivo, identità/differenza, io/altro e quindi anche uomo/donna. Al primo termine è concesso il privilegio di definire ciò che è, e di relegare all’altro tutto ciò che non è […] Accettare la proposta decoloniale: uscire di casa coi calzini spaiati, calpestare la ragione cartesiana [31].
Ora – continua Le Guin – se vogliamo rigettare il dannato binarismo della scelta tra felicità e libertà che ci ha condotto sull’orlo dell’abisso, dobbiamo percorrere sentieri non mappati, i sentieri del coyote, difficili da individuare, ancora più difficili da percorrere. Non ci sono visioni del mondo universalistiche a cui appoggiare conformismi e acquiescenza ai poteri dati. Bisogna gettare vie le mappe esistenti e … lasciare andare l’immaginazione. Haraway scriverà qualche anno dopo della necessità di inventare «futuri prossimi, futuri possibili, e presenti poco plausibili ma reali» [32]. E ancora Françoise Vergès: «Vogliamo applicare un pensiero utopico, inteso come energia e forza di sollevazione, come presenza e invito ai sogni di emancipazione e come gesto di rottura: osare pensare oltre ciò che si presenta come “naturale”, “pragmatico”, “ragionevole”» [33]. Oltre! appunto.
Ma al momento l’inquisitore (il realismo politico strutturato cui gli uomini affidano la loro vita) sbarra il cammino e sembra che non ci sia soluzione. Dobbiamo scavare un sentiero che conduca oltre di lui, oltre la sua apparente inamovibilità, rischiando il tutto per tutto e con la sola certezza che quando usciremo, oltre l’abisso, saremo cambiati. Scrive Le Guin in quel saggio del 1982:
Non ho idea di chi saremo o come potrebbe essere dall’altra parte, però credo che ci siano persone lì. Hanno sempre vissuto lì. Ci sono canzoni che cantano lì; una delle canzoni si intitola Dancing at the edge of the world [34].
È quasi commovente la scommessa di Le Guin sul fatto che l’umanità riesca a uscire dall’altra parte dell’abisso, leggerla è sentire il lavorio della speculazione femminista, quello che lei chiamava «esperimento mentale». Un esperimento assolutamente necessario poiché l’immaginazione crea e modifica la lettura della realtà che abbiamo attorno e la realtà a venire. E i «risultati» di quell’esperimento non sono risposte ma domande, non ipotesi ma sussurri e grida di disperazione, amore, dolore, coraggio.
Note
[1] Potete leggere il discorso pronunciato da Elaine Castillo il 18 giugno 2019 andando su: https://www.iltascabile.com/letterature/il-futuro-decoloniale/
[2] F. Vergès, Un femminismo decoloniale, ombre corte, Verona 2020, pp. 39-40.
[3] R. Borghi, Decolonialità e privilegio, Meltemi, Milano 2020, p. 36.
[4] N. K. Jemisin, Discorso di accettazione del premio Hugo 2018 per il miglior romanzo, su https://www.youtube.com/watch?v=8lFybhRxoVM
[5] Ho notizia di una sola lettera indirizzata da Ursula Le Guin a Nora K. Jemisin, pochi mesi prima del gennaio 2018, come ringraziamento per la recensione sul «New York Times» a una raccolta di racconti di Le Guin. Ne parla Jemisin in un tweet del 23 gennaio 2018.
[6] U. Le Guin, The Ones Who Walk Away From Omelas, in The Wind’s Twelve Quarters and The Compass Rose, Harper & Row, New York 1975. trad. it. Quelli che si allontanano da Omelas in I dodici punti cardinali, Editrice Nord, Milano 1979. traduzione di Roberta Rambelli,
[7] U. Le Guin, The Left Hand of Darkness, Ace books, New York 1969, trad it. La mano sinistra del buio, Mondadori, Milano 2021, traduzione di Chiara Reali.
[8] U. Le Guin, The Word for World is Forest, in Harlan Ellison (ed.), Again, Dangerous Visions, Doubleday 1972, trad. it. Il mondo della foresta, Editrice Nord, Milano 1976, traduzione di Riccardo Valla.
[9] U. Le Guin, The Dispossessed: an Ambiguous Utopia, Harper & Row, New York 1974, trad. it. I reietti dell’altro pianeta, Mondadori, Milano 2019, traduzione di Riccardo Valla.
[10] N. K. Jemisin, The Ones Who stay and Fight, in How Long ‘Til Black Future Month?, Orbit Books, New York 2018.
[11] Tweet del 23 gennaio 2018, traduzione mia.
[12] La trilogia è così composta: The Fifth Season (2015), The Obelisk gate (2016), The Stone Sky (2017), tradotti in italiano da Alba Mantovani (La quinta stagione, Il portale degli obelischi e Il cielo di pietra) e editi da Mondadori.
[13] N. K. Jemisin, The Ones Who stay and Fight, cit., pp. 11-19; traduzione mia.
[14] Edizione italiana: Judith Butler, A chi spetta una buona vita, a cura di Nicola Perugini, Nottetempo, Milano 2013.
[15] Richard Nixon si dimetterà nel 1974 per evitare l’impeachment per lo scandalo Watergate.
[16] Cfr. il numero di «Leggendaria» n. 143/2020 MIXTOPIA sui rapporti tra femminismo, utopia e fantascienza.
[17] U. Le Guin, Il mondo della foresta, cit., pp. 9-10.
[18] R. Borghi, Decolonialità, cit., p. 121.
[19] Si tratta di un dialogo tra Nora K. Jemisin, Anne Leckie e la conduttrice Ellen Wright, del 9 dicembre 2014. Potete ascoltarlo su: https://www.youtube.com/watch?v=jKJjei9Mwe0
[20] M. Killjoy, Anarchia, letteratura e femminismo. Intervista a Ursula K. LeGuin , in Miti & Molotov. Interviste su anarchia e narrativa, Contrabbandiera, Firenze 2020.
[21] Lo trovate nella raccolta di saggi di Ursula Le Guin, Dancing at the Edge of the World: Thoughts on Words, Women, Places, Grove Press, New York 2017. In it. Una visione non-euclidea della California come luogo freddo, in Ursula Le Guin, I sogni si spiegano da soli. Immaginazione, utopia, femminismo, a cura di Veronica Raimo, SUR, Milano 2022, pp. 74-105.
[22] La leggenda del grande inquisitore è inserita ne I fratelli Karamazov. L’inquisitore rimprovera Cristo per aver voluto portare la libertà a un popolo incapace di usufruirne e la Chiesa si è fatta carico dell’unica possibilità di rendere gli uomini felici, togliendo loro la libertà. Ma il ritorno di Cristo danneggia quest’ordine raggiunto. E quindi l’inquisitore domanda a Cristo: perché sei venuto a infastidirci?
[23] M. Killjoy, Anarchia, letteratura e femminismo, cit.
[24] Sarebbe interessante approfondire (cosa che qui non sono riuscita a fare) se e come l’utopia imperfetta abbia qualche punto in comune con l’utopia razionale di John Rawls che negli anni Sessanta, gli stessi in cui stava scrivendo Ursula Le Guin, pubblicò A Theory of Justice. Ma siamo nell’ambito del pensiero liberale e il salto verso il pensiero anarchico rischierebbe di cadere nel vuoto.
[25] U. Le Guin, I reietti dell’altro pianeta. Un’ambigua utopia, traduzione di Riccardo Valla, Mondadori, ed. elettronica.
[26] A. Pasolini – N. Vallorani, Corpi magici, Mimesis Edizioni, Milano 2021, pp.140-141.
[27] Tweet del 23 gennaio 2018, traduzione mia.
[28] trad. it. L’occhio dell’airone-Il giorno prima della rivoluzione, Elèutera, Milano 1997, traduzione di Roberta Rambelli.
[29] R. Borghi, op. cit. p. 136.
[30] trad. it. L’occhio dell’airone-Il giorno prima della rivoluzione, cit.
[31] Ivi, pp. 52-53.
[32] D. Haraway, Chthulucene. Sopravvivere su un pianeta infetto, Nero, Roma 2019, ed. elettronica.
[33] F. Vergès, Un femminismo, cit., p. 115. [34] U. Le Guin, A Non-Euclidean View of California as a Cold Place to Be, in Dancing… op. cit., trad. mia.



