Al passato si scrivono i nomi,
al passato quasi tutti i verbi,
al passato i nomi dei luoghi, ma invece la guerra
si scrive al presente
ed è sempre minuscola (1)
Nei giorni di fine agosto 2022, mentre questi versi inediti uscivano in traduzione italiana, un locale di Milano cancellava improvvisamente dal proprio calendario il concerto di una rock band ucraina, i Sobaki.
Motivazione ufficiale: il tour europeo del gruppo era finalizzato a raccogliere fondi per l’acquisto di automobili destinate all’esercito, quindi violava presunti obblighi di imparzialità che i gestori del locale sostenevano essere stabiliti per legge nel nostro Paese.
L’aspetto curioso è che l’autore di quei versi e il cantante di quella band sono la stessa persona: Serhij Viktorovyć Zhadan, probabilmente il più importante intellettuale ucraino vivente.
Nato nel 1974 a Starobil’s’k, in Donbas – precisamente nella regione di Luhans’k, da nove anni occupata dalle milizie filorusse – Zhadan si forma culturalmente nel variegato scenario urbano di Kharkiv, città che ha vissuto più di altre l’intero spettro di aspre contraddizioni legate alla fine del mondo sovietico.
Tra queste, lo sviluppo di una lingua e di una letteratura nazionale plurisecolari, radicate al punto da essere fortemente valorizzate persino nella korenizacija voluta da Lenin alle origini dell’URSS.
Seppur circondata dalla bellezza architettonica delle università, dei musei e dei conservatori, la post soviet generation cui appartiene Zhadan, sceglie deliberatamente di radicarsi nella crisi, e con essa nella desolazione periferica seguita al crollo.
Aver vissuto il tramonto del socialismo reale in piena adolescenza ha permesso a questa leva di creare un topos narrativo incentrato sull’età proustianamente perduta, da ricercare attraverso malinconie e attese, ricordi, ritorni e allontanamenti, nei quali la fratellanza di strada diventa mito fondante, soppiantando definitivamente quella politica universale del proletariato e dei pionieri
All’inizio degli anni ’80 dal suo appartamento passò tutta la gioventù progressista del quartiere: i ragazzini conquistavano la virilità, le ragazze l’esperienza.
Koča beveva sempre di più e lo sfascio del paese gli passò accanto senza che se ne accorgesse.
All’inizio degli anni ’90, siccome non esisteva più il Komsomol, toccò alle forze dell’ordine occuparsi di lui. Una volta, nei suoi perenni allegri bagordi, Koča bruciò l’insegna pubblicitaria di una nuova società per azioni. Lo presero nel suo appartamento. Quando lo portarono fuori si era radunata una piccola manifestazione. Noi, ragazzi del quartiere ormai cresciuti, eravamo per Koča. Nessuno però ci dava retta. (2)
La rapida chiusura delle prospettive alimentate dall’indipendenza del 1991 ha quindi accompagnato questa stessa generazione verso l’età adulta.
E come accade per ogni altro fallimento politico su scala nazionale, anche in Ucraina l’involuzione degli ideali in retorica d’accatto ha prodotto una straordinaria occasione di sviluppo per la letteratura rivolta ai deserti contemporanei e all’umanità di scarto.
Nel caso di Serhij Zhadan, il disincanto artistico in versi e in prosa è stato favorito dal recupero del cosiddetto “Rinascimento fucilato” (ovvero dei geniali artisti ucraini d’avanguardia degli anni ’20/’30 ferocemente spazzati via da Stalin), sul cui fusto lo scrittore ha saputo innestare le migliori influenze occidentali: dal pop al calcio, dal rock al punk (3).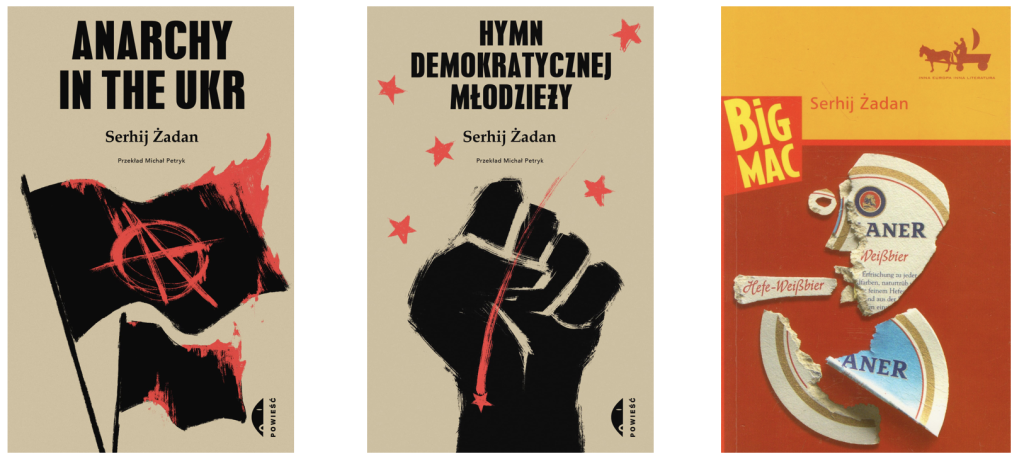
… anche loro hanno cominciato come normali allegri abitanti delle nostre città e villaggi, non potevano essere dall’inizio quei coglioni depressi di adesso, che hanno cinquanta, sessant’anni. Allora dove è iniziata la loro grande depressione personale, dove sono le sue origini? […] I Soviet gli hanno spremuto tutto ciò che c’era di umano, trasformandoli in prefabbricati per lo zio Sam, ecco quello che penso.(4)
I romanzi di Zhadan si sviluppano sulla continua alternanza tra ingenui tentativi di riscatto e inevitabili sconfitte, spesso determinate dalle ipoteche che il passato riscuote nel presente.
I suoi personaggi sono sempre sul punto di evadere, di trovare una traccia di saggezza e un filo rosso che li porterebbe dritti verso una qualche forma di felicità: ma anche quando oltrepassano i limiti a loro riservati o sfondano una quarta parete, non giungono mai ad una meta; non acquisiscono una dimensione epica, sfacciatamente redentiva o degna di un romanzo di formazione.
Il massimo cui possono aspirare nella loro morbida prigionia urbana è la catarsi ironica: un’illuminazione breve, la coda di una meteora, per fingere di essere precipitati direttamente da un’opera di Kafka o di Camus.
A fare da sfondo stagionale degli intrecci sono spesso le estati di Kharkiv o del Donbas, interamente calate in un’atmosfera sospesa, rarefatta, colma di miraggi o di allucinazioni.
Nei suoi versi, d’altro canto, Zhadan adotta un io lirico certamente influenzato dagli autori che lui stesso ha tradotto in ucraino – in particolare Paul Celan, Charles Bukowski, Rainer Maria Rilke. Questo io però lo immerge sistematicamente nella melancholia di un presente inafferrabile, che non prevede alcuna velleità di cambiamento. Le poesie di Zhadan ritmano quindi come dei veri e propri blues introspettivi, una simbiosi di fragilità e consapevolezza.
E ogni parola, come sabbia sonora,
è rimasta attaccata alla tua gola
perchè tu possa pronunciarla
con la tua lingua (5)
Ad una distanza infinita dalla sua poetica e dai suoi personaggi sta invece l’attivista Serhij Zhadan, in prima linea durante tutti i principali sconvolgimenti politici che hanno attraversato l’Ucraina negli ultimi trent’anni.
Impegnato nella fondazione di circoli d’avanguardia (come il Červona fira) ai tempi dell’indipendenza, Zhadan ha incarnato il modello dell’agit-prop di matrice beat americana, organizzando happening, sit-in, concerti, reading, flash mob dall’epoca della cosiddetta “Rivoluzione arancione” del 2004 fino all’EuroMajdan del 2014, divenendo per questo uno dei bersagli prediletti dello squadrismo filorusso.
Dal 24 febbraio 2022, giorno nel quale il tour bus dei Sobaki dovette precipitosamente far ritorno a Kharkiv, Serhij Zhadan ha deciso di sfruttare la sua duplice fama di scrittore e musicista, utilizzando ogni canale disponibile per attirare l’attenzione internazionale sulla sua città – che come era già avvenuto nel 2014, stava per cadere dopo pochissimi giorni di conflitto.
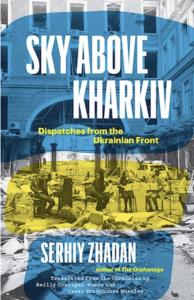
Poesie inedite, video in diretta sotto i bombardamenti, concerti nelle stazioni della metro, crowfunding per la difesa territoriale, dibattiti sulla cultura russa utilizzata come strumento di colonialismo culturale: tutto questo ha portato Zhadan a diventare una vera celebrità nell’intera Europa centrale e settentrionale, fino ad essere insignito del titolo di “Uomo dell’Anno” dalla Gazeta Wyborcza, il giornale polacco sul quale scriveva la poetessa Premio Nobel Wislawa Szymborska.
Di questa enorme rilevanza continentale, in Italia nell’ultimo anno non sono giunti nemmeno gli echi.
Forse perchè anche del vasto corpus di pubblicazioni di Zhadan (undici raccolte di poesia, altrettanti volumi tra romanzi e racconti, testi saggistici, articoli, ecc…) nel nostro Paese è giunto pochissimo, a differenza di quanto avvenuto in Germania e in Inghilterra.
Va quindi reso omaggio a piccole realtà editoriali come Castelvecchi, Voland e Elliot, per aver introdotto (e oggi riproposto) nel nostro panorama culturale un autore meritevole di ben altra visibilità, inadatto alle miscellanee collettive approntate frettolosamente agli inizi di ogni guerra e realizzate soltanto per mostrare al mondo un campionario delle “voci migliori” di un Paese, con la prospettiva di dimenticarlo presto.
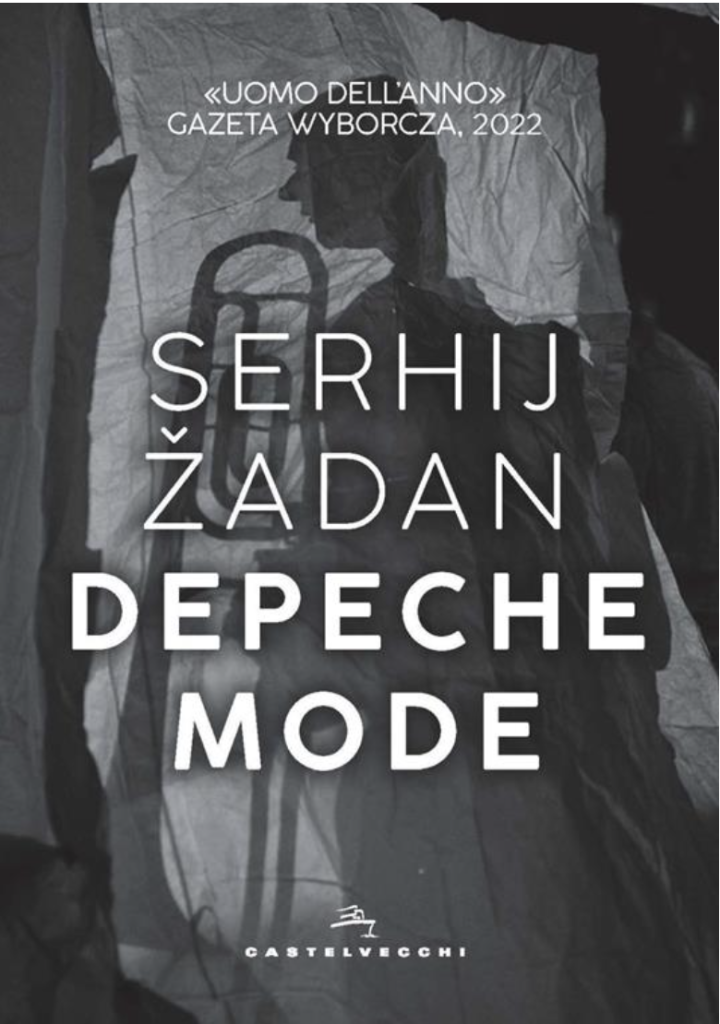
La lost youth di Kharkiv ad appena due anni dall’indipendenza (il romanzo è ambientato nel 1993) è rappresentata con lo stile ed il ritmo di un film sperimentale, in cui la cinepresa è tenuta a mano lungo le strade.
Zhadan si ritaglia un’introduzione-confessione d’autore datata 15 febbraio 2004, lasciandoci intendere che nel bilancio retroattivo del decennio mancheranno gli anni più infuocati – che inizieranno nel novembre 2004, con l’inizio della “Rivoluzione arancione”.
… c’erano due cose delle quali si poteva andare orgogliosi: il campionato di calcio e le armi atomiche, e coloro che hanno privato il popolo di queste attrazioni dubito che li attenderà una tranquilla vecchiaia indisturbata, nulla infiacchisce il karma quanto la politica nazionale idiota
Sobaka Pavlov (ebreo antisemita), Kakao, Karburator, il Piccolo Chuck Berry, Čapaj, Vasja Komunist formano una ridicola gang di ragazzini ubriachi dedita alla microcriminalità di quartiere e al contrabbando di alcol lungo la ormai permeabile frontiera con la Russia.
Incapaci di creare un vero business illegale, si muovono tra lo stadio del Metalist – la squadra di Kharkiv – le stazioni ferroviarie, i sottoscala, le soffitte trasformate in rifugi e decine di appartamenti altrui sfruttati come nascondigli.
Il mondo adulto al di sopra di loro è una jungla di fiere feroci: poliziotti, ex membri del Partito corrotti, criminali veri, maniaci sessuali, fanno da controcanto alla perdizione giovanile vissuta come dazio in nome della transizione storica.
Un giorno Karburator scompare, e il resto della gang deve trovarlo per metterlo al corrente della scomparsa del patrigno. La surreale ricerca dell’amico sarà costellata di centinaia di contrattempi e separazioni, infinite riflessioni sul marxismo, scontri con la comunità Rom (le cui iconografie religiose pervaderanno la psiche del narratore), guide cartacee per fabbricare potenti ordigni artigianali e infine l’ideazione di un furto epocale di denaro nella sede dell’ex Comitato di Partito, in una fabbrica dismessa.
Furto che si concluderà, alla maniera de I soliti ignoti, con un bottino imprevisto: non la pasta e fagioli, bensì il busto di …
“Forse è il direttore?” dice Sobaka.
“No” fa Čapaj “Il direttore non ha i baffi”
“È qualche marxista” suppongo io.
“Trotsky” dice Sobaka “Guada che naso! È sicuramente Trotsky!”
“Non è Trotsky” si innervosisce Čapaj “Trotsky aveva la barbetta. E questo non ha la barba”
“È Trotsky in Messico” fa Sobaka.
“Non è affatto Trotsky” si erge Čapaj, sforzandosi di nascondere la sua agitazione. “È Molotov! Che di tutti quelli era l’unico tipo normale. Era un edonista, come Tito”
Il titolo del romanzo – Depeche Mode – non allude a un concerto o a una comparsa concreta della celebre band inglese a Kharkiv. È invece riferito ad una surreale trasmissione radiofonica di stampo musicale che nel tracciare la biografia del gruppo fa credere che Dave Gahan & C. siano figli di militanti dell’IRA e tutta la loro vita sia stata spesa per la difesa della causa irlandese.
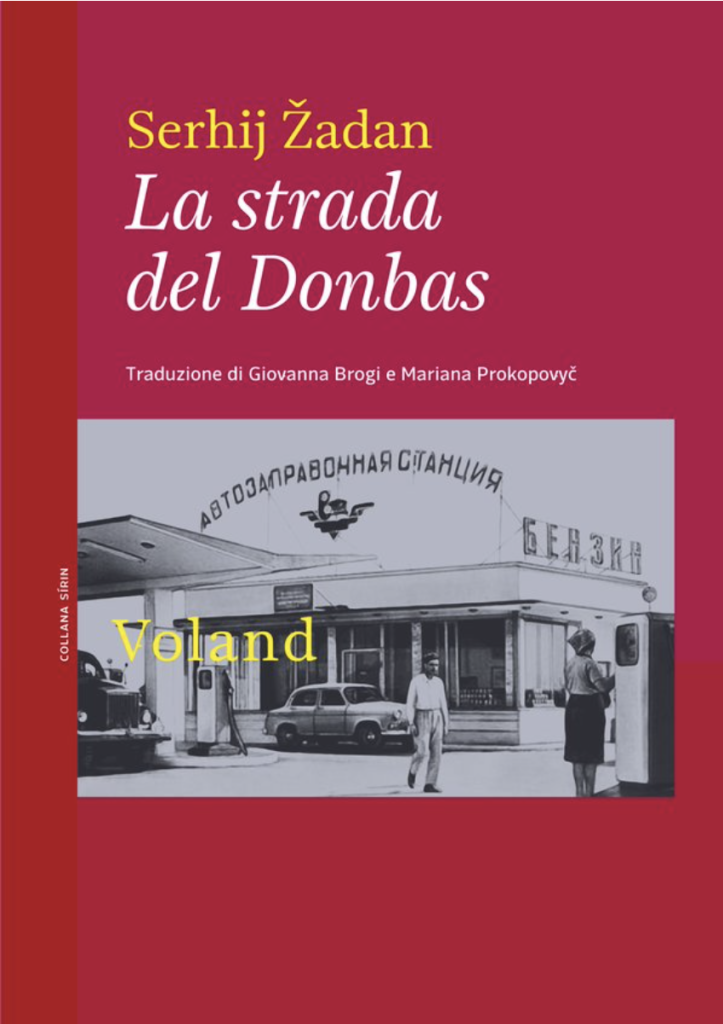
Nell’Ucraina orientale non esiste una Route 66 che faccia della regione del Donbas un punto di approdo per i moderni grappoli dell’odio. Esistono, invece, innumerevoli strade dissestate, mulattiere e percorsi rurali conosciuti soltanto da chi in quei luoghi ci ha trascorso o sprecato la vita.
In una delle statali abbandonate alla calura estiva in quel sud-est sorge una stazione di servizio che viene improvvisamente abbandonata dal proprietario, fuggito ad Amsterdam (forse). Il fratello Herman – pubblicitario senza entusiasmi, da anni residente a Kharkiv – viene informato della scomparsa: essendo lui il vero intestatario dell’attività, decide di andare a verificare la situazione di persona.
Sarà un ritorno alle origini scandito dalle memorie intense dell’età perduta, simboleggiate dai due co-protagonisti: Koča e Šura Traumatizzato. Il primo un ex ribelle anticonformista distrutto dall’alcol e ormai sul filo della demenza; il secondo una promessa fallita del calcio, la cui unica consolazione è il sesso occasionale.
A queste figure fanno da contraltare due donne sensuali e misteriose: la commercialista Olha e l’adolescente Katja. Entrambe appoggeranno in modo diverso Herman nella strenua difesa della stazione di servizio, oggetto delle violente mire mafiose dei latifondisti del granoturco.
Mentre il titolo italiano (La strada del Donbas) fa riferimento al cordone ombelicale che unisce il protagonista alla sua terra, il titolo originale (Vorošylovhrad) è molto più suggestivo per i lettori dell’Est. È infatti il nome che Stalin volle dare alla città di Luhans’k per omaggiare uno dei suoi generali più fedeli (Kliment Vorošylov). E tale nome rimase fino al 1990.
Era una cosa strana nella pedagogia sovietica: apprendere il tedesco. C’era una sorta di insano pathos antifascista. Ci davano cartoline postali con le vedute di varie città. Per esempio cartoline con vedute della città di Vorošylovhrad. Ora non esiste più nemmeno la città, ma qualche anno fa io raccontavo di lei in tedesco.
Riparàti all’interno di un ex campo dei pionieri, che ancora conserva le pareti dipinte dell’epoca, Herman tenta di condividere con l’eccentrica Olha il significato mitico della sua infanzia. Ma senza riuscirci.
Per recuperarne il senso autentico, Herman dovrà giocare una onirica partita di calcio con Traumatizzato e con tutti gli amici della giovinezza, il cui destino di morte è però già segnato da tempo. Avversari: i “gasisti”, ovvero i discendenti degli operai immigrati e sfruttati per l’estrazione del gas.
È nella descrizione antropologica di questa comunità chiusa che gli echi di Steinbeck si fanno fortissimi, così come nella grandiosa descrizione della migrazione (reale o immaginaria?) delle masse nomadi mongole e tibetane attraverso il Donbas, seguita da una missione di osservatori dell’Unione Europea.
– Chi sono? – chiesi.
– Profughi – spiegò Karolina.
– E dove scappano?- chiesi
– Verso occidente – rispose Karolina.
– Ma è legale?
– Certo che no. Se non fosse per noi, sarebbero già stati rimandati tutti indietro.
– E come mai vanno di nuovo verso l’Europa?
– Herman, sono nomadi. Ce l’hanno nel sangue di andare avanti senza fermarsi
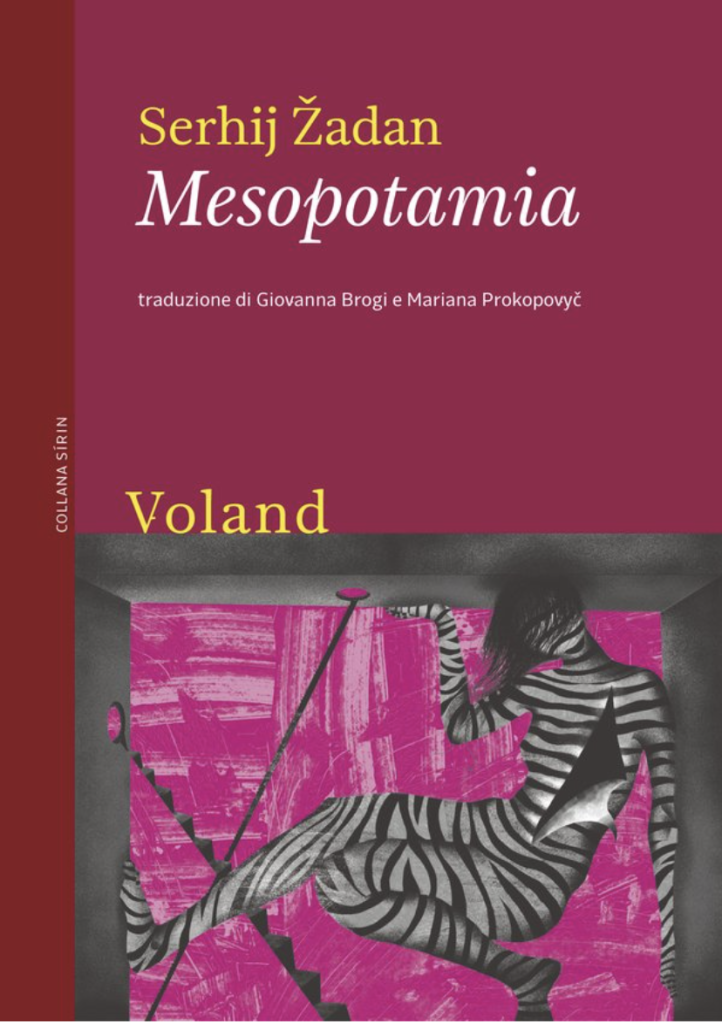
Anche la città di Kharkiv è bagnata da due fiumi, il Lopan e l’Udy. Irrilevanti, semplici affluenti secondari del Donec, ma sufficienti per intraprendere ancora una volta i percorsi tortuosi dell’impossibile redenzione dei derelitti.
Nove racconti i cui titoli riflettono i nomi dei rispettivi protagonisti ed una seconda parte (Precisazioni e Riflessioni) che si finge saggistica ed esplicativa per il lettore, invece è composta di circa duecento stanze in versi, di lunghezza differente: Mesopotamia è anzitutto un’opera ibrida, nella quale nessuna delle due parti funge da sostegno semantico per l’altra.
La parte in prosa, infatti, non è solo una galleria di personaggi e delle loro paradossali vicende, ma una costruzione ad incastro minuziosa, nella quale uomini e donne balzano da un racconto all’altro – come comparse o deus ex machina – tessendo un reticolo di relazioni ed intimità disparate.
Trait d’union universale il farmacista Žora, che compare come tale in tutti i racconti, ma mai di persona: bensì come rivelatore di segreti e pettegolezzi citati dai personaggi.
Anche i generi adottati nei racconti sono molto diversi, si va dal ricordo funebre in ambiente familiare (Marat) a narrazioni di matrimoni boccacceschi (Ivan) fino a commedie dal sapore shakesperiano (Romeo).
Al centro del volume, i due racconti più riusciti: Mario e Jura. Entrambi costruiti sullo sfondo dei ricoveri ospedalieri, nel primo un adolescente si innamora della propria cugina all’interno del caotico appartamento del burbero zio, mentre questi è allettato; nel secondo un musicista rock prolunga artificiosamente la sua degenza per evitare di incappare nella vendetta del suo usuraio.
Il circo sembrava il Reichstag dopo l’attacco: grande allegria, ma evidentemente tutto il complesso aveva bisogno di un restauro. Corridoi freddi, donne in pelliccia, cognac al bar e animali della Mesopotamia sulla pista malinconica.
Questo il ricordo di Jura e della sua prima volta con la figlia al circo, dopo che nella sua stanza è stato ricoverato il circense Valera, erede di una stirpe di girovaghi la cui fortuna si è interrotta drammaticamente.
Degno di nota per il tono umoristico da cinema americano è anche il racconto Fomà, nel quale un ricco imprenditore tenta di avere una relazione con una cameriera che gli viene presentata come ex prostituta.
Cominciò a parlare del lavoro, disse che i clienti erano dei figli di puttana, si morse la lingua, passò alla politica, raccontò una storia sui deputati del partito di governo che si fanno portare i ragazzini in camera, s’interruppe di nuovo, accennò alla cronaca nera, il caso della sauna a luci rosse dove erano stati beccati alcuni sacerdoti, ma a quel punto persino lei gli disse di smetterla
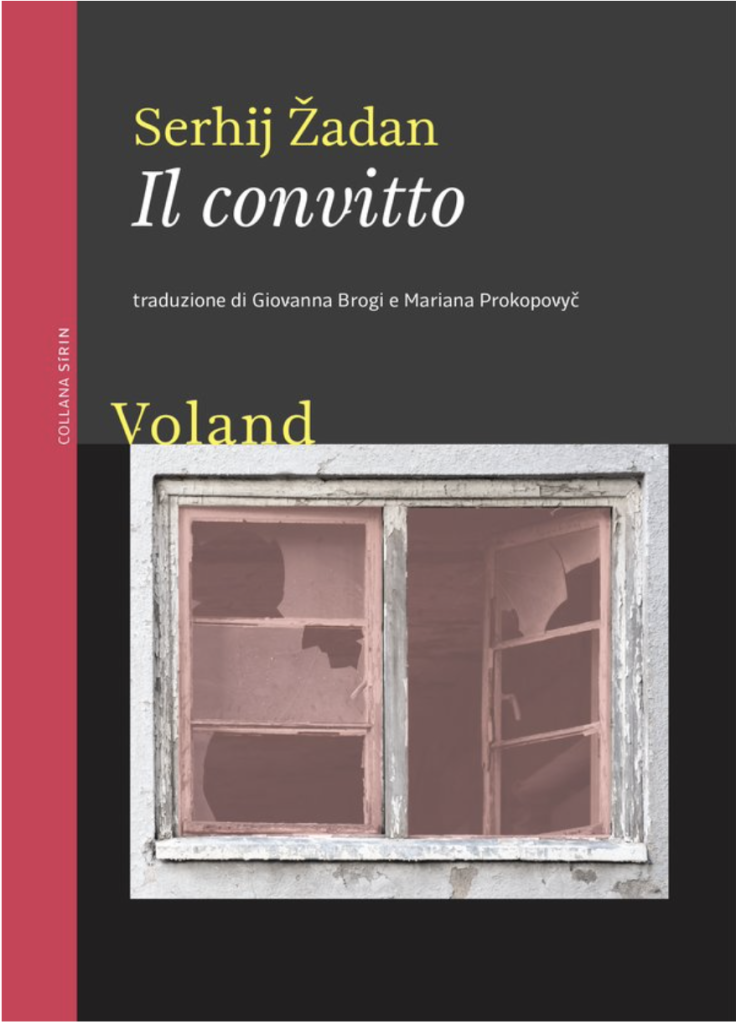
Se nei romanzi precedenti tutti gli sconvolgimenti storici dell’Ucraina erano stati attenuati dalle atmosfere magiche o nostalgiche del passato perduto, in quest’opera Zhadan costruisce un vero capolavoro, un’opera calata anima e corpo nella guerra del Donbas.
Pavlo Ivanovyč detto “Paša” è la letteraria reincarnazione del Pereira di Tabucchi, cui si aggiungono i tratti del Merseault di Camus.
Insegnante di lingua ucraina in un liceo, Paša deve andare (controvoglia) a recuperare il nipote Saša, ospite di un convitto distante pochi isolati dalla scuola ma diversi chilometri dalla sua abitazione. Mentre tutto intorno a sè i segni della guerra si moltiplicano facendosi brutali, in un crescendo magistrale e tragico, il professore rimane assolutamente convinto che quanto sta vivendo sia una piccola parentesi, un’eccezione temporanea alla normalità.
Anche laggiù, a sud, dove comincia la città, c’è uno strano silenzio, senza esplosioni, senza squarci nell’aria. Un autobus sbuca da dietro l’angolo. Paša tira un sospiro di sollievo: il trasporto pubblico funziona, va tutto bene. Semplicemente è ancora presto.
Dunque non è necessario prendere posizione, e nemmeno esprimere le proprie idee politiche – ragione per cui viene progressivamente odiato dai suoi studenti e dai conoscenti.
I tre giorni della sua odissea personale sono quindi scanditi da posti di blocco, granate, deflagrazioni, soldati nervosi o ubriachi, civili stretti nelle stazioni in attesa di una tregua. Ad ogni metro, Paša deve esibire documenti (che spesso non trova) e giustificare la sua presenza e la sua professione in un mondo stravolto nel quale persino gli animali, in particolare gli uccelli e i cani, diventano riflessi dei comportamenti guardinghi e timorosi tenuti dagli umani.
Ma anche quando il professore si trova suo malgrado a guidare una colonna di civili terrorizzati lungo le vie della città in cerca della salvezza, il suo orientamento non cambia: una volta raggiunta la collina del convitto, osservando la città bombardata dall’alto – immagine che al lettore italiano ricorderà i passi del miglior Fenoglio – Paša pensa
È stata solo una giornata pesante. Meno male che è tutto finito
La guerra “invisibile” agli occhi di Pavlo Ivanovyč è anche una guerra linguistica. I militari parlano idiomi sconosciuti quanto le loro remote origini, talvolta lo fanno in modo feroce, talvolta con disponibilità. Per il giornalista americano Peter, invece, è la lingua ucraina ad essere degna dell’archeologia, come il latino, e come molti non concepisce come la si possa insegnare – motivo per il quale in tutto il romanzo Paša si definirà genericamente “insegnante” senza mai specificare di cosa.
Lungo la via del ritorno a casa con Saša, il professor Ivanovyč incontra un ex minatore diventato soldato che con molto nervosismo gli porge una pietra
– E’ una felce. Ha un milione di anni. Tu quanti anni hai – chiede a Paša
– Trentacinque – risponde Paša confuso.
– Lei ne ha un milione – ripete il soldato – Un milione. Tu ed io non eravamo nati, e lei aveva già un milione di anni. Noi creperemo e lei resterà qui. È la storia capisci? Questa è la storia. Io e te non siamo storia: oggi ci siamo, domani no. Ed è un bene, a chi potemmo essere utili? L’ho presa nel museo – precisa.
– Perchè l’hai presa? – chiarisce Paša – Era meglio lasciarla nel museo.
– Il museo non c’è più – grida paziente il soldato – Lo hanno bombardato. Restano solo le macerie. Però la felce si è salvata. Prendila, laggiù da voi ci sarà un museo. Oppure un’aula di geografia. Mettetela lì. Ha un milione di anni. Che non stia a marcire sotto terra.
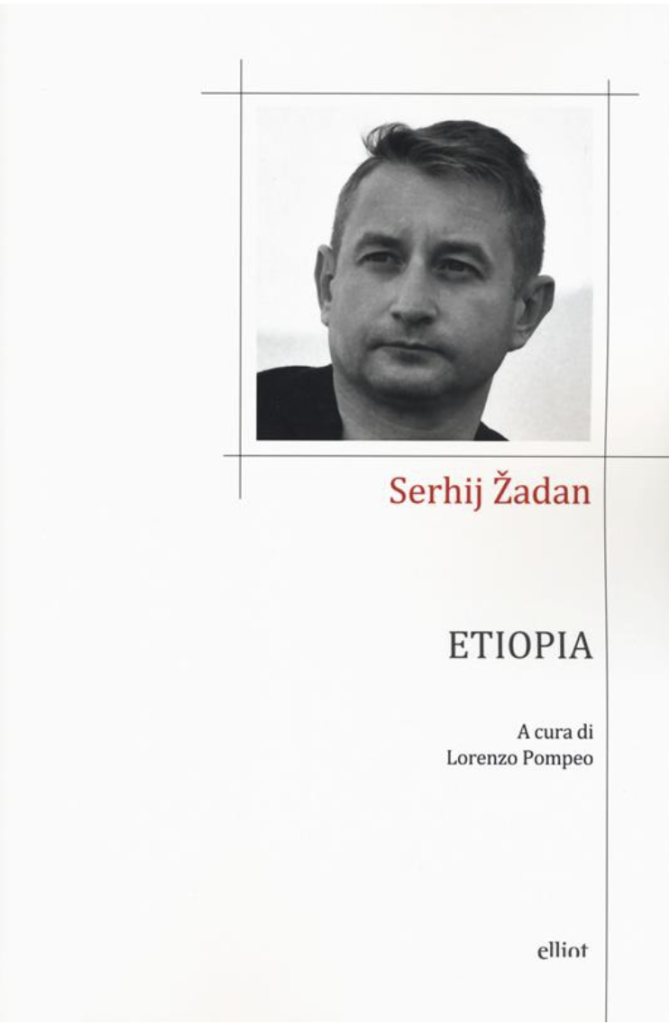
L’unica silloge poetica di Zhadan uscita in edizione italiana conta venticinque componimenti, arricchiti dalla versione originale a fronte.
Il traduttore Lorenzo Pompeo è riuscito magistralmente a rendere il ritmo delle quartine considerando come peculiare il lavoro sulla costruzione delle immagini, piuttosto che sulla fedeltà delle rime.
Ciò che ne emerge è un breve quanto significativo saggio delle abilità poetiche di Zhadan, capace di passare in modo camaleontico dalle venature satirico-punk
C’è stagnazione e rimbecillimento,
liberalismo e pseudo-sinistra venduta,
e non si sa come si sta a galla
l’Unione Europea è governata da canaglie
tutti a dire : “Libertà! Libertà!”
ma a comprare erba decente chi ci va?
a quelle alte dell’immaginario maudit francese
Allora chiederai un po’ di carezze,
perchè non sia tutto troppo crudele,
perchè non si dimentichino
della moneta d’argento
su entrambi gli occhi
Fino a ritrovare, come una sublime maledizione, quello sguardo nostalgico verso un tempo fragile, in bilico tra due epoche e due universi, ostinato nel suo voler essere ancora un ponte
E guardandomi indietro,
nel bel mezzo del silenzio e della vastità
d’un tratto mi sono ricordato di voi
e mi dicevo
che in questo degrado delle sorti
tutto è deciso dal caso,
che il fiore nero dell’alcool
vi sta crescendo tra le scapole
NOTE
(1) Versi tratti da Ancora per un anno aggrappato a chi vuoi bene, poesia contenuta nel volume Poeti d’Ucraina, Mondadori 2022, pag. 181
(2) La strada del Donbas (Voland 2016, 2022)
(3) Una raccolta di poesie pubblicata da Zhadan nel 2007 si intitola Maradona.
(4) Depeche Mode, Castelvecchi 2022, p. 53
(5) Etiopia, Elliot 2019, p. 47



