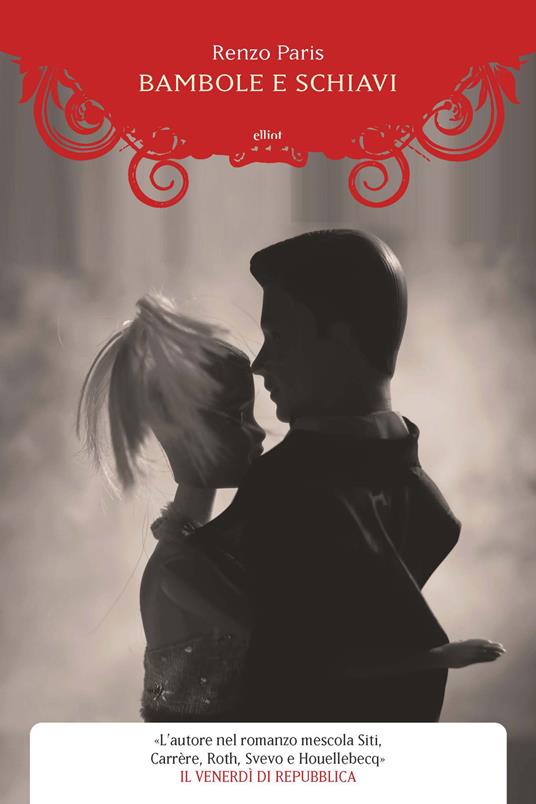Renzo Paris è un autore poliedrico, saggista e poeta e narratore, che ultimamente ci aveva affascinato con due scritture ibride, quel Fenicottero nel quale Paris si raccontava attraverso Silone (suo conterraneo, nato come lui nella Marsica calcarea e primigenia), riuscendo nel contempo a restituirci un Silone nient’affatto agiografico e scandalosamente vivo, quasi in modo imbarazzante; e quel Pasolini ragazzo a vita nel quale, oltre a fare i conti con il poeta (e tante altre cose) di Casarsa, rifletteva anche su di sé. Quindi biografia che s’intreccia con l’autobiografismo, ma senza disdegnare spiazzanti sprazzi di immaginazione; come dimenticare l’incredibile sogno del Pasolini masai che chiude il libro su PPP?
E ora, romanzo. Ma fino a un certo punto. La storia sarebbe presto detta: Francesco, intellettuale romano invecchiato malamente (che ha diverse cose in comune con Paris, esibite disinvoltamente), lascia Roma (nonché una moglie con la quale convive precariamente e una giovane amante, Elsina, con la quale ha una tresca morbosa anzichenò) per una sorta di pellegrinaggio intellettuale a Vienna, dove vuole visitare ancora una volta la casa di Freud. Ma all’aeroporto incontra una ragazza rumena, Dana, con la quale fa amicizia – un’amicizia non priva di sottofondi erotici. Francesco è evidentemente uno di quegli anziani che vuole sparare le ultime cartucce, come si suol dire, però ha troppa consapevolezza di sé per giocare allegramente al Berlusconi in sedicesimo o in trentaduesimo con una femmina dell’Est in cerca di grana.
Dana deve avere qualche problema serio, è in fuga a tutta prima non si sa bene da cosa, anche se già nel quinto capitolo la sorprendiamo a tagliare la corda dalla scena di un delitto, e intuiamo una vita vissuta sul filo del rasoio. Per il momento, cerca rifugio. Da parte sua Francesco vuole “tornare alle origini del romanzo, ai fatti nudi e crudi, alla cronaca, alla vita degli altri”. Ed ecco il contratto tra i due: Dana racconterà la sua storia; Francesco prenderà appunti, coll’intenzione di costruire su quella narrazione orale, anche se smozzicata e faticosa (Dana non parla benissimo l’italiano), un romanzo com’era alle origini, costruito di fatti, cronaca, vita vissuta. Per una settimana l’intervista/interrogatorio va avanti, e tornato finalmente a Roma Francesco scriverà Bambole e schiavi.
La storia di Dana, premetto, è di quelle spietatamente crude: la ragazza passa da un’abiezione all’altra. Miseria in un villaggio contadino, grandi speranze di farsi una vita lontana dalla Romania, poi la prostituzione, poi finire badante di vecchioni bavosi e ripugnanti in una Roma dove sembrano esserci per l’appunto solo bambole (italiane, rumene, poca differenza) e uomini schiavi dei propri appetiti, siano essi sessuali o di esperienze al limite. Droga, alcol, sesso selvaggio, sesso estremo, sesso senza se e senza ma, e alla fine la morte che giunge ogni tanto a chiudere il percorso dell’eccesso o meglio a compierlo. Non c’è perversione più riuscita di quella che ti porta alla fossa, si sa. E Dana viene sballottata da un paese all’altro e da un’umiliazione all’altra, incrociando il suo percorso con quello di Vasil, l’amante/pappone cresciuto con lei nel piccolo borgo transilvano di Ruscova; e delle sue amiche Ana, lesbica e ottimista, e Marlena, puttana allegra che sembra capace di cascare sempre in piedi.
La visione dell’Europa che esce dalla narrazione di Dana (la cui alterità è sottolineata dall’uso di un diverso carattere tipografico) è desolante; ma leggendo viene da chiedersi se sia verosimile che a questa ragazza bella e snella (ma con tendenza all’anoressia) sia successo tutto e il contrario di tutto, che Paris snocciola senza batter ciglio capitolo dopo capitolo. Non posso ovviamente dettagliare fin dove arriva il suo percorso, dove va a parare il suo viaggio al termine della notte, ma garantisco che quando arriverete al capitolo 29 avrete i botti quelli veri. Però non mi sorprenderebbe se qualcuno obiettasse a Paris che la sua è una visione sessista e razzista delle rumene e dei rumeni: tutte troie? Tutti magnaccia e mafiosi?
In realtà sono possibili altre letture. Dana sembra quasi incarnare tutta la serie di stereotipi sulle rumene che senti ripetere dalla gente mentre aspetti di entrare dal dottore o mentre viaggi sul tram; sembra mettere in scena tutte le leggende metropolitane sulle donne di quel paese, ciniche, avide, immorali, prive di scrupoli e comunque tremendamente attraenti. Pare quasi che la storia di Dana sia un abile montaggio di articoli giornalistici, dicerie, luoghi comuni, stereotipi che abbiamo già incontrato n volte. Che Dana sia per un verso una vera rumena ricreata da uno scrittore realistico, per un altro la proiezione di un immaginario collettivo quello sì razzista, becero e bavoso.
Inoltre: gli italiani che Dana incontra e per alcuni dei quali lavora come domestica o badante, l’avvocato Surace, l’architetto Soldati, il giornalista “Mircea” e l’intellettuale Francesco, non fanno certo una gran bella figura. Tutti uomini per bene che alla lunga vogliono allungare le mani sul corpo giovane e ben carrozzato della ragazza. Tutti in realtà vecchioni sbavanti che sembrano voler allontanare la morte succhiando la vita di una giovane donna; e qui l’ironia è palese, perché la transilvana Dana è vittima di vampiri italiani, e molto meno affascinanti e misteriosi del buon vecchio conte Dracula, che al confronto è quasi un eroe positivo.
E concludendo: ma fino a che punto ci possiamo fidare di una narrazione prezzolata come quella che Francesco raccoglie da Dana? Se l’orgasmo della prostituta è simulato, e fa parte del “pacchetto” venduto al cliente infoiato, chi garantisce che un racconto prostituito non sia simulato anch’esso? Dana sta raccontando cose vere, o inventa? Oppure, ipotesi ancor più spiazzante, sa giocare benissimo a mescolare pezzi di vita vissuta e invenzioni ad hoc? Chi è il romanziere, Francesco che ha dalla sua i soldi e la cittadinanza nell’Occidente ricco, o Dana, che lo prende abilmente in giro servendogli quelle scene scandalose delle quali l’italiano ha fame, e per motivi tutt’altro che nobili?
Del resto sappiamo che le narrazioni prigioniere (captive narratives), per esempio quelle degli schiavi di colore negli Stati Uniti pre-abolizione, sono raramente “libere”; sono soggette a mille condizionamenti da parte di chi quelle narrazioni le raccoglie. Quelle storie vincolate hanno ispirato Il racconto dell’ancella della Atwood, e altrettanto vincolato mi pare il racconto della badante di Paris.
Insomma, Bambole e schiavi è un romanzo abilmente costruito con tutta una serie di giochi prospettici e di specchi, con tutta un’architettura di vicoli ciechi e passaggi segreti che – specie nel finale – invitano alla rilettura, e a non dare per scontato quel che si è capito a prima botta. Soprattutto, è un romanzo su quest’Italia che inveisce contro gli immigrati e poi non sembra capace di farne a meno, per gli usi più diversi – non tutti confessabili.
Ed è anche un’amara riflessione sulla vecchiaia, ma non v’illudete che essa sia circoscrivibile alla condizione dell’autore, da non molto settantaquattrenne. Non dimenticate che l’Italia è un paese di vecchi; e i babbioni concupiscenti siamo noi, indipendentemente dalle date sui nostri documenti.