Renato Giovannoli, saggista e narratore, è nato a Cervia nel 1956 e dal 1983 risiede in Svizzera nel Canton Ticino, dove tra il 1990 e il 2007 ha lavorato come giornalista culturale della Radio della Svizzera italiana e ora svolge l’attività di docente di filosofia. È stato allievo di Umberto Eco e ha collaborato ai più stimolanti periodici culturali italiani, da Linus ad Alfabeta. Ha vinto il Premio Battello a Vapore per la letteratura dell’infanzia. È noto soprattutto per i suoi numerosi volumi di saggistica tra cui La scienza della fantascienza ed Elementare Wittgenstein!
Partiamo dall’inizio. Dal tuo rapporto con la filosofia e con la semiotica. Come è iniziato il tuo percorso? Una caratteristica dei tuoi libri – piuttosto rara nella saggistica in lingua italiana, questo va detto – è che il rigore metodologico di una disciplina spesso ostica si accompagna sempre con un approccio, direi, giocoso e divertito al tema trattato (tema spesso, a sua volta, divertente e divertito): insomma si rifugge sempre dalla pesantezza e dalla triste magniloquenza accademica. Una prospettiva generalmente condivisa da un personaggio a te molto legato: Umberto Eco. Quale è stato esattamente il tuo rapporto con lui e quanto un modello così ingombrante, diciamolo pure, ha influito sulla tua formazione e visione del mondo? Mi viene in mente anche la tua collaborazione su Linus con un’altra figura notevole di studioso, Omar Calabrese, per la prima rubrica in Italia sui videogiochi (eravamo nei primissimi anni Ottanta…), nella quale, ancora, affrontavate in modo serio un argomento considerato futile, un po’ come vent’anni prima aveva fatto Eco con i fumetti o le canzonette o la fenomenologia di Mike Bongiorno…
D’accordo, partiamo dall’inizio. Torniamo al luglio 1977. Una sera al campus universitario di Urbino, dove si stanno svolgendo i seminari estivi di semiotica, un gruppo di studenti, tra i quali io, ventunenne iscritto al secondo anno di filosofia, bussa alla porta dell’appartamento di Eco per prelevarlo e andare a cena. La porta si apre e il maestro, con il corpo villoso coperto soltanto, in vita, da un asciugamano, appare in una densa nuvola di vapore che proviene dal vano della doccia e al nostro silenzio imbarazzato risponde con la frase: “Mens sauna in corpore fauno”.
L’episodio dice molto sui rapporti amichevoli che intratteneva con noi studenti e sul suo senso dell’umorismo. Ma il significato profondo di quell’epifania mi si è svelato molti anni dopo, quando l’ho associata al paragone che nel Simposio di Platone Alcibiade fa tra Socrate e un sileno o un fauno… Perché Eco, come Socrate, non ci ha lasciato una dottrina ma un metodo dialettico in cui l’ironia ha un posto importante, e come Socrate non indottrinava i suoi allievi ma li aiutava a partorire le loro proprie idee. E in effetti anche se mi sento pienamente un allievo di Eco, non sono stato mai echiano, neppure negli anni dell’università.
Certo, quanto al metodo e allo stile, gli devo molto e il mio primo libro, La scienza della fantascienza (Bompiani, 1991; seconda edizione ampliata Bompiani, 2015), non solo è stato scritto su suo invito, ma risente di quel suo approccio serio verso le cose apparentemente futili e divertito verso quelle serie a cui alludevi, come anche ovviamente le recensioni ai video games scritte con Omar Calabrese, che recentemente sono state ripubblicate nella nuova edizione di un libro di Omar dal titolo eloquente Serio ludere (Flaccovio, 2010; La Casa Husher, 2015).
 Ma quanto ai contenuti nella Scienza della fantascienza agivano anche altre influenze. Tra il 1976 e il 1977 avevo partecipato al seminario di Carlo Ginzburg in cui stava prendendo forma il suo saggio “Spie. Radici di un paradigma indiziario” (prima in Crisi della ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività umane (a cura di Aldo Gargani, Einaudi), e ripubblicato dall’autore nel volume Miti emblemi spie. Morfologia e storia nel 1986, Einaudi), che tratta di un paradigma scientifico, nel senso di Thomas Kuhn, nel quale viene incluso anche Sherlock Holmes. In quel libro raccontavo tra l’altro lo scontro tra due paradigmi fantascientifici: come in Ginzburg, la nozione kuhniana era applicata alla letteratura di finzione. Mi ero poi appassionato alla lettura di Mille piani di Gilles Deleuze e Félix Guattari, che ricorrevano per esemplificare alcuni loro concetti ai racconti di H.P. Lovecraft. Più in generale, il mio libro è nato dalla scoperta che la fantascienza è una letteratura di idee, una letteratura intrinsecamente filosofica…
Ma quanto ai contenuti nella Scienza della fantascienza agivano anche altre influenze. Tra il 1976 e il 1977 avevo partecipato al seminario di Carlo Ginzburg in cui stava prendendo forma il suo saggio “Spie. Radici di un paradigma indiziario” (prima in Crisi della ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e attività umane (a cura di Aldo Gargani, Einaudi), e ripubblicato dall’autore nel volume Miti emblemi spie. Morfologia e storia nel 1986, Einaudi), che tratta di un paradigma scientifico, nel senso di Thomas Kuhn, nel quale viene incluso anche Sherlock Holmes. In quel libro raccontavo tra l’altro lo scontro tra due paradigmi fantascientifici: come in Ginzburg, la nozione kuhniana era applicata alla letteratura di finzione. Mi ero poi appassionato alla lettura di Mille piani di Gilles Deleuze e Félix Guattari, che ricorrevano per esemplificare alcuni loro concetti ai racconti di H.P. Lovecraft. Più in generale, il mio libro è nato dalla scoperta che la fantascienza è una letteratura di idee, una letteratura intrinsecamente filosofica…
Mi chiedevi anche del mio rapporto con la semiotica. Be’, devo dire che non ho mai praticato una semiotica particolarmente tecnica, una semiotica “dura”, come quella modellata sui paradigmi della logica formale e della linguistica. La mia semiotica, che nei risvolti dei libri non sapendo bene come qualificarmi dal punto di vista disciplinare chiamo “semiotica della cultura”, pur cercando di essere esatta è morbida, ed è semplicemente un tentativo di comprendere i codici e i significati degli oggetti, o degli insiemi di oggetti culturali di cui mi occupo. In questo senso, per me il confine tra semiotica da una parte e iconologia, critica letteraria, persino storia dall’altra è piuttosto labile.
Di La scienza nella fantascienza vorrei parlare in modo più dettagliato. Oltre che una delle tue opere più conosciute e lette è anche una delle mie preferite. Ricordo che, nel corso degli anni, l’hai modificata e accresciuta molto, in tre stesure distinte e piuttosto diverse tra loro. Un testo quindi particolarmente elaborato. Perché è così importante la fantascienza, perché di tutti i generi letterari è forse quello che maggiormente merita un’indagine approfondita? Nel libro spieghi benissimo questo e molto altro sulla “fantasia scientifica” e la “scienza fantasiosa”, ma vorrei che cercassi di sintetizzare questi concetti per i nostri lettori.
Ho cominciato a scrivere La scienza della fantascienza compilando un’antologia di scienze fantastiche nello stile di Borges. Nel frattempo, riflettendo sulla semiotica dei generi letterari, ero giunto alla conclusione che la normale narratologia, quella degli attanti e delle funzioni, era del tutto inadeguata di fronte a certi generi letterari, come il poliziesco e soprattutto la fantascienza, che non raccontano tanto di personaggi umani e delle loro azioni, quanto di “macchine astratte” (il termine lo rubavo a Deleuze e Guattari), di strutture logiche o topologiche. La fantascienza classica racconta le avventure dell’iperspazio e della macchina del tempo, dei paradossi pragmatici delle intelligenze artificiali e di grandiosi processi di ingegneria sociale: i personaggi umani sono secondari, semmai sono ingranaggi di queste macchine astratte. In fantascienza, come diceva Philip K. Dick, l’idea è il vero eroe. Le idee della fantascienza inoltre si raccordano in una sorta di sistema condiviso dai diversi autori, che costituiscono una vera comunità, analoga alla comunità degli scienziati. Come le teorie scientifiche, le teorie della fantascienza si sviluppano nel tempo e, per tornare a Kuhn, si fronteggiano in vere e proprie rivoluzioni scientifiche.
Il libro è un catalogo sistematico delle idee della fantascienza, sistematico perché intende anche esplicitare le connessioni logiche tra le teorie fantascientifiche e ricostruire il dibattito tra i diversi autori, che spesso danno soluzioni diverse dello stesso problema, talvolta polemizzano esplicitamente tra di loro.
Naturalmente nel libro ho dovuto occuparmi anche della scienza “vera”, non solo perché la fantascienza, com’è ovvio, ne fa uso, distorcendola in molti casi con finalità parodistiche e dunque critiche, ma anche perché mi sono presto reso conto che proprio in quegli anni la cosiddetta “nuova fisica”, recuperava molte idee della fantascienza dando loro un contenuto rigoroso. Sto parlando di quei fisici, per lo più progenie di quel geniale allievo di Albert Einstein che è stato Archibald Wheeler, che a partire dagli anni Settanta si sono messi a progettare macchine del tempo o a calcolare la possibilità teorica degli stargates, introducendo quando necessario la nozione di multiverso, cioè degli universi paralleli. Un interscambio tra scienza e fantascienza c’è stato per altro, come ho cercato di mostrare, anche in altri ambiti disciplinari: nell’intelligenza artificiale, nella linguistica, nella logica modale… Per finire ho scritto un libro non soltanto sulla fantascienza, ma anche sulle tendenze altamente speculative e poco galileiane di certa scienza contemporanea.
Dopo la fantascienza – quasi in un ideale proseguimento dello stesso percorso – ti sei dedicato ad un altro genere letterario se possibile ancora più frequentato: il poliziesco, il mystery, o come si dice da noi il “giallo”. Se nel precedente volume hai individuato le linee epistemologiche, la metodologia, la storia e la filosofia della scienza che sostanziano la science fiction, letteraria e cinematografica, così in Elementare, Wittgenstein!, hai rintracciato i percorsi filosofici che orientano la logica dell’indagine, dal razionalismo e le “deduzioni” di Auguste Dupin e Sherlock Holmes, alle abduzioni etiche e psicologiche di padre Brown e di Maigret, al “gotico razionalista” di Agatha Christie o di John Dickson Carr, fino alle derive scettiche, esistenzialiste e nichiliste dell’hard boiled di Dashiell Hammett e Raymond Chandler e del noir. Una serie di traiettorie particolarmente interessanti che, per quanto possibile, ti pregherei di volerci riassumere e commentare.
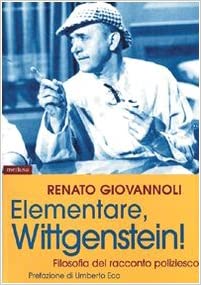 In effetti La scienza della fantascienza ed Elementare, Wittgeistein! (Edizioni Medusa, 2007) sono i frutti di un unico progetto che a suo tempo, all’inizio degli anni Ottanta, aveva il titolo di lavoro “Epistemologie della finzione”. Ho già accennato al ruolo che a Holmes ha dato Ginzburg in un suo saggio. Negli anni immediatamente successivi, Eco, Thomas Sebeok e altri semiotici stavano studiando i suoi racconti con la convinzione che le sue deduzioni fossero piuttosto delle abduzioni. L’abduzione è il terzo tipo di inferenza, dopo la deduzione e l’induzione, scoperto da Charles Sanders Peirce, uno dei padri della semiotica, che riteneva fosse il vero motore della scienza. A me l’ipotesi di Eco e Sebeok non convinceva. Mi pareva che Holmes fosse piuttosto un razionalista, un allievo di Cartesio e Leibniz, e che le sue deduzioni fossero deduzioni in senso stretto. La posta in gioco era alta, perché l’abduzione è un’inferenza ipotetica, mentre la deduzione, se le sue premesse sono vere, dà risultati certamente veri. Dal punto di vista di Eco e Sebeok, Holmes bluffava e le sue teorizzazioni di un’infallibile scienza della detection erano una copertura teatrale della sua abilità, e fortuna, nell’indovinare. Per me Holmes era piuttosto una sorta di mistico capace di vedere l’armonia prestabilita, l’ordo et connexio rerum, e di ricostruirla sul piano logico.
In effetti La scienza della fantascienza ed Elementare, Wittgeistein! (Edizioni Medusa, 2007) sono i frutti di un unico progetto che a suo tempo, all’inizio degli anni Ottanta, aveva il titolo di lavoro “Epistemologie della finzione”. Ho già accennato al ruolo che a Holmes ha dato Ginzburg in un suo saggio. Negli anni immediatamente successivi, Eco, Thomas Sebeok e altri semiotici stavano studiando i suoi racconti con la convinzione che le sue deduzioni fossero piuttosto delle abduzioni. L’abduzione è il terzo tipo di inferenza, dopo la deduzione e l’induzione, scoperto da Charles Sanders Peirce, uno dei padri della semiotica, che riteneva fosse il vero motore della scienza. A me l’ipotesi di Eco e Sebeok non convinceva. Mi pareva che Holmes fosse piuttosto un razionalista, un allievo di Cartesio e Leibniz, e che le sue deduzioni fossero deduzioni in senso stretto. La posta in gioco era alta, perché l’abduzione è un’inferenza ipotetica, mentre la deduzione, se le sue premesse sono vere, dà risultati certamente veri. Dal punto di vista di Eco e Sebeok, Holmes bluffava e le sue teorizzazioni di un’infallibile scienza della detection erano una copertura teatrale della sua abilità, e fortuna, nell’indovinare. Per me Holmes era piuttosto una sorta di mistico capace di vedere l’armonia prestabilita, l’ordo et connexio rerum, e di ricostruirla sul piano logico.
All’epoca scrissi solo un paio di brevi articoli su questo tema e solo all’inizio del nuovo secolo ho iniziato a scrivere il libro. Nel frattempo avevo approfondito anche lo studio dei metodi di altri detectives letterari mettendoli in rapporto con varie dottrine filosofiche e, così come avevo fatto con la fantascienza, ho scritto per finire una sorta di storia astratta e ideale del poliziesco. Anche il poliziesco è una letteratura di idee ed Elementare, Wittgenstein!, analogamente alla Scienza della fantascienza, è un catalogo delle idee di questa letteratura e delle metodologie investigative letterarie, delle loro connessioni logiche e delle loro contrapposizioni epistemologiche. Anche in questo caso il mio approccio è stato di tipo kuhniano. Nella Scienza della fantascienza avevo contrapposto un paradigma neopositivista e un paradigma “critico” e anarcoide. In Elementare, Wittgenstein! si fronteggiano un paradigma razionalista, quello fondato da Holmes, anzi, prima di lui, dal Dupin di Edgar Allan Poe, e poi riformato in chiave formalistica dagli autori degli anni Venti, e un paradigma pragmatista, questo sì peirciano e abduttivo, riconoscibile nel metodo degli investigatori hard boiled.
Quanto al titolo del libro, come si sa esistono due Wittgenstein, il primo Wittgenstein, quello del Tractatus logico-philosophicus (Einaudi, 2009), e il secondo Wittgenstein, quello delle Ricerche filosofiche (Einaudi, 2009). Il primo è un razionalista, molto vicino anche nel suo misticismo a Holmes, il secondo è in fondo un pragmatista, oltre che, come dimostra il suo epistolario, un appassionato lettore di racconti hard boiled. Dato questo sdoppiamento, potevo immaginare che fosse lo stesso Wittgenstein, il primo o il secondo poco importa, a pronunciare la frase “Elementare, Wittgenstein!” e a mettere l’altro se stesso nel ruolo di Watson.
Hai accennato alle abduzioni etiche e psicologiche di padre Brown e di Maigret. Di queste mi sono occupato nella seconda parte del libro, dove mettevo in luce un secondo aspetto dei due paradigmi, che non si oppongono solo quanto alla logica dell’indagine, deduttiva in un caso, abduttiva nell’altro, ma anche quanto all’ontologia degli indizi. Holmes prediligeva gli indizi materiali, delle cui classificazioni era un’enciclopedia vivente, mentre i detective hard boiled ripetono “Io non sono come Sherlock Holmes” e fanno attenzione piuttosto a degli indizi molto più “vaghi”, come dice Philip Marlowe. Il primo a mettere in crisi la concezione holmesiana dell’indizio era stato il ladro gentiluomo Arsène Lupin, il quale aveva dimostrato che Sherlock Holmes, o meglio Herlock Sholmes come lo chiamava Maurice Leblanc per aggirare la normativa sui diritti d’autore, poteva essere battuto attraverso la falsificazione degli indizi. Il paradigma razionalista cerca di parare il colpo con S. S. Van Dine, che sosteneva che però gli indizi psicologici non possono essere falsificati. Anche il prete detective di G. K. Chesterton e Maigret, che dal punto di vista epistemologico sono molto vicini ai detective hard boiled, risolvono i loro casi sulla base di tracce di carattere psicologico. Poi arriva un poliziesco in cui anche gli indizi psicologici possono essere falsificati e non esiste più alcuna verità. È questa la deriva scettica e nichilista a cui alludevi, che inizia nell’hard boiled più disincantato, e dunque già in Dashiell Hammett, e che però ci porta fino al poliziesco postmoderno della seconda metà del Novecento.
Hai citato anche il gotico razionalista. È una mia definizione di quei polizieschi in cui il mistero appare all’inizio soprannaturale, ma viene alla fine svelato su basi esclusivamente razionali. Tzvetan Todorov prendeva questi romanzi come esempio di ciò che chiamava “il fantastico”. Borges notava che il loro finale ci delude. È vero, hanno sempre un finale deludente – e come potrebbe essere altrimenti? – ma per il resto sono incantevoli. Dal punto di vista storico, se teniamo conto dell’inquietudine metafisica che ci comunicano, possiamo considerarli, parte del terreno in cui affondano le radici del poliziesco postmoderno.
Una terza parte del libro è dedicata alla geometria e alla topologia dei luoghi del delitto e dell’indagine. Se il poliziesco razionalista ha come emblema la scacchiera, le avventure dei detectives pragmatisti si svolgono sotto il segno del labirinto. In Hammett troviamo addirittura una concezione relativistica, in senso fisico, dello spazio, e qualcosa di analogo all’iperspazio della fantascienza. A proposito, in Elementare, Wittgenstein!, come anche nella Scienza della fantascienza, ho cercato anche di mostrare la forte analogia che intercorre tra alcune delle idee della fantascienza e alcune idee del poliziesco.
Un altro tuo libro che ho trovato originalissimo e appassionante è Il vampiro innominato. A suo modo un gotico razionalista anche questo, se vogliamo: una detection che intende smascherare vampiri sotto falso nome e li va a cercare dove meno ci aspetteremmo di trovarli, fin ne I promessi sposi, nell’Ulysses di Joyce e perfino in Peter Pan. È davvero raro che un volume di saggistica letteraria sia anche così divertente da leggere: intanto perché travestirsi da Van Helsing letterario e cercare proprio i vampiri? E poi, come ti è venuta l’idea geniale e un po’ folle di mettere a confronto Don Rodrigo, Renzo e Lucia, con Mina e Jonathan Harker nel Dracula di Stoker? Non dimentichiamo poi anche l’amato Edgar Allan Poe, che svolge anche lui una parte importante nel mosaico che vai a ricomporre: pochi sanno che il genio statunitense avesse letto e recensito entusiasticamente la traduzione americana della prima edizione del capolavoro di Manzoni. Raccontaci.
 Il vampiro innominato (Medusa, 2008) nasce da un gioco, un gioco “echiano” se vuoi. Ricordi le pagine del Diario minimo (Mondadori, 1963; Bompiani, 2001) in cui Eco recensisce I promessi sposi come se fosse un opera di James Joyce? Io ho letto invece il romanzo di Manzoni come se fosse una variante della storia di Dracula.
Il vampiro innominato (Medusa, 2008) nasce da un gioco, un gioco “echiano” se vuoi. Ricordi le pagine del Diario minimo (Mondadori, 1963; Bompiani, 2001) in cui Eco recensisce I promessi sposi come se fosse un opera di James Joyce? Io ho letto invece il romanzo di Manzoni come se fosse una variante della storia di Dracula.
Perché proprio i vampiri? Ho pubblicato la prima versione del saggio su Dracula e Manzoni sul mensile Alfabeta nel 1981 e poco prima c’era stato un vero revival cinematografico del vampirismo: Werner Herzog nel 1979 aveva diretto il remake del Nosferatu di Murnau, John Badham (proprio quello della Febbre del sabato sera) nello stesso anno aveva girato un Dracula con la bella interpretazione di Frank Langella. Sono stati quei due film a darmi l’idea. In Nosferatu i ratti che seguono il Conte, a cui Stoker accenna appena, portano la peste! E mentre nel Dracula di Stoker il dottor Seward cura Lucy dal vampirismo a domicilio, nel film di Badham la chiude nella sua clinica per proteggerla dalle effusioni del vampiro, proprio come Lucia viene rinchiusa nel monastero della monaca di Monza.
Allora mi sono costruito una teoria che spiegasse questa e altre coincidenze. In parte l’ho ricavata da un libro di Michel Serres (Sellerio, 1979) in cui le opere di Jules Verne venivano lette come versioni moderne di antichi miti. Applicando un testo su un altro, diceva Serres, si può scoprire che i due testi presentano dei punti notevoli in comune. Ne parlai con Omar Calabrese e lui utilizzò una teoria molto simile per applicare Sandokan su Garibaldi. Una seconda componente della teoria l’ho ricavata invece dalla “teoria della traccia” di Noam Chomsky. Nella trasformazione di un testo in un altro gli elementi cancellati lasciano una traccia, da cui, in una successiva trasformazione, quanto è stato rimosso può nuovamente germinare. Manzoni, soprattutto nella Quarantana, aveva cancellato molti elementi delle sue fonti gotiche, ma erano restate delle tracce. In Stoker la peste aveva lasciato solo delle tracce a partire dalle quali Herzog l’aveva ripristinata. E gli untori manzoniani, i propagatori del contagio, non certo secondo Manzoni ma secondo le leggende da lui riferite con un certo compiacimento, non sono in fondo qualcosa di simile a dei vampiri? In realtà i due romanzi mettevano in forma diversa una stessa materia del contenuto, in parte letteraria, in parte folclorica. Non era un caso dunque che Poe ammirasse così tanto Manzoni, tanto da ricavare dai Promessi sposi, facendo germinare le tracce gotiche presenti nel romanzo, almeno due suoi racconti: “La maschera della morte rossa” e “Re Peste”.
A questo punto però il gioco si faceva maledettamente serio, perché Manzoni entrava a pieno diritto nella storia del romanzo gotico. E io, appassionatomi al gioco, l’ho ripetuto, già agli inizi degli anni Ottanta, con Joyce e con Peter Pan. Poi molti anni dopo ho ripreso questi dossier in mano e li ho arricchiti aggiungendo anche un dossier su Franz Kafka nel quale cerco di dimostrare che il progetto iniziale de Il Castello, e in ogni caso i suoi primi capitoli, sono una parodia di Dracula.
A proposito del termine dossier, che ho appena utilizzato, devo aggiungere che il libro non è suddiviso in capitoli, ma appunto in dossier che rendono conto di altrettante avventure poliziesche. E quindi è vero, come hai accennato, che la critica letteraria prende in questo libro la forma della detection.
Quelli che ne nel libro definisci molto acutamente i temi paralleli del dominio e del contagio sono forse l’essenza primaria, il nucleo ricorrente, dell’eredità gotica che fonda – manifestata o meno – praticamente tutta la letteratura contemporanea, di genere e non. Sei d’accordo o la mia è una semplificazione eccessiva?
I due ambiti tematici del dominio e del contagio sono le due grandi regioni di quella materia del contenuto comune a Dracula e ai Promessi sposi di cui parlavo poco fa. Il vampiro, che si nutre di sangue altrui è, già in Voltaire e poi in Marx, una figura del dominio politico-economico. Nello stesso tempo il vampiro si riproduce per contagio e non per filiazione e secondo certe tradizioni è portatore di malattie contagiose. In Manzoni il primo aspetto si manifesta in personaggi come don Rodrigo e l’innominato, evidenti omologhi di Dracula, il secondo nella peste, il cui carattere demoniaco è cancellato ma non del tutto.
Che questa coppia concettuale sia poi il fondamento di tutta la letteratura contemporanea forse è effettivamente un’eccessiva semplificazione, ma certo si ritrova in molti testi, e per fare riferimento alla letteratura di genere si può ricordare che gli alieni della fantascienza, gli alieni invasori almeno, sono al tempo stesso dominatori e contagiosi… Più che alla letteratura mi viene però da pensare alla realtà. In tempo di covid la connessione tra potere e contagio mi pare un’evidenza. E direi anche che il dominio tecnocratico si impone oggi attraverso la seduzione e il contagio, davvero vampirici, delle tecnologie informatiche.
Ritrovo in tutti i tuoi lavori una costante: la visione analitica, dettagliata, tassonomica, ma che mai perde la meraviglia di occhi stupiti e curiosi sul mondo, senza preconcetti e chiusure aprioristiche, quasi da fanciullino pascoliano. Un aspetto questo che mi porta a un capitolo a parte della tua carriera letteraria: il romanzo d’avventura per ragazzi – e qui a pascoliano sostituirò l’aggettivo stevensoniano, ed ecco che tornano i pirati… – che hai praticato con frequenza e successo. Vari volumi pubblicati da Piemme alla fine degli anni Novanta. Ce ne puoi parlare?
 Hai ragione, quei romanzi sono il frutto di un ritorno all’infanzia. Ero diventato padre e li ho scritti per i miei figli. Ma per far questo non potevo che prendere come lettore ideale me stesso bambino e ricorrere al ricordo delle emozioni che avevo provato leggendo L’isola del tesoro e Huckleberry Finn.
Hai ragione, quei romanzi sono il frutto di un ritorno all’infanzia. Ero diventato padre e li ho scritti per i miei figli. Ma per far questo non potevo che prendere come lettore ideale me stesso bambino e ricorrere al ricordo delle emozioni che avevo provato leggendo L’isola del tesoro e Huckleberry Finn.
Quei libri sono inoltre il frutto secondario di un cammino religioso sostenuto anche da molte letture esoteriche e “tradizionali”. Da qui l’interesse per il Medioevo e per le organizzazioni iniziatiche furfantesche dell’epoca, che sono il soggetto del primo di questi romanzi, I Predoni del Santo Graal (Piemme, 1995; Ancora, 2020). Da qui alla pirateria “classica” la strada era breve, e così ho scritto Il mistero dell’Isola del Drago (Il battello a vapore, 1998), che oltre che a L’Isola del tesoro Stevenson si ispirava non poco alle storie di pirati di Pierre Mac Orlan. Poi con Quando eravamo cavalieri della Tavola Rotonda (Il battello a vapore, 2000), sono tornato al Medioevo, ma un Medioevo fiabesco, anzi decisamente fantasy, piuttosto diverso da quello del primo romanzo. Se nei Predoni i miei autori di riferimento erano François Villon e François Rabelais (e tra gli storici moderni Bronisław Geremek) in Quando eravamo cavalieri guardavo a Chretien de Troyes e a Wolfram von Eschembach. Ma in entrambi i casi non si trattava di un Medioevo visto con un occhiale critico illuminista come quello di Eco, ma di un Medioevo “tradizionale” attraverso il quale speravo di trasmettere dei valori spirituali. Non posso negare però che quei libri avessero un certo carattere citazionista, dunque postmoderno e, se vuoi, “echiano”…
Quanto dici a proposito di un tuo cammino religioso e di letture esoteriche e “tradizionali”, mi suggerisce una domanda particolarmente sentita. Che significa “tradizionale”, ha davvero senso questo termine? Gli autori del “tradizionalismo integrale” hanno usato categorie e concetti assolutamente moderni (la Philosophia perennis – infatti termine più appropriato per definire questa branca del pensiero dovrebbe essere “Perennialismo” – che è un mito nato proprio nel Rinascimento, periodo che secondo loro segna il definitivo tramonto della metafisica…) per criticare il “mondo moderno”, una contraddizione in termini. Se poi possiamo, in parte, assolvere Rene Guénon che rimane almeno figura pertinente quasi esclusivamente a un dibattito interno alla storia delle religioni, il suo emulo italiano – che teorizza una “rivolta contro il mondo moderno” nei dintorni della Volksgemeinschaft nazionalsocialista dove “tradizionale” è il Blut und Boden o il razzismo e l’antisemitismo (divenuti “spirituali” e quindi nobilitati, potenza dello spirito!) – o i suoi seguaci, peggiori del maestro, che fino a oggi si arrampicano sugli specchi dello stravolgimento terminologico per asseverare il rango di “pensatore” al loro beniamino, e chiamano il neofascismo “non-conformismo”, il totalitarismo, “società organica”, e da reazionari che sono si definiscono “antimoderni”. Se è questa la “Tradizione”, bisogna stare molto attenti. Mi incuriosisce molto il tuo percorso di semiologo in campo religioso, esoterico e – una volta sentita la tua definizione del termine, per non incorrere in fraintendimenti – “tradizionalista”.
 Potrei definire la Tradizione come ciò che i Padri ci hanno trasmesso quanto alla conoscenza di Dio, in primo luogo, e poi del mondo e dell’uomo. Utilizzo un linguaggio cristiano, perché è in questo ambito tradizionale che mi muovo, ma non dovrebbe essere difficile adattare questa definizione ad altri contesti culturali e religiosi.
Potrei definire la Tradizione come ciò che i Padri ci hanno trasmesso quanto alla conoscenza di Dio, in primo luogo, e poi del mondo e dell’uomo. Utilizzo un linguaggio cristiano, perché è in questo ambito tradizionale che mi muovo, ma non dovrebbe essere difficile adattare questa definizione ad altri contesti culturali e religiosi.
Subito dopo la laurea mi sono messo a leggere Origene e altri padri della Chiesa, ma anche Zhuang-zi e la letteratura vedica, poi ho letto Guénon e Ananda Coomaraswamy, per citare solo pochi nomi. Prima mi hai chiesto del mio rapporto con la filosofia e la semiotica e ho risposto solo per quanto riguarda la semiotica: aggiungo ora che per quanto riguarda la filosofia, io che ero stato marxista e deleuziano, sono giunto presto alla conclusione che una filosofia senza metafisica, cioè nella sostanza senza Dio, è incompleta e incoerente. Tornando alla semiotica, queste letture mi avevano fatto scoprire il simbolismo e la teoria tradizionale del simbolismo. Una semiotica metafisicamente fondata, completamente diversa da quella moderna. Eppure per millenni è così che gli uomini hanno interpretato il mondo e hanno costruito i loro sistemi di segni.
Un giorno, quando Eco stava scrivendo Il pendolo di Foucault (Bompiani, 1988; La nave di Teseo, 2018), sul quale manteneva il più assoluto riserbo, ho sbirciato degli appunti sulla sua scrivania e ho visto un diagramma “semiotico” che includeva il Graal e la Santa Lancia. Mi ha piacevolmente stupito che anche lui leggesse Guénon, ma poi mi ha spiegato che lo faceva per combatterlo e ho dovuto prendere atto che i nostri punti di vista erano molto lontani. In seguito ha tenuto all’Università un seminario sulla “semiotica ermetica” e qualcuno mi ha raccontato che quando l’amico Daniele Barbieri gli ha suggerito di invitarmi, dato che mi stavo occupando di quelle cose, lui ha risposto: “Questo è un seminario contro Giovannoli”.
Dicevo che la Tradizione per me verte innanzitutto sulla conoscenza di Dio, il che esclude che siano autori tradizionali personaggi come Georges Gurdjieff o Aleister Crowley (che Guénon considerava degli adepti della controiniziazione) e anche Julius Evola (verso cui Guénon non aveva alcuna stima). A questo proposito, permettimi di dirti che il tuo Applausi per una mano sola (Clinamen, 2008), che ho letto solo due o tre anni fa, troppo tardi purtroppo per poter citare nell’ultima edizione della Scienza della fantascienza il capitolo su Ron Hubbard, è un libro utilissimo, e che lo è proprio perché, a dispetto della simpatia che allora provavi per Gurdjieff, getta luce proprio su questi esoterismi e misticismi oscuri. I quali, hai perfettamente ragione, sono molto pericolosi, sia dal punto di vista politico che per l’anima degli incauti che li avvicinano.
Ti ringrazio per aver ricordato il mio vecchio libretto, ormai molto lontano dalla mia visione attuale, ora certo più vicina a Eco che a Gurdjieff. A questo punto però mi viene spontaneo chiederti in che modo, al di là dell’ipse dixit di Guénon o di altri come lui, ma da semiologo, da filosofo e da storico delle idee, discrimini che cosa è “oscuro” e che cosa è “luminoso”. I grandi mistici, come Meister Eckart, Nagarjuna, Al Hallaj, non ponevano opposizioni: Dio è abisso, quindi anche tenebra, nulla, urgrund come dice Eckart. L’albero sephirotico della cabala include e comprende il suo rovesciamento qliphotico. Ermete Trismegisto proclama che “ciò che è in alto è come ciò che in basso per il miracolo di una cosa sola…”. Gli autori perennialisti, come Guénon, pongono invece irrevocabili dualismi e dicotomie, talvolta dando il sospetto che questo discrimine derivi solo dalle loro idiosincrasie personali e “umane, troppo umane”: mondo “tradizionale” e “mondo moderno”, “iniziazione” e “controiniziazione”, etc. Non ti sembra paradossalmente poco “tradizionale” – se identifichiamo questo termine con mistico, metafisico, spirituale – questo procedere, da parte degli autori che citi, più per analisi che per sintesi (se vogliamo usare termini sicuramente troppo approssimativi, ma tanto per intenderci…)?
 Se volevi mettermi in imbarazzo con una domanda difficile, ci sei riuscito… Mi chiedi un criterio per distinguere ciò che è oscuro da ciò che è luminoso. Potrei risponderti con il detto evangelico “Li riconoscerete dai loro frutti”, un criterio non così diverso da quello che poco fa ti ha spinto a rifiutare un pensiero che facilmente può approdare al razzismo e all’antisemitismo. Mi hai chiesto poi se non sia più coerente, all’interno di un pensiero non dualista, pensare che anche ciò che oscuro abbia un suo fondamento metafisico e dunque in qualche modo i suoi diritti. Mi pare che rispondere di sì significherebbe ammettere un dualismo più o meno mascherato: ammettere che ci sia un lato oscuro in Dio o una frattura originaria nel Pleroma divino, come pensavano e pensano i falsi gnostici. Per altro, come sai benissimo, la tenebra o il nulla divino della teologia apofatica non hanno niente a che fare con tutto ciò, ma sono espressioni simboliche che significano che Dio è superiore a ogni determinazione e persino all’Essere.
Se volevi mettermi in imbarazzo con una domanda difficile, ci sei riuscito… Mi chiedi un criterio per distinguere ciò che è oscuro da ciò che è luminoso. Potrei risponderti con il detto evangelico “Li riconoscerete dai loro frutti”, un criterio non così diverso da quello che poco fa ti ha spinto a rifiutare un pensiero che facilmente può approdare al razzismo e all’antisemitismo. Mi hai chiesto poi se non sia più coerente, all’interno di un pensiero non dualista, pensare che anche ciò che oscuro abbia un suo fondamento metafisico e dunque in qualche modo i suoi diritti. Mi pare che rispondere di sì significherebbe ammettere un dualismo più o meno mascherato: ammettere che ci sia un lato oscuro in Dio o una frattura originaria nel Pleroma divino, come pensavano e pensano i falsi gnostici. Per altro, come sai benissimo, la tenebra o il nulla divino della teologia apofatica non hanno niente a che fare con tutto ciò, ma sono espressioni simboliche che significano che Dio è superiore a ogni determinazione e persino all’Essere.
Ho paura che potremmo andare avanti per pagine e pagine su un tema così complesso e affascinante e questo, per quanto intellettualmente stimolante, ci porterebbe troppo lontano dal filo conduttore dell’intervista. Credo quindi sia meglio fermarci qui e apprezzo la concisione della tua risposta. Non ci allontaniamo però troppo dal tema della tradizione con quello che trovo un caso a parte nella tua bibliografia, già abitualmente molto fantasiosa, un libro mi pare più personale degli altri e, direi, quasi privato nella sua singolarità. Sto parlando di Jolly Roger. Le bandiere dei pirati (Medusa, 2012). Vero e proprio trattato di iconografia e iconologia piratesca. Quando lo avvicinai la prima volta ero dubbioso: un volume intero dedicato solo alla bandiera nera con teschio e tibie incrociate? Impossibile. Mi bastò sfogliarne le pagine per ricredermi: oltre ad aver fornito un ricco corredo di immagini bellissime, è incredibile quante cose e quanto interessanti, tu sia riuscito a trarre da uno spunto apparentemente così limitato. Raccontaci le ragioni di questa scelta, la tua curiosità verso un argomento tanto particolare. Cosa rappresentano per te i pirati? Li hai frequentati parecchio, anche nella tua attività narrativa.
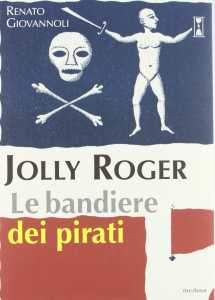 In effetti Jolly Roger nasce dallo stesso background da cui sono emersi I predoni del Santo Graal e Il mistero dell’isola del Drago. Nasce quindi dalle mie passioni infantili, e in questo senso è vero che è un libro personale e privato. Però dietro c’è anche l’interesse per le corporazioni criminali del Medioevo, governate, come notava Marcel Schwob, da un’élite intellettuale di malviventi, e dalle quali le confraternite piratesche della prima metà del Settecento procedono. Il libro è anche uno “studio tradizionale” perché le bandiere dei pirati mettono in campo un simbolismo sacro e anche iniziatico. “Malavita eroica e tradizionale, biblica, un brulicare di Europe maledette”, diceva Guido Ceronetti della pirateria classica, e in questa definizione trovi sia l’aspetto romantico e romanzesco, sia l’aspetto sapienziale della questione.
In effetti Jolly Roger nasce dallo stesso background da cui sono emersi I predoni del Santo Graal e Il mistero dell’isola del Drago. Nasce quindi dalle mie passioni infantili, e in questo senso è vero che è un libro personale e privato. Però dietro c’è anche l’interesse per le corporazioni criminali del Medioevo, governate, come notava Marcel Schwob, da un’élite intellettuale di malviventi, e dalle quali le confraternite piratesche della prima metà del Settecento procedono. Il libro è anche uno “studio tradizionale” perché le bandiere dei pirati mettono in campo un simbolismo sacro e anche iniziatico. “Malavita eroica e tradizionale, biblica, un brulicare di Europe maledette”, diceva Guido Ceronetti della pirateria classica, e in questa definizione trovi sia l’aspetto romantico e romanzesco, sia l’aspetto sapienziale della questione.
Una delle idee centrali del libro, e credo che sia un’idea originale, è che Jolly Roger, prima che il nome delle bandiere, sia il nome dello scheletro che vi è raffigurato, il quale ipotizzo sia un avatara di Odino. Come Odino, Jolly Roger è il signore di un esercito furioso di morti. Ed è anche un parente prossimo della maschera del teatro medievale francese Roger Bontemps, pure connesso al tema odinico dell’Esercito Furioso o Caccia Selvaggia. Roger significa “lancia gloriosa” ed è un nome odinico. L’iniziazione dei guerrieri scandinavi, che garantiva loro l’accesso al Walhalla e la partecipazione all’esercito dei morti di Odino, prevedeva la ferita rituale di una lancia e nel Jolly Roger che per primo, probabilmente, ha ricevuto questo nome, vediamo lo scheletro che trafigge un cuore da cui escono tre gocce di sangue, un’immagine di cui cerco di dimostrare il significato iniziatico attraverso la comparazione con tutta una famiglia di simboli che troviamo nell’iconografia e nella letteratura mistica e cavalleresca.
Jolly Roger è però un libro piuttosto difettoso e lo sto riscrivendo, non solo per correggere alcuni errori, ma anche perché nel frattempo la bibliografia sull’argomento è cresciuta e io ho fatto nuove scoperte. A proposito, in questa nuova versione cito anche un testo settecentesco che attesta, e non me ne ero accorto quando ho scritto la prima versione, che la bandiera di cui parlavo poco fa veniva issata non solo quando i pirati incarnavano nei loro arrembaggi l’Esercito Furioso, ma anche quando venivano celebrate le iniziazioni alla pirateria.
Un altro libro che, come Il vampiro innominato, è nato da un gioco geniale e decisamente visionario è Come costruire la biblioteca di Babele (Medusa, 2015). Il sottotitolo è a dispetto degli errori di Borges: il Maestro infatti – e ci presenti tutta la documentazione in proposito – ha sbagliato per ben due volte, nella prima stesura e anche nell’autocorrezione di una seconda riscrittura del suo racconto forse più famoso. Né Borges, né un numero piuttosto elevato di critici che hanno tentato l’impresa, sono riusciti a rettificare in modo soddisfacente gli errori matematici e architettonici presenti nel testo, lasciando irrisolto il problema. Tu invece una soluzione la trovi. Qui il tema si fa davvero complicato e ci devi una spiegazione.
 Io includo Come costruire la biblioteca di Babele nei miei science fiction studies e lo considero una specie di appendice della Scienza della fantascienza. Il racconto di Borges è infatti un racconto di fantascienza e in particolare di fantageometria.
Io includo Come costruire la biblioteca di Babele nei miei science fiction studies e lo considero una specie di appendice della Scienza della fantascienza. Il racconto di Borges è infatti un racconto di fantascienza e in particolare di fantageometria.
La Biblioteca di Babele, come si sa, è un’infinita estensione in tutte le direzioni dello spazio di celle esagonali, collegate orizzontalmente da brevi corridoi e verticalmente da scale a chiocciola. Nella prima versione del racconto però Borges dice che delle loro sei pareti solo una dà su un corridoio, quindi, orizzontalmente, la biblioteca di Babele è composta solo da due celle, e se consideriamo anche la dimensione verticale è una torre ogni piano della quale ha solo due stanze. Nella versione corretta inclusa in Tutte le Opere (Mondadori, 1991), Borges corregge il tiro ma non abbastanza, poiché afferma che le porte delle celle sono due. Ne consegue inevitabilmente che la Biblioteca, sempre considerando solo i suoi piani orizzontali, è una sequenza lineare di celle, e in altezza una sorta di muraglia cava. Ma allora come si fa a costruire la Biblioteca di Babele? Chi ci ha provato si è sentito costretto, e quindi autorizzato, a non rispettare le indicazioni di Borges. Io invece, seguendo pressoché alla lettera quel che Borges dice nella seconda versione del racconto, fornisco la soluzione del rompicapo, che però è solo in parte mia perché un suggerimento determinante, e cioè dove piazzare le scale a chiocciola, mi è stato dato da mio figlio Tommaso, che è architetto.
In alcuni excursus approfondisco inoltre il tema dell’architettura fantastica in autori come Kafka, Chesterton e Lovecraft, riprendendo il tema di uno dei sottocapitoli della Scienza della fantascienza.
Veniamo a La farfalla e il Leviatano. Indagini filosofiche su Lewis Carroll (Medusa, 2017), un libro che si muove audacemente fra letteratura e filosofia, logica e metafisica, tracciando un ampio periplo che, partendo da Alice al di là dello specchio e dal paradosso taoista del sogno della farfalla di Zhuang-zi, ci conduce, passando per Borges, Gordon Pym, Achab, Northrop Frye, la poesia sufi, la teologia apofatica e il concetto di Nirvana, a caccia dello Snark insieme a Lewis Carroll. Un vero tour de force intellettuale. Mostraci il filo di Arianna in questo affascinante labirinto…
 Raccontare questo libro non è facile… Dirò che è una lettura metafisica, e per certi aspetti mistica di Carroll. Sono partito dal paradosso che conclude Al di là dello specchio e che ho chiamato “il paradosso del sogno”. Alice aveva appreso di essere un sogno del Re Rosso, ma alla fine si accorge di aver sognato tutto. E dunque è Alice che ha sognato il Re Rosso o il Re Rosso che ha sognato Alice? Questo paradosso è formalmente identico a quello di Zhuang-zi e la farfalla. Zhuang-zi sognò di essere una farfalla e al risveglio non sapeva più se era Zhuang che aveva sognato di essere una farfalla o una farfalla che aveva sognato di essere Zhuang. Dunque ho dovuto coinvolgere il Taoismo, i ritratti fotografici che Carroll faceva alle sue amichette in abiti cinesi, la sinologia oxoniense dei tempi di Carroll e il bruco di Alice nel Paese delle Meraviglie, che deve essere cinese, perché nelle illustrazioni di Carroll non fuma un narghilè come poi in quelle di John Tenniel ma una pipa da oppio, e forse è proprio Zhuang-zi, perché lo si può collegare al sogno della farfalla di Zhuang-zi. Infatti discute con Alice della sua trasformazione in farfalla e la farfalla sognata da Zhuang-zi non è altro che Zhuang-zi stesso a un più alto stato dell’essere, come la dantesca angelica farfalla che potremmo essere quando ci sveglieremo da questo sogno…
Raccontare questo libro non è facile… Dirò che è una lettura metafisica, e per certi aspetti mistica di Carroll. Sono partito dal paradosso che conclude Al di là dello specchio e che ho chiamato “il paradosso del sogno”. Alice aveva appreso di essere un sogno del Re Rosso, ma alla fine si accorge di aver sognato tutto. E dunque è Alice che ha sognato il Re Rosso o il Re Rosso che ha sognato Alice? Questo paradosso è formalmente identico a quello di Zhuang-zi e la farfalla. Zhuang-zi sognò di essere una farfalla e al risveglio non sapeva più se era Zhuang che aveva sognato di essere una farfalla o una farfalla che aveva sognato di essere Zhuang. Dunque ho dovuto coinvolgere il Taoismo, i ritratti fotografici che Carroll faceva alle sue amichette in abiti cinesi, la sinologia oxoniense dei tempi di Carroll e il bruco di Alice nel Paese delle Meraviglie, che deve essere cinese, perché nelle illustrazioni di Carroll non fuma un narghilè come poi in quelle di John Tenniel ma una pipa da oppio, e forse è proprio Zhuang-zi, perché lo si può collegare al sogno della farfalla di Zhuang-zi. Infatti discute con Alice della sua trasformazione in farfalla e la farfalla sognata da Zhuang-zi non è altro che Zhuang-zi stesso a un più alto stato dell’essere, come la dantesca angelica farfalla che potremmo essere quando ci sveglieremo da questo sogno…
Vedi, te lo dicevo che non è facile raccontare questo libro. Mi rendo conto che riassunto in poche parole dà l’idea di essere un delirio, e invece è il mio libro più rigoroso dal punto di vista logico. Be’, da Zhuang-zi sono tornato a Borges, che ha reso famoso l’apologo della farfalla. Borges e Carroll mi portavano poi a Berkeley e tenendo conto di un altro paradosso carrolliano, questo in Alice nel paese delle Meraviglie, a Hume. Ma dai paradossi di Alice non si esce perché come tutti i veri paradossi non hanno soluzione. Sono dei koan e hanno la funzione di farci capire che la loro soluzione è altrove.
La loro soluzione la troviamo nel poema di Carroll La caccia allo Snark (Feltrinelli, 2018) dove, come ben vide Snarkophilus Snobs alias il filosofo pragmatista F.C.S. Schiller, Carroll espone una metafisica e una mistica assai vicine a quelle dell’India o del misticismo cristiano medievale. O meglio, Snobs, che era un acerrimo nemico dell’Assoluto, dice che Carroll fa la parodia di questa metafisica, ma in realtà Carroll non fa nessun parodia, dice sul serio. Lo Snark è un fratello di Moby Dick, è un mostro che raffigura l’Assoluto, e poi c’è uno Snark di tipo particolare, lo Snark Boojum, che fa svanire tutti quelli che lo vedono. Perché chi cattura lo Snark, cioè l’Assoluto, è in realtà divorato da lui. Perde la propria individualità, ma non è annientato, è dio in Dio, come la farfalla che diventa fiamma nella fiamma della candela, una celebre immagine della poesia sufi che ritroviamo più volte nell’opera di Carroll.
Per decifrare il simbolismo nonsense della Caccia allo Snark, oltre che alle indicazioni di Snobs e di altri autori, ho dovuto ricorrere al Grande Codice, per usare la formula che Northrop Frye ha ripreso da Blake, cioè alla Bibbia utilizzata come chiave. Dietro al poema carrolliano c’è infatti il Libro di Giobbe e in particolare la terribile figura del Leviatano, che Carroll trasforma nello Snark e usa come una figura dell’Assoluto, di Dio. Qui ho dovuto seguire una pista che mi portava a Hobbes e da lui a Giovanni Calvino, il primo che abbia tolto al Leviatano l’aura demoniaca che gli avevano dato i precedenti commentatori…
Scusami, ma chiudo qui perché temo proprio di confondere l’eventuale lettore del libro. Però insisto: il libro è un’interpretazione perfettamente coerente e credo convincente dell’opera di Carroll. L’eventuale lettore troverà il filo d’Arianna che mi hai chiesto nel libro stesso. D’altra parte, un filo d’Arianna non serve a niente se si resta fuori dal labirinto.
Siamo tornati al tema spirituale (termine che – lo avrai capito – utilizzo molto più volentieri di tradizionale…), e non ce ne allontaniamo parlando di una tua monumentale opera che è anche, se non mi sbaglio, la tua più recente: i tre volumi de La Bibbia di Bob Dylan (Ancora, 2017). Una dettagliatissima esegesi di tutte le canzoni dylaniane attraverso i riferimenti biblici in esse contenuti o forse, ancora meglio, un’esegesi biblica attraverso le canzoni dylaniane. Di che si tratta esattamente? Spiegaci.
 In primo luogo, è un repertorio di non proprio tutte, ovviamente, ma di quasi tutte le citazioni bibliche che costellano il canzoniere di Dylan. Va precisato, che almeno tre quarti delle canzoni dylaniane contengono riferimenti alla Bibbia. Uno degli indici che ho compilato e messo alla fine del terzo volume è l’indice scritturistico, ovvero l’elenco dei riferimenti biblici che ho fatto nei tre volumi, che per la maggior parte sono i riferimenti biblici presenti nelle canzoni di Dylan. Be’, l’elenco è impressionante, riempie più di trenta pagine a tre colonne composte con un corpo tipografico piccolo. Dylan ha citato quasi tutti i libri biblici, e per ogni libro le citazioni sono numerosissime.
In primo luogo, è un repertorio di non proprio tutte, ovviamente, ma di quasi tutte le citazioni bibliche che costellano il canzoniere di Dylan. Va precisato, che almeno tre quarti delle canzoni dylaniane contengono riferimenti alla Bibbia. Uno degli indici che ho compilato e messo alla fine del terzo volume è l’indice scritturistico, ovvero l’elenco dei riferimenti biblici che ho fatto nei tre volumi, che per la maggior parte sono i riferimenti biblici presenti nelle canzoni di Dylan. Be’, l’elenco è impressionante, riempie più di trenta pagine a tre colonne composte con un corpo tipografico piccolo. Dylan ha citato quasi tutti i libri biblici, e per ogni libro le citazioni sono numerosissime.
Per altro, parlare di citazioni bibliche non rende l’idea, perché molte strofe di Dylan e anche intere sue canzoni sono letteralmente costruite su un testo o su una collezione di testi biblici. La Bibbia di Bob Dylan, dunque, è anche un’interpretazione e una decifrazione di una buona parte del canzoniere dylaniano, che grazie al Grande Codice acquista un senso che sarebbe restato altrimenti inattingibile. Il surrealismo, il nonsense, l’oscurità di tante canzoni di Dylan vengono inaspettatamente illuminati da questa analisi comparativa, che permette inoltre di gettare uno sguardo nel laboratorio del poeta. Dylan infatti spesso trasforma, scompone e ricompone le sue fonti bibliche, che restano visibili in trasparenza permettendoci di ricostruire il suo lavoro. Talvolta risulta chiaro che ha svolto uno studio biblico preliminare basato sulle concordanze, perché in pochi versi troviamo tracce di molti passi biblici sullo stesso tema.
Ancora, La Bibbia di Bob Dylan è un viaggio attraverso la Bibbia di cui le canzoni di Dylan offrono il pretesto. Io stesso durante la sua stesura, nel tentativo di ricostruire gli studi biblici preliminari di Dylan, ho avuto modo di arricchire la mia conoscenza della Bibbia.
 Infine, è una biografia spirituale di Dylan, perché la Bibbia e più in generale la religione non sono state per lui soltanto una fonte di ispirazione letteraria, ma hanno avuto un valore, diciamo così, esistenziale. Dylan, come si sa, è molto geloso della sua vita privata, ma nelle sue canzoni ci dà spesso, anche se con un linguaggio cifrato, informazioni sulla sua storia spirituale che le fonti normalmente utilizzate dai biografi non registrano.
Infine, è una biografia spirituale di Dylan, perché la Bibbia e più in generale la religione non sono state per lui soltanto una fonte di ispirazione letteraria, ma hanno avuto un valore, diciamo così, esistenziale. Dylan, come si sa, è molto geloso della sua vita privata, ma nelle sue canzoni ci dà spesso, anche se con un linguaggio cifrato, informazioni sulla sua storia spirituale che le fonti normalmente utilizzate dai biografi non registrano.
Bob Dylan non è l’unico musicista-poeta con un’opera segnata da forti riferimenti biblici e da una profonda tensione spirituale, potrei citarti ad esempio un altro, grande almeno quanto lui e forse ancora più “biblico”, Leonard Cohen; e poi, volendo, anche Patti Smith o Nick Cave. Hai scelto Dylan perché lo ritieni più significativo, più compiuto di altri o c’è un particolare legame con le sue canzoni e la sua figura per te? Gli hai dedicato un bel po’ di tempo e di energie, quindi evidentemente ha un’importanza particolare ai tuoi occhi.
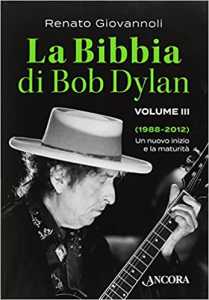 Si potrebbero citare moltissimi altri autori della musica popolare americana con una forte tensione spirituale e un consistente background biblico, per fare solo un altro nome Bruce Springsteen, su cui un amico, Luca Miele, ha scritto un bel libretto intitolato Il vangelo secondo Bruce Springsteen (Claudiana, 2017). Il fatto è che la cultura americana è intrisa di Bibbia, ed è per ignoranza che la ricezione italiana della musica rock, che non sfugge alla regola, per molti anni (le cose sono cambiate nel nuovo secolo) non ha colto questo suo aspetto certo non secondario.
Si potrebbero citare moltissimi altri autori della musica popolare americana con una forte tensione spirituale e un consistente background biblico, per fare solo un altro nome Bruce Springsteen, su cui un amico, Luca Miele, ha scritto un bel libretto intitolato Il vangelo secondo Bruce Springsteen (Claudiana, 2017). Il fatto è che la cultura americana è intrisa di Bibbia, ed è per ignoranza che la ricezione italiana della musica rock, che non sfugge alla regola, per molti anni (le cose sono cambiate nel nuovo secolo) non ha colto questo suo aspetto certo non secondario.
La mia predilezione per Dylan deriva dai miei gusti e dalla mia storia personale… Sì, trovo che l’arte di Dylan, almeno nei suoi momenti migliori, che non sono pochi, superi in qualità quella di tutti gli altri suoi colleghi. D’altra parte, per me Dylan ha costituito un mistero e dunque una sfida fin dall’adolescenza, per l’eccellenza di cui ho appena detto, per il carattere enigmatico di molte sue canzoni e per il loro tono biblico che oscuramente percepivo, ed ero ancora adolescente quando mi sono ripromesso di scrivere prima o poi un saggio sull’argomento.
A cosa stai lavorando attualmente? Quale sarà il tuo prossimo libro? Puoi anticiparci qualcosa?
Il mio prossimo libro, che per la verità è un libretto piuttosto sottile, è un saggio su I vortici di Van Gogh. È già scritto e sarebbe dovuto andare in stampa lo scorso marzo, poi il covid ha bloccato il lavoro di edizione, che spero possa riprendere presto. Si tratta di un’analisi della pittura di van Gogh a partire dal suo carattere “turbolento” e con particolare attenzione ai vortici che vi sono esplicitamente rappresentati, prima di tutti quello che campeggia al centro della Notte stellata. L’analisi spazia dalla fisica, poiché van Gogh ha straordinarie intuizioni di dinamica dei fluidi, alla metafisica, grazie soprattutto all’evidenziazione dei suoi rapporti con l’arte orientale, con le immagini del mondo fluttuante giapponesi, ovviamente, ma anche con la pittura taoista che ne è l’inconscio. I due approcci si completano a vicenda, perché cerco di dimostrare che la fisica delle turbolenze assume in van Gogh la funzione di un simbolismo metafisico.
In cantiere ho poi un libro su Eugenio Montale e la fantascienza, e più in generale sulla fantascienza italiana “colta”. Oltre a Montale e alla fantascienza americana, coinvolge Borges (ancora!), Sergio Solmi, Italo Calvino, Dino Buzzati, Federico Fellini… È quasi finito, ma la sua pubblicazione non è ancora in vista. Uscirà un’anticipazione sotto forma di articolo in una rivista. Un altro articoletto sul tema l’ho già pubblicato una decina d’anni fa e qualche accenno al Montale fantascientifico c’è anche nell’ultima edizione della Scienza della fantascienza.
Infine, grazie anche al lock down, ho ripreso a lavorare a un grosso e ramificato progetto iniziato molto tempo fa: una serie di studi su Bosch e Rabelais, i quali hanno un orizzonte culturale molto simile, popolare ed esoterico al tempo stesso. In particolare ho messo a punto un articolo piuttosto consistente sul simbolismo delle regioni artiche che ritroviamo in entrambi gli autori. Mi riferisco alle regioni artiche della geografia cinquecentesca, naturalmente.
A conclusione del nostro breve excursus resta ancora da accennare al tuo lavoro come curatore: due opere che non escono dal perimetro dei tuoi interessi e delle suggestioni estetiche e culturali a te care. La prima evidenzia ancora il tuo rapporto fascinoso con il mondo dell’infanzia: un’infanzia, potremmo dire, al quadrato o al cubo, perché è l’infanzia dei nostri padri o dei nostri nonni: sto parlando di un bellissimo libro di/su Antonio Rubino, nome purtroppo oggi quasi dimenticato dal grande pubblico, in realtà una figura cardine dell’immaginario, comparabile, per le sue derive visionarie, a quanto rappresentato, e molto meglio ricordato, per gli americani e il mondo anglofono, da personaggi come il Winsor McCay di Little Nemo e Gertie The Dinosaur, o il Richard Felton Outcault di Buster Brown, etc. A differenza dei due nomi che ho citato, però, Rubino non era solo, o prevalentemente, un artista figurativo, ma un vero e proprio scrittore: e questo libro lo dimostra.
L’altra opera da te curata è invece un tributo a Umberto Eco a commento del suo primo e più famoso romanzo, Il nome della rosa. Visto che con Eco abbiamo cominciato, direi che, quasi seguendo le linee di un ouroboros ermetico, con Eco possiamo terminare la nostra piacevolissima chiacchierata. A te la parola.
 La mia edizione delle Fiabe del tempo futuro in stile Novecento di Antonio Rubino è nello stesso tempo un altro effetto ritardato delle mie passioni infantili e uno dei miei lavori nell’ambito degli science fiction studies. Avevo sei anni quando incautamente mio padre mi regalò i suoi vecchi Corrieri dei piccoli degli anni Trenta. Incautamente perché in breve tempo li distrussi. Ho conservato però fino a oggi le pagine che mi avevano colpito di più: le tavole di Bibì e Bibò e, soprattutto, i racconti e le poesie di Rubino. Effettivamente Rubino non era solo un grande illustratore, ma anche un fine scrittore. Straordinarie certe sue poesie nonsense, molto anglosassoni, di cui pure mi piacerebbe fare un’antologia. E tra i suoi racconti i migliori erano queste storie di fantascienza, modernissime e piene di ironia, scritte per la maggior parte tra il 1932 e il 1933. Rubino avrebbe voluto ricavarne un libro, che però fu rifiutato dall’editore Bemporad a cui l’aveva proposto. Io l’ho ricostruito sulla base di una sua lettera e l’ho pubblicato insieme ad altri suoi testi fantascientifici reperiti nell’archivio della sua famiglia e a un mio apparato storico-filologico.
La mia edizione delle Fiabe del tempo futuro in stile Novecento di Antonio Rubino è nello stesso tempo un altro effetto ritardato delle mie passioni infantili e uno dei miei lavori nell’ambito degli science fiction studies. Avevo sei anni quando incautamente mio padre mi regalò i suoi vecchi Corrieri dei piccoli degli anni Trenta. Incautamente perché in breve tempo li distrussi. Ho conservato però fino a oggi le pagine che mi avevano colpito di più: le tavole di Bibì e Bibò e, soprattutto, i racconti e le poesie di Rubino. Effettivamente Rubino non era solo un grande illustratore, ma anche un fine scrittore. Straordinarie certe sue poesie nonsense, molto anglosassoni, di cui pure mi piacerebbe fare un’antologia. E tra i suoi racconti i migliori erano queste storie di fantascienza, modernissime e piene di ironia, scritte per la maggior parte tra il 1932 e il 1933. Rubino avrebbe voluto ricavarne un libro, che però fu rifiutato dall’editore Bemporad a cui l’aveva proposto. Io l’ho ricostruito sulla base di una sua lettera e l’ho pubblicato insieme ad altri suoi testi fantascientifici reperiti nell’archivio della sua famiglia e a un mio apparato storico-filologico.
Quanto ai Saggi sul “Nome della Rosa” è un tributo a Eco voluto dall’editore Bompiani. Il nome della Rosa era uscito nel 1980 e nel 1983 era già un best seller internazionale che aveva suscitato un’imponente bibliografia. Bompiani chiese a Eco chi avrebbe potuto curare un’antologia di saggi sul romanzo, ed Eco, su suggerimento di Omar Calabrese, come mi disse, scelse me e mi mise in contatto con Mario Andreose alla Bompiani. Il contratto prevedeva un compenso di tre milioni di lire di allora, una boccata d’ossigeno per le mie finanze di precario appena sposato. Il mio fu un lavoro soprattutto di scelta. Erano stati pubblicati ormai centinaia di articoli e saggi sul romanzo: io ne scelsi trentacinque, ai quali aggiunsi qualche nota di commento e un’introduzione. Era il secondo libro che firmavo da solo, dopo la prima edizione della Scienza della fantascienza.
È vero, il serpente si morde la coda. Hai citato Eco e Calabrese nella tua prima domanda e sono contento che con l’ultima tu mi permetta di ricordare ancora una volta questi cari amici e la loro generosità.



