La buona notizia è che il Capitale è morto. La cattiva è che al suo posto forse stiamo cominciando a conoscere una nuova forma di dominio economico peggiore, un nuovo modo di produzione basato sul controllo asimmetrico dei dati che generiamo in ogni istante di vita. E’ la “bomba” che McKenzie Wark, scrittrice, ricercatrice e teorica australiana di media theory, lanciava due anni fa nell’introduzione di Capital Is Dead: Is This Something Worse? (Verso, 2019), ora pubblicato da Nero Edizioni. Ma la domanda che il testo pone non è tanto se questa tesi – che cioè il capitalismo abbia lasciato il posto a qualcosa d’altro, tesi sviluppata con zelo marxiano atipico e corrosivo nelle pagine del libro – sia vera o falsa quanto se oggi saremmo pronti a verificarla, eventualmente ad accettarla, qualora la posta in gioco fosse tornare a orientare le nostre energie di animali politici per il verso giusto.
Il tema dei saperi e dei bias conoscitivi figura, del resto, anche al centro del suo ultimo libro, Sensoria (Verso, 2020), una galleria di artisti, progettisti e pensatori selezionati da McKenzie Wark per accompagnarci attraverso le sfide del XXI secolo. Sensoria si apre sull’immagine del classico elefante in una stanza per rivisitare il mito della caverna platonica. Nel puzzle frammentato delle moderne “competenze”, l’elefante viene non solo percepito (sensate) da ciascun osservatore, in conformità con le proprie gerarchie in fatto di vista, tatto, olfatto, etc ma raccontato agli altri in base alla propria adesione a uno specifico impianto di tassonomie scientifiche, narrazioni simboliche, ascendenze religiose, etc. Il paradosso – l’elefante nella stanza – non svela certo un difetto di sinestesia, a cui possano porre rimedio i nostri sensi, eventualmente aumentati da qualche tecnologia postumana, quanto il limite proprio della nostra episteme nel momento storico presente. Il nostro problema è che, pur consapevoli della loro finitezza, continuiamo ad affidarci a narrazioni specialistiche, che si proiettano però verso di noi, ciascuna per conto proprio, come tante bolle che si gonfiano nello spazio del sapere, con la pretesa di raccontare l’assoluto, di offrire un quadro descrittivo totalizzante, dentro a un’illusione persistentemente umanista.
Ma torniamo al Capitale. Capital Is Dead arriva al termine di un decennio iniziato con Occupy e le rivolte nelle piazze di New York o del Cairo autoconvocate via Twitter, in un clima di “’ottimismo “post-capitalista” alla Paul Mason che vedeva la fine della proprietà più o meno iscritta nel passaggio all’economia digitale e l’avvento di una share economy “dal basso” un obiettivo a portata di mano, anzi di acceleratore. Una linea di pensiero non certo estranea in passato a McKenzie Wark, autrice nota soprattutto grazie A Manifesto Hacker (Harvard Univ Press, 2004), forse il più popolare di una lunga serie di manifesti che hanno punteggiato negli ultimi 30 anni l’ascesa dell’etica hacker, non solo nella riflessione politica, a partire da quello dell’e-zine Phrank, The Hacker Manifesto (1986) per finire con il Telecomunist manifesto di Dmytri Kleiner (Institute of Network Cultures, 2010), tutti oggi disponibili in rete. Una prospettiva che, con le approssimazioni del caso, possiamo definire “accelerazionista di sinistra” e che, nelle sue molteplici sfumature, da J.D. Bernal a Nick Srnicek, colloca la tecnologia al centro di qualsiasi ipotesi di cambiamento sociale. Questa linea di pensiero, osserva oggi McKenzie Wark, sembra averci raccontato solo metà della storia, nessuno di questi autori infatti “ha molto da dire sul’Antropocene” e sulla crisi climatica.
Ma Capital Is Dead arriva anche, e soprattutto, dopo le tensioni teoriche tese a fotografare, a partire dagli anni ‘70, il volto sempre cangiante del “neoliberismo”, visto come un ciclo della modernità che ha spostato il suo baricentro su finanza, comunicazione, produzione “immateriale”, automazione robotica, etc. Partite dagli studi sul “nuovo spirito del capitalismo” e sui soggetti che caratterizzano la fase “toyotista” (anni ‘70-’90) le analisi si confrontano, almeno a partire dal nuovo millennio, soprattutto con i nodi strategici (AI, internet, Big Data..) di una fase all digital, concomitante alla ascesa degli Over The Top Google, Amazon, etc e dei loro omologhi cinesi.
Anche qui McKenzie Wark la mette giù piano:
“La bizzarria di questo stato di cose viene elisa apponendo semplicemente una variazione sulle idee tramandate a proposito del Capitale. Basta aggiungere un termine che lo qualifichi: capitalismo della sorveglianza, capitalismo delle piattaforme, capitalismo neoliberale, capitalismo postfordista, etc. […] Come possiamo sentirci tanto a nostro agio nel descrivere una realtà con cui non ci sentiamo affatto a nostro agio? Abbiamo cercato nel linguaggio una certezza che non potremmo trovare altrove?”
La consuetudine a considerare “ancora capitalismo” un sistema di dominio che si basa non più sulle fabbriche ma sui data center (non per questo immateriale o meno materiale del precedente), sul controllo asimmetrico dell’informazione e non sul lavoro salariato, nasce secondo MCKenzie Wark da un pregiudizio radicato soprattutto attraverso il marxismo accademico. Il suo esito è una fallacia nei sillogismi conseguenti, che potremmo riassumere così: dopo il capitalismo viene il comunismo, e questo sicuramente non lo è, ergo è capitalismo. Detta altrimenti: possiamo accettare che gli operai non facciano la rivoluzione ma non che, nel frattempo, l’abbiano fatta gli “altri”. Ad esempio una classe di nuovi “padroni” digitali.
La Prima conseguenza, per dirla con Mark Fisher e Fredric Jameson, è che è più facile immaginare la fine del mondo che non quella del capitalismo. Ma un altro esito non meno paradossale, nota la studiosa australiana, sta nella torsione a cui è stata sottoposta, nel frattempo, la nozione di “classe”, tra il ritorno a categorie analitiche durkheimiane (macroclassi professionali) o di derivazione weberiana (classe tecnocratica) e la sua frantumazione in una specie di nebbia sociologica, preludio, di fatto, alla sua scomparsa dalla scena politica. A titolo di esempio, si cita il concetto di precariat, indicato dall’economista Guy Standing “come una classe emergente e non come una condizione di vita all’ultima spiaggia” .
Ma come starebbero invece le cose secondo McKenzie Wark, che rivendica per sé un un punto di vista radicalmente materialista? Intanto ai piani alti sarebbe in corso una guerra i cui esiti appaiono ormai scontati: una nuova classe, quella dei “vectorialisti”, cioè i signori del digitale, a cominciare dai vari Google, Amazon., Facebook, etc sta sostituendo i capitalisti ai vertici della catena di comando, per incorporarli nel proprio modo di produzione, come questi ultimi hanno fatto due secoli fa con i landlord terrieri. Un nuovo “layer” digitale, che connette l’internet delle cose ai desideri delle persone, si è sovrapposto al vecchio modello capitalistico definendo in tempo reale l’orientamente del vettore che collega l’abbondanza dell’informazione con la scarsità delle merci:
“Il vettore comprende la capacità di trasmettere, memorizzare e processare l’informazione. E’ il mezzo materiale per assemblare i cosiddetti big data e realizzare un potenziale predittivo. La classe vettoriale possiede e controlla brevetti che gli consentono di monopolizzare questa tecnologia. Possiede brands e celebrities per galvanizzare l’attenzione. Possiede la logistica e le catene di fornitura che mantengono l’informazione in un regime proprietario”
Nel nuovo ordine “vettoriale” la classe subordinata è ora quella degli “hackers”: la sua definizione non si discosta molto da quella del più noto “cognitariato”, gente che si suda flessibilmente la pagnotta nell’arena affollatissima del “lavoro intellettuale”. Quindi ingegneri, professionisti, comunicatori, artisti, etc. ma non solo. A differenza della “classe creativa” descritta di Richard Florida, la sua composizione può comprendere anche temporaneamente chiunque di noi, ogni volta che ci accingiamo a generare contenuti e “differenze”, variazioni culturali o semplicemente dati utili all’estrazione del valore vettoriale. Per immaginare all’opera queste “frazioni di noi stessi” – o, detta in termini deleuziani, “dividui” – pensiamo al rider di Deliveroo quando aggiorna i suoi social o lascia un commento su Twitch, ma in un certo senso anche mentre pedala segnalando alla app in tempo reale i suoi spostamenti nella rete metropolitana dei servizi.
Accanto all’hacker, il lavoratore verso cui converge il modo di produzione dominante, non scompaiono per questo le classi storicamente subordinate dei workers industriali e dei farmer contadini, che ovviamente sussistono, benché assoggettati a rapporti di produzione storicamente declinanti. Tuttavia, i loro antagonismi “locali” (cioè contro i capitalisti) e le rispettive, divergenti culture valoriali sono oggi, alla pari delle aspirazioni degli hackers (fare una startup, diventare il boss, etc), facilmente componibili e controllabili dal sistema nel suo complesso.
Non è importante approfondire in questa sede la solidità o meno dei fondamenti teorici su cui McKenzie sviluppa la sua ipotesi di discontinuità, quanto riconoscere, almeno per un attimo, la portata della sua provocazione: la nostra percezione degli eventi è sempre “storica”, perché ad essa concorre in primo luogo l’adattamento di saperi tramandati. Il tema è poi sempre quello dell’elefante nella stanza, “fotografato” secondo le credenze di chi ritiene di conoscerlo già attraverso una tassonomia che si è così estesa nel tempo da comprendere ora anche gli elefanti rosa, senza proboscide o con orecchie da pipistrello. L’elefante nella stanza è ancora il capitalismo? Quando abbiamo cominciato ad esserne così sicuri? Ai tempi delle sue origini o quando un giovane hegeliano ha detto “fanculo l’economia politica”?
Per farsene un’idea basta ricorrere a quella “macchina del tempo” che è la Storia (come suggerisce il titolo di uno dei capitoli del libro) e trasportarsi nel Trecento dei banchieri fiorentini, nel Cinquecento dei Conquistadores spagnoli o, persino, a fine Settecento per ammirare la prima macchina a vapore con condensatore separato di James Watt. In tutti questi casi non troveremo nessuno ad avvertirci che sta nascendo un nuovo modo di produzione anche se possiamo divertirci a immaginare un proto-accelerazionista del passato che ci descriva magari il passaggio dal capitalismo schiavista dei galeoni a quello “vaporoso”. In altre parole, occhiali e attitudine nuove, in grado di descrivere e orientare il cambiamento, non ce li fornisce oggi la tradizione intellettuale accademica e, nello specifico, neppure quella marxista. Per farlo, meglio forse mettersi nei panni del giovane Karl Marx, quello del film di Raoul Peck:
“Quello che sottolineo è come Marx e i suoi compagni più prossimi cambiarono il linguaggio e lo stile del movimento progressista dei loro tempi. Si liberarono dalle idee ricevute, anche quelle di una esclusiva tradizione radicale. In termini volgari: erano punk”
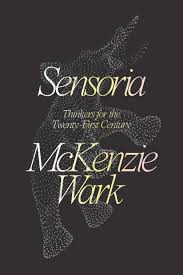 Da questa inclinazione punk a liberarsi delle sovrastrutture culturali e politiche tramandate, discende oggi per McKenzie Wark anche l’attitudine del “marxismo da strada” (trivial), il solo in grado di guardare dritto alla struttura materiale del dominio, senza distrarsi e perdersi nella nella vastità del consenso o nella minorità del dissenso. “Per anni sono stata una che la cosiddetta Alt-Right chiama “marxista culturale”, interessata per lo più a ciò che capita nella sovrastruttura culturale e politica della società moderna. Ovviamente la cultura ti porta a capire i media e anche un po’ la tecnologia. Tuttavia, nelle università, da alcune generazioni, le forme raffinate del pensiero teorico marxista occidentale non sono in grado di descrivere le forze di produzione al lavoro oggi”.
Da questa inclinazione punk a liberarsi delle sovrastrutture culturali e politiche tramandate, discende oggi per McKenzie Wark anche l’attitudine del “marxismo da strada” (trivial), il solo in grado di guardare dritto alla struttura materiale del dominio, senza distrarsi e perdersi nella nella vastità del consenso o nella minorità del dissenso. “Per anni sono stata una che la cosiddetta Alt-Right chiama “marxista culturale”, interessata per lo più a ciò che capita nella sovrastruttura culturale e politica della società moderna. Ovviamente la cultura ti porta a capire i media e anche un po’ la tecnologia. Tuttavia, nelle università, da alcune generazioni, le forme raffinate del pensiero teorico marxista occidentale non sono in grado di descrivere le forze di produzione al lavoro oggi”.
Rispetto al marxismo raffinato (genteel), che ha fin troppi padri, quello “triviale” può riconoscere i suoi simili non per la postura più o meno “eretica” o per la narrazione “non ortodossa” che ci trasmette, ma per il punto di vista che assume e da cui prende ogni volta le mosse. I suoi strumenti linguistici – intellettuali, politici, etc – arrivano dopo, saranno scelti rispetto ai fini del momento o si presenteranno lungo la strada. McKenzie Wark fa quattro esempi, tratti dal secolo scorso
- Andrey Platonov, che nel suo romanzo speculativo Chavengun, racconta il lavoro dopo la Rivoluzione d’Ottobre dal punto di vista dei contadini ai margini della provincia e non da quello costruttivista degli editi staliniani e della Locomotiva della Storia.
- Pierpaolo Pasolini, in particolare quando impara a usare il cinema per raccontare il neocapitalismo ai suoi nuovi adepti, con un linguaggio “moderno”, non mediato dai cascami della cultura clericale e scolastica del suo tempo.
- Angela Davis, che spiega come la schiavitù abbia controllato per secoli le relazioni sessuali tra gli afroamericani e come “le donne del Blues contestavano la nozione di “high culture” della borghesia nera che denigrava la musica popolare della working class” .
- Asger Jorn, l’artista che distingue tra “avere un punto di vista materialistico sul mondo” e “avere un’attitudine di vita materialista”, due cose entrambe importanti ma per lui profondamente diverse. Perché, nell’arte e nella vita, la forma non può essere usata come veicolo di un’essenza, come una specie di Uber per arrivare in tempo al vernissage.
Ma chi sarebbero oggi i nuovi marxiani senza paraocchi e di quali gli strumenti teorici possono disporre? L’ultimo libro di McKenzie Wark, Sensoria: Thinkers for the Twentieth-first Century, può anche essere visto, in questo senso, come una ripresa e un sequel del discorso, e fatto iniziare dove finisce Capital is dead: visioni molteplici di un mondo scoperchiato con attitudine punk non nostalgica. Non offre biografie esemplari, Sensoria, ma modelli di pensiero utili ad affrontare l’era dell’Antropocene, in una sorta di simbiosi non disciplinare di saperi provenienti da diversi ambiti, filosofici, scientifici, artistici, sociologici, etc. . Diviso in tre sezioni – Estetica, Etnografica, Tecnica – descrive in modo conciso ed efficacemente condensato l’elefante nella stanza dall’angolazione di una ventina di “pensatori radicali che stanno conferendo nuova forma al mondo” [1] . Si va dalla discussione sull’uso di un termine emergente e apparentemente insignificante come “cute” nei dialoghi tra giovani adulti alla Cina del XXI secolo, dall’analisi del sistema industriale carcerario in USA alle radici dell’approccio “low theory” nell’estetica e nei suoni tecnologici della musica afrofuturista, fino al superamento del binarismo umano/non umano nei miti della tradizione amerindia. Un prisma di saperi non ordinabili secondo una gerarchia o una teoria tramandate, per cominciare a rimettere in moto quella macchina del tempo che è la storia.
NOTE
[1] Sianne Ngai, Kodwo Eshun, Lisa Nakamura, Hito Steyerl, Yves Citton, Randy Martin, Jackie Wang, Wang Hui, Anna Lowenhaupt Tsing, Achille Mbembe, Eyal Weizman, Cory Doctorow, Benjamin Bratton, Tiziana Terranova, Keller Easterling, Jussi Parikka, Deborah Danowich and Eduardo Viveiros de Castro



