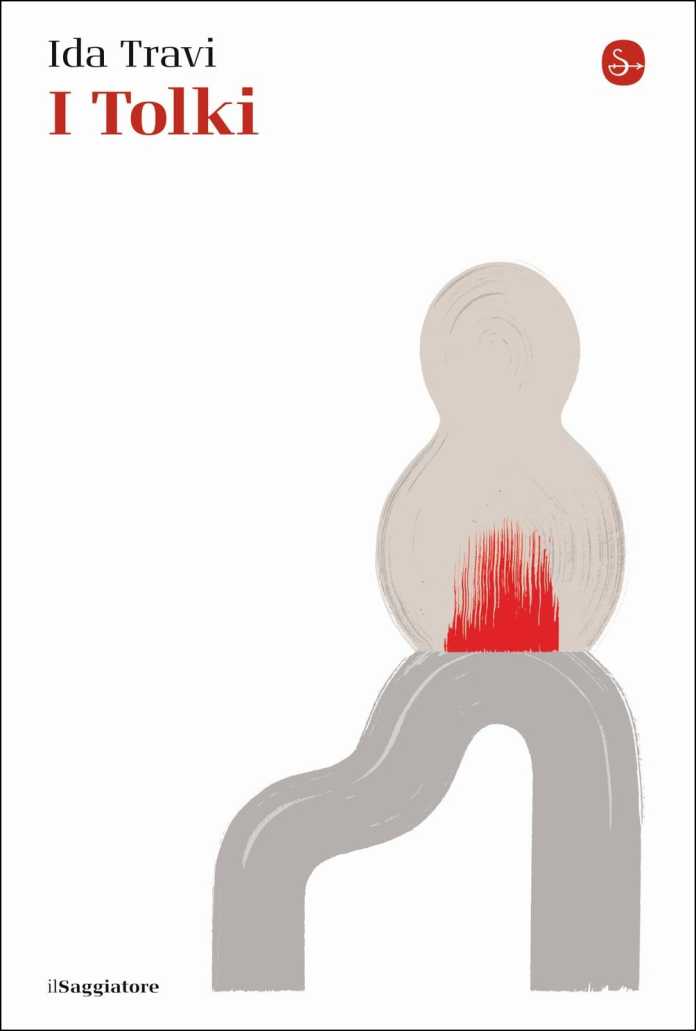I Tolki sembrano esseri randagi che si spostano nello spazio dei libri, uno spazio asettico eppure non neutro. Appaiono come personificazioni del linguaggio a partire dal nome latamente onomatopeico che suggerisce un parlottare continuo, un ticchettio simile a un brusio di massa, ma non c’è alcun popolo se non nelle sillabe che si uniscono all’interno delle parole, e poi confluiscono nei discorsi. Le particelle fonetiche minime, così, mostrano la loro inclinazione a solidarizzare tra segni-essenti per individuarsi e individuare un senso, seppur enigmatico, nel vocabolo riconoscibile e comunicabile. Sono terragni, vestiti come noi, materiali e immateriali, stordenti, infestanti, appena nascosti, appena visibili, appena esistenti, mutevoli nella posa, sfuggenti. Contraltari di un’umanità che si volge al suo post-umano. Il parlêtre lacaniano, il corpo parlante auto-individuato e individuante l’altro per relationem, è segnato dall’inconsistenza eppure profondamente vitalistico nella sua peculiare trama mentalizzata. Tale incorporalità oggettuata, tramite la mente, emerge proprio dal linguaggio e dall’immagine derivante da esso. Eppure, è dal linguaggio subito contraddetta: la parola non ha corpo, ma è nel corpo che nasce e del corpo che si fa testimone.
I Tolki, forse, sono i mille corpi della parola e, quindi, dell’individuo, in un tempo senza tempo (o un “tempo assoluto”, come l’orecchio con la musica), una storicità a-storicizzata, nel paradosso del continuum esistenziale. Sono collegati al lavoro, a quel fare connesso semanticamente con la poesia (poiein), nella pronuncia del suono («sento la musica della tua parlata») che diventa segno dal fonosimbolismo primordiale dell’umanità fino alle nuove declinazioni/derivazioni onomatopeiche del linguaggio da social. I versi sono tra loro diversi come i corpi, ogni testo è uno scorcio, o uno squarcio di qualcosa di più grande ma dolorosamente spezzettato. Un postmoderno che sembra rinunciare alle sue velleità decostruzionistiche per presentare il quotidiano così com’è, a brandelli.
“TA’” (titolo del primo libro) è un nome, un soprannome, un diminutivo, un idioletto, un nascondimento della personalità o della sfera personale, il primo soggetto e il primo oggetto movente, il primo cittadino senza città, l’ombra dell’uomo che non trova sé stesso. E subentra in fretta il noi, pur rimanendo impalpabile. Sembra stabilire, questo noi inatteso, parentele ataviche e, quindi, latamente palinodiche, in un ambiente beckettiano, isolante, sardonico, incompiuto. Un ambiente che appare esterno ma anche interno, esternalizzato ma anche interiore, una “casa pubblica” e piena di contraddizioni. È un’opera civile, politica? Solo in un’accezione trasfigurale del termine: sembra trattarsi di un post-politico che guarda ai fenomeni sociali attraverso l’astrazione, la decontestualizzazione, la frammentazione del discorso engagé e la sua riproduzione in ambienti linguistici e paesaggistici volutamente stranianti.
L’interpunzione è parte integrante di questi corpi lessicali, e pasolinianamente introduce elementi discorsivi (ma non esattamente dialogici) nel testo. Ed è proprio fra i vari testi che si viene a creare un rapporto di reciproca sopravvivenza, di relazione stretta per cui uno vive nell’altro, risultando inscindibili fra loro nel discorso. Una forma di velato ermetismo intride alcuni versi e, molto spesso, le chiuse, un ermetismo non orfico che trae dal reale la sua oscurità.
Nel ri-assemblamento testuale, tante perle espressive brillano e mettono in risalto la possibilità del dettato di dislocarsi, di funzionare anche in altri modi rispetto a quelli comuni, di rivelare l’appartenenza ad altri scenari, ad altri ambiti di realtà. Una realtà letteraria che non intende mimetizzarsi con quella reale ma, anzi, vive di una vita autonoma, collegata alla prima da stretti rapporti logici, fonetici e di esperienza. L’animalità pervade soggetti e scene, una zoomorfia che implica un ampliamento dei significati, una costante trasfigurazione degli ambienti e dei sentimenti, entrambi costellati di segni mitici e archetipici.
“Cosa cerchi nei libri” è un testo che contiene una dichiarazione di poetica e, contemporaneamente, una lettura della vita, forse perfino delle relazioni tra scrittori e tra di essi e i lettori: «Qualcuno spinge il tempo sotto l’ala/qualcuno tiene il tempo con lo sputo, la gente/prega sotto il grande sputo». Un contesto agreste, naturale, sembra interfacciarsi con qualcosa di sconosciuto, misterioso, innominato, che attiene a questi nomi insoliti, a questa unità segmentata, a questa pluralità radunata, a questi organismi senza organicità che chiacchierano e si dimenano nello spazio, ma non si sa dove, in che modo, in quale tempo.
Compare una poesia che sembra fare il verso a Quasimodo («Ognuno se ne sta / come un bicchiere / al suo posto, al suo posto») riconducendo un’antica eleganza ermetica all’oggettualità contemporanea, allo schianto con le cose, con i nomi di cose, con la concretezza che, però, non coincide con la limitatezza del finito. La presenza di frasi d’uso comune crea un ambiente linguistico familiare, spaesando e insieme accogliendo il lettore che poco si può orientare tra personaggi e sagome e posti che non conosce. In effetti, ci si può solo lasciare trascinare da questi mini-racconti come da una serie di eventi apparentemente scollegati eppure tra loro continuativi.
«Dici sempre – con noi / ma che vuol dire noi, noi chi?»: in questo libro le domande (e ce ne sono tantissime) sono i veri indizi, le tappe del percorso a ostacoli che si devono seguire per provare a decodificare il metatesto, ciò che c’è ma non si legge. D’altronde, «Fa’ in modo che le parole non / facciano pensare a una poesia, / ma lo siano». Nella prosa iniziale di “Il mio nome è Inna”, sembra che si voglia dare compagine fisica a questi esseri dematerializzati, una compagine che agglomerando entità diverse, proprio come nell’alfabeto con le lettere, assomiglia a una famiglia queer, un magnifico incontro di solitudini diverse, perfino incompatibili tra loro, eppure pronte a occupare uno spazio comune – quello del suono – a partire dai nomi: «In fondo ci amiamo noi quattro / per questo ti aiuto, Zet / per questo ti allatto, Nikka».
Fatti non ne esistono se non nei molteplici segnali della natura e delle coscienze («La neve è caduta sull’ematoma / qui, sul gonfiore, al centro») e si può assistere a una costante consustanziazione tra il corpo e l’elemento ambientale, entrambi vittime e carnefici, artefici di un destino che non esiste. Forse non è il caso di fare un discorso sulle figure icastiche del libro (il bambino, il vecchio, il dottore, la donna, l’io e il tu, la ragazza, la vecchia), perché qui, in mancanza di contorni netti e di un contesto preciso, si rischierebbe di immettere contenuti specifici in elementi che fondano la loro presenza sulla volatilità, sull’essere impalpabili, irraggiungibili.
Otto libri (nove, perché uno s’è perso) uniti in uno solo, un’opera aperta secondo la lezione di Eco che abbraccia passato e futuro trattandoli come unico lascito nel presente. Il mistero, il dubbio (attraverso il domandare) rimangono la chiave di lettura più valida di queste poesie, così come della vita: «io dirò la preghiera / dirò tutta la storia / al tuo orecchio / solitario, antico». Se, come scrive Derrida, «la necessità di diventare fiato o parola stringe il senso – e la nostra responsabilità del senso -, la scrittura stringe e costringe ancora di più la parola», poiché «fiato che si mozza da se stesso per ritornare in sé, per aspirarsi e tornare alla sua sorgente», allora i Tolki si sono imposti all’autrice come la vastissima gamma di sentimenti ed emozioni che dal linguaggio misteriosamente provengono, in un turbine di reciproci rimandi che rimangono ignoti, proprio come i protagonisti di questa poesia, nonché il nostro inconscio.