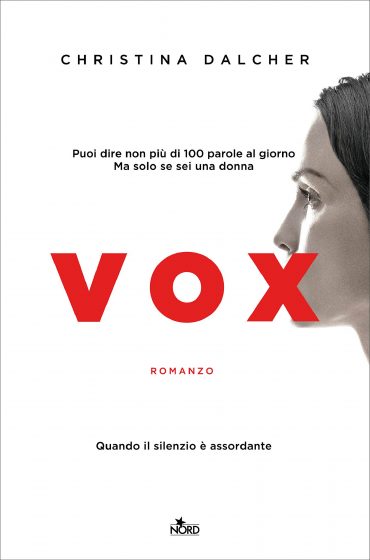Viene presentato come «lo straordinario romanzo di cui tutti parlano», e già questa frase mi ha fatto venire brutti presentimenti. Comunque mi sono cimentato nella lettura di questo romanzo, anche perché lo pubblica la Nord, casa editrice che per uno della mia età è associata a bei ricordi (come la storica edizione della Svastica sul sole di Dick con la prefazione di Carlo Pagetti, tanto per dirne una). Cosa ho trovato?
All’inizio, diciamo per le prime cento-centocinquanta pagine di questo corposo romanzo, avremmo una distopia: un’America governata da un presidente un po’ più a destra di Trump, ispirato da un predicatore fondamentalista biblico convinto che bisogni rimettere in riga le donne, riportarle nel focolare dopo averle scacciate dai posti di lavoro e dalle istituzioni statali e federali. E fin qui niente di nuovo: altro non è che Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood traslato nel XXI secolo. La novità dovrebbe essere il lato linguistico, nella misura in cui la protagonista, Jean, è una neurolinguista forzata a diventare casalinga, scacciata dall’università dove lavorava e dai laboratori dove ricercava una cura per l’afasia. Una neurolinguista che adesso non solo non può più esercitare la sua professione, ma neanche articolare più di 100 parole al giorno, se non vuole ricevere una sgradevolissima scossa elettrica dal braccialetto contaparole che è stata costretta a mettere al polso e che non può togliere per nessun motivo (tanto per avere un metro di paragone, pare che ogni giorno una persona pronunci mediamente 16.000 parole…). Questo perché il reverendo Carl Corbin, l’ispiratore del presidente, è convinto che le donne faranno meglio a stare al loro posto zitte e mute, a meditare sui loro errori, tipo volere la parità con gli uomini, errori che stavano mandando in malora gli Stati Uniti e pure il resto del mondo.
Fin qui ero disposto a continuare nella misura in cui l’intento trasparente della Dalcher mi pareva quello di attaccare l’amministrazione Trump e le sue derive conservatrici e retrive attraverso la narrazione distopica, pur se indebitata con la Atwood. Nella scrittura distopica a ben vedere c’è spesso la ripresa dei precedenti, perché le storie più classiche vengono riattualizzate per focalizzarsi sui mali del momento. Lo ha fatto Roth ne Il complotto contro l’America, mobilitando Sinclair Lewis e Philip K. Dick contro Bush figlio, tanto per fare un esempio illustre; e perché non avrebbe dovuto farlo la Dalcher?
Inoltre va detto che in alcune scene l’autrice di Vox riesce a far entrare il lettore abbastanza bene nel mostruoso meccanismo repressivo all’opera in quest’America anche troppo vicina, e a far sentire in imbarazzo un lettore di sesso maschile (come chi scrive) nel constatare che il regime autoritario e discriminatorio del romanzo gioca su meccanismi radicati nella psiche di noi uomini (e qui la figura del figlio maggiore della protagonista, Steven, e la sua accettazione della repressione, risulta credibile in modo quasi inquietante). E poi, per quanto la scrittrice non entri molto nei meccanismi dell’afasia di Wernicke, oggetto delle ricerche di Jean prima della repressione, i suoi trascorsi di linguista le consentono di trattare l’argomento con una certa sicurezza.
Però Dalcher non è né Atwood né Roth, e lo si vede anche troppo bene quando il romanzo scivola dalla distopia nel thriller, nella misura in cui la protagonista viene costretta dal governo a riprendere la sua attività di ricercatrice e liberata (temporaneamente) dal braccialetto silenziatore perché è forse l’unica in grado di trovare una cura per il fratello del presidente degli Stati Uniti, che ha perso l’uso della parola a causa di un incidente di sci. Questo la porta a ritrovare il suo amante italiano (di nome Lorenzo Rossi) e la sua fidata collaboratrice Lin. Inoltre la mette in contatto a sorpresa con un movimento clandestino di resistenza…
E qui casca il romanzo, perché la Dalcher, che già si muoveva senza grandissima sicurezza nel racconto distopico, riuscendo comunque a risultare credibile, rivela tutti i suoi limiti svoltando verso il thriller. Evidentemente questo genere, affatto diverso dalla distopia, non è proprio nelle sue corde: la storia a questo punto barcolla, ci sono incongruenze, avvenimenti che non stanno insieme, scelte per lo meno bizzarre (come quella di non mostrare ai lettori la scena risolutiva), cadute di tensione clamorose. Inoltre alla lunga emerge la debolezza dei personaggi, specie quelli negativi, piuttosto stereotipati; e se in un film dove il bene si scontra col male è l’attore più bravo che deve fare il cattivo (lo sapeva già Shakespeare), in un romanzo come questo la costruzione dei malvagi sessisti al potere avrebbe dovuto essere più convincente.
Infine il lieto fine appare decisamente troppo consolatorio se confrontato alla situazione presentata inizialmente, e viene in mente che sotto sotto l’America distopica dell’inizio, che tutto sommato stava in piedi e aveva una sua cupa dignità, fosse solo uno sfondo minaccioso per la storia d’azione decisamente fiacca che segue. Peccato, perché si sentiva il bisogno di un libro che suonasse l’allarme sulla controffensiva tradizionalista contro la parità dei sessi, tesa a imporre un modello di famiglia (e società) unico e piuttosto vetusto (e non solo negli Stati Uniti, vedi certe proposte nostrane…); ma Vox non risulta all’altezza del compito.