Ci sono tre pericoli, di stampo quasi adolescenziale, nell’approcciare il mondo della pirateria che si sviluppò all’alba dell’epoca moderna in diverse latitudini. E David Graeber (1961-2020), antropologo, anarchico, attivista noto sopratutto per la sua partecipazione al movimento Occupy, dimostra non solo di conoscere bene tali insidie, ma di volerle accuratamente evitare in L’utopia pirata di Libertalia, tradotto e pubblicato ora per i tipi di Eleuthera, di cui pubblichiamo qui di seguito l’introduzione.
Il primo è il fascino che gli irregolari del mare esercitano ancora oggi nell’immaginario e nella cultura di massa. Fascino che spesso prende il sopravvento sulla ricostruzione storico-scientifica di quanto avvenne realmente nei territori da loro attraversati, conquistati o addirittura amministrati. Studiando sul campo e per diversi anni le tracce degli insediamenti politici della pirateria in Madagascar, Graeber non cede a queste illusioni.
Lungi dal sottolineare l’eccezionalità libertaria e la natura romantica di quegli esperimenti, l’antropologo americano pone subito l’accento sul fatto che le fonti e le testimonianze giunte sino a noi risentono fortemente del mito, quindi del carattere affabulatorio delle narrazioni orali, spesso agiografiche. Bisogna destreggiarsi in un dedalo di interpolazioni, quindi, ma allo stesso tempo riconoscere all’interno di queste l’influenza di caratteristiche sociali peculiari.
La nave pirata fu davvero un microcosmo nato dall’insubordinazione dell’ammutinamento di equipaggi regolari: una comunità che perciò si trovava ad organizzarsi “orizzontalmente” quasi per inerzia, delegando al capitano soltanto il privilegio di comandare gli assalti. E tali assalti, lungi dall’essere mera operazione di rapina (siamo pur sempre nei secoli del colonialismo più feroce e sadico) diventavano l’incipit di un sistema anticonvenzionale di gestione delle ricchezze, che portò poi molti corsari ed i loro seguaci a diventare stanziali, col conseguente tentativo di tradurre le modalità di organizzazione interna delle navi in progetti collettivi, sempre legati ad un territorio specifico – prevalentemente un’isola o un porto.
Il secondo errore potenziale da evitare è quello di vedere le figure dei filibustieri e i loro esperimenti di autogestione come profondamente conflittuali rispetto alle comunità indigene, quindi come delle specie di enclaves fondate sulla presunta superiorità dell’europeo bianco, declinata in termini di violenza o di lignaggio.
Graeber è abilissimo nel confutare questa tesi.
Concentrandosi sul versante nord orientale del Madagascar, rileva quanto il rapporto con le popolazioni autoctone e l’inclusione sociale dei pirati – prima attraverso i matrimoni, poi attraverso la progressiva emancipazione delle spose – sia stata fondamentale per la loro permanenza, a differenza di quanto avvenne con gli eserciti coloniali, indifferenti all’integrazione, perciò restii a comprendere gli usi locali e interamente concentrati sulla sottrazione dei traffici commerciali, quanto sul potere coercitivo delle armi.
Non è un caso se la maggiore e più cruenta rivolta contro una comunità di pirati nell’area analizzata da Graeber sia avvenuta proprio quando un ex corsaro (di nome Adam Baldridge), trasformatosi in feudatario e trafficante di schiavi verso l’America del Nord, decise sciaguratamente di deportare in catene anche donne e bambini. Un affronto che portò i malgasci a distruggere completamente la sua fortezza e a sterminare i pirati ivi rimasti, così come a stoppare ogni genere di traffico di schiavi, ma non ad interrompere il rapporto con le navi corsare e con i loro equipaggi.
Il terzo ed ultimo errore dal quale Graber vuole distoglierci è quello di ritenere che in uno scenario costituito da scorrerie ed espropri, conflitti tribali e potentati locali, non vi fosse alcuno spazio per l’affinamento dei metodi di governo. Nè che tale lavoro di discussione e partecipazione assembleare, aperto anche alle figure femminili, fosse trasmissibile.
La realtà del Madagascar tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo dimostra il contrario: è proprio una figura meticcia (figlio di un pirata e di una donna malgascia) passata alla storia col nome di Ratsimilaho a fondare la comunità più duratura e “libertaria” ante litteram, nella località di Ambonavola. Un esperimento durato trentasei anni, proprio in quanto capace di coniugare rituali e tradizioni malgasce con uno spirito che Graeber, coraggiosamente, non esita a definire “illuministico”.
Perché di queste forme politiche si discuteva (e molto) nelle capitali dei caffè e dei teatri, tra Londra e Parigi, dove l’aura maudit dei pirati vantava un pubblico crescente.
Perché tali esperimenti si trovavano ad essere in qualche modo figli dei reietti europei e infine perché, come fa l’autore, dovremmo sempre chiederci “è davvero sensato designare come ‘europei’ gli ideali dell’Illuminismo, e in particolare quelli di emancipazione dell’umanità?”
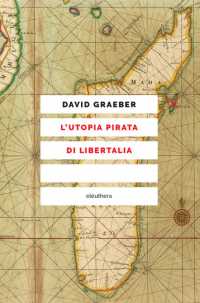
Estratto da David Graeber, L’utopia pirata di Libertalia, tr. Elena Cantoni, Eleuthera edizioni, pp. 216, euro 17.00
Un Illuminismo (molto) radicale
Parlare di «Illuminismo pirata» è un’evidente provocazione, a maggior ragione oggi quando l’Illuminismo è caduto in disgrazia. Se nel Settecento i rappresentanti dei Lumi si consideravano pensatori radicali il cui intento era spezzare le catene di ogni autorità imposta dall’alto ed elaborare una teoria universale della libertà umana, i pensatori radicali odierni tendono invece a considerare il progetto ideologico dei Lumi come la strada maestra dell’ordine costituito. Ai loro occhi, l’Illuminismo è il movimento intellettuale all’origine di una forma specificamente moderna di individualismo razionale divenuta la base del razzismo «scientifico», dell’imperialismo, dello sfruttamento e del genocidio contemporanei. E non c’è alcun dubbio che fu proprio questo ciò che accadde quando gli imperialisti, i colonialisti e gli schiavisti europei educati alle idee illuministe furono sguinzagliati per il mondo. Resta però da discutere il rapporto di causalità. Quegli uomini avrebbero agito diversamente se, come nei secoli precedenti, avessero dovuto continuare a giustificare il proprio operato in termini di fede religiosa? Non credo. Ritengo semmai (come ho già sostenuto altrove: Graeber 2007a) che così impostato il dibattito ci distrae da un problema più fondamentale: è davvero sensato designare come «europei» gli ideali dell’Illuminismo, e in particolare quelli di emancipazione dell’umanità? Ho il forte sospetto che quando gli storici del futuro si volgeranno indietro a esaminare la questione, la loro risposta sarà no. L’Illuminismo europeo fu principalmente un’era di sintesi intellettuale. Trovandosi d’un tratto al centro di imperi globali ed esposte a idee nuove e – per loro – sorprendenti, nazioni prima intellettualmente arretrate come l’Inghilterra e la Francia si sforzarono di integrare tra loro elementi diversi come gli ideali di individualismo e libertà sorti nelle Americhe, un nuovo concetto di Stato-nazione burocratico ispirato alla Cina, le teorie africane del contratto e le teorie economico-sociali originariamente sviluppate nell’islam medievale.

Per ovvi motivi, i rari casi in cui quella sintesi trovò applicazione pratica, in particolare nella sperimentazione di nuove forme di organizzazione sociale improntate alle idee degli «illuministi», non ebbero luogo nelle grandi città europee, ancora sotto il controllo dei vari Anciens Régimes, ma alla periferia del nuovo sistema mondiale emergente, principalmente negli spazi di relativa libertà operativa aperti sulla scia delle imprese imperialistiche e dei capovolgimenti che ne derivarono. Questi capovolgimenti furono spesso eventi di enorme violenza, con la distruzione di interi popoli e civiltà preesistenti. Ma è importante ricordare che non sempre si trattò solo di questo. Ho già indicato, sia pure di passaggio (Graeber 2007a, p. 353), il ruolo fondamentale svolto dai pirati in tutto questo, soprattutto come pionieri nello sviluppo di forme innovative di governo democratico. Tipicamente gli equipaggi delle navi pirata riunivano un ampio assortimento di soggetti di varia provenienza, e dunque avevano familiarità con una quantità di strutture sociali differenti (un’unica nave poteva imbarcare inglesi, svedesi, schiavi africani fuggiaschi, creoli caraibici, nativi americani, arabi…). Votati a una sorta di approssimativo egualitarismo pratico, e posti di fronte a situazioni in cui urgeva la creazione di nuove strutture istituzionali, questi equipaggi rappresentarono in un certo senso un laboratorio perfetto di sperimentazione democratica. Almeno uno storico illustre del pensiero politico europeo ha ipotizzato che alcune delle forme democratiche sviluppate in seguito dagli statisti illuministi del mondo nord-Atlantico furono collaudate per la prima volta a bordo delle navi pirata, negli anni Ottanta e Novanta del Seicento:
Tra le prime esperienze degli equipaggi pirata agli albori del mondo atlantico moderno dovremmo annoverare quella di un potere derivante da un consenso dal basso invece che conferito da un’autorità dall’alto. Quegli equipaggi non soltanto eleggevano i propri capitani, ma avevano istituito poteri di controllo (nella persona del quartiermastro o nella forma di un consiglio di bordo) e relazioni contrattuali tra l’individuo e la collettività (sotto forma di articoli consensuali volti a regolamentare la spartizione del bottino e riconoscere i risarcimenti per gli incidenti sul lavoro) (Markoff 1999, p. 673, n. 62).
Per esempio, benché la versione storica consolidata riconosca ai pirati un’influenza sulla creazione della Confederazione betsimisaraka, la spiegazione che viene offerta è – letteralmente – genetica. Secondo la storia accreditata, il popolo betsimisaraka sarebbe stato creato dai figli meticci dei pirati e delle donne malgasce, sotto la leadership ispirata di un malata (mulatto) particolarmente carismatico, chiamato Ratsimilaho, accettata passivamente dai nativi malgasci, il cui contributo consistette nel giurargli obbedienza. Lo stesso Ratsimilaho viene rappresentato come un importatore di invenzioni europee preesistenti, per esempio il concetto di Stato-nazione, e non come un elaboratore di soluzioni politiche in proprio. L’interpretazione convenzionale del periodo coloniale data dallo storico francese Hubert Deschamps (riportata qui di seguito) è a tutt’oggi la visione prevalente:
Tale fu dunque il grand’uomo, il figlio di un pirata che si impose come principe in virtù della propria intelligenza e del proprio carattere. Egli riuscì a raggruppare insieme le tribù disperse della costa orientale che avevano vissuto nell’anarchia, nella guerra e nella miseria, e le trasformò in uno Stato potente e prospero, garantendone la durata e la coesione. […] Fu il primo a introdurre sull’isola maggiore il concetto di Stato territoriale, seguendo senz’altro l’esempio dei paesi europei. […] Ma dopo di lui il suo regno si sfaldò (Deschamps 1972, p. 203).
In realtà quasi niente di questa visione standard regge la prova di un esame più attento. In primo luogo, come vedremo, sebbene l’esistenza di Ratsimilaho sia documentata, come pure il fatto che fosse figlio di una donna malgascia chiamata Rahena e di un pirata inglese di nome Thamo o Tom, pressoché tutti gli altri malata erano ancora bambini al tempo in cui fu fondata la Confederazione [1]. Inoltre, le fonti di cui disponiamo affermano in modo esplicito che, con l’eccezione di Ratsimilaho, chi allora era già adulto rifiutò di averci niente a che fare.
In secondo luogo, non esistono prove cogenti che il regno di Ratsimilaho somigliasse anche solo lontanamente a uno «Stato territoriale». Anzi, non c’è prova dell’esistenza di un regno di alcun tipo. Una campagna archeologica condotta nella regione (Wright 2006; cfr. Wright e Fanony 1992) non ha ravvisato traccia di cambiamenti nei modelli di insediamento dopo la creazione del «regno», e nessun altro archeologo o studioso di altre discipline ha trovato lungo la costa nordorientale vestigia di qualcosa di simile a una burocrazia amministrativa o a un sistema di classi sociali risalenti al periodo. Tutti i dati indicano che gran parte delle decisioni veniva presa, così come si era sempre fatto, in assemblee popolari in cui tutte le persone implicate negli esiti avevano diritto di parola. Anzi, vedremo più avanti come ci siano buoni motivi per ritenere che in realtà l’organizzazione politica e sociale diventò meno gerarchica, rispetto al passato, dopo la creazione del «regno»: i gradi dell’aristocrazia guerriera citati in resoconti precedenti spariscono del tutto in quelli successivi, segno che le assemblee dovevano avere acquisito ancora più peso. È vero che gli zana-malata diventarono qualcosa di simile a un’aristocrazia ereditaria endogamica, che alla fine del Settecento tornò persino alle consuetudini degli antenati pirata, organizzando scorrerie ai danni delle isole Comore e addirittura di Zanzibar. Ma questa casta fu sempre considerata fondamentalmente esterna alla società, e infine il suo potere fu spezzato da una rivolta popolare poco prima che il territorio venisse incorporato nel regno degli altopiani del Madagascar, nel 1817 (Carayon 1845, pp. 15-16).

La tesi che sostengo in questo libro è che l’arrivo dei pirati determinò una serie di rivoluzioni nella regione. La prima e forse la più importante fu guidata in larga parte da donne, e puntava a spezzare il potere rituale ed economico del clan che in passato aveva fatto da intermediario tra gli stranieri e i popoli della costa nordorientale. La creazione della Confederazione betsimisaraka fu di fatto la seconda di queste iniziative, e andrebbe vista come una reazione maschile alla prima. Dietro la facciata dei pirati e sotto la guida formale di un re-pirata meticcio, i capi-clan e gli ambiziosi giovani guerrieri avviarono quello che ritengo andrebbe considerato come un esperimento politico proto-illuminista, una sintesi creativa dell’autogoverno pirata e di alcuni degli elementi più egualitari della cultura politica malgascia tradizionale. Ciò che in genere viene liquidato come un tentativo fallito di istituire una monarchia, può invece essere altrettanto facilmente interpretato come un esperimento riuscito di Illuminismo pirata a guida malgascia.
Note
[1]. Di più: nessuno di loro poteva aver superato i ventun anni allo scoppio della guerra, nel 1712, perché solo a partire dal 1691 circa abbiamo prove di una significativa presenza di pirati attivi in Madagascar. Dello stesso Ratsimilaho si dice che al tempo fosse diciottenne.



