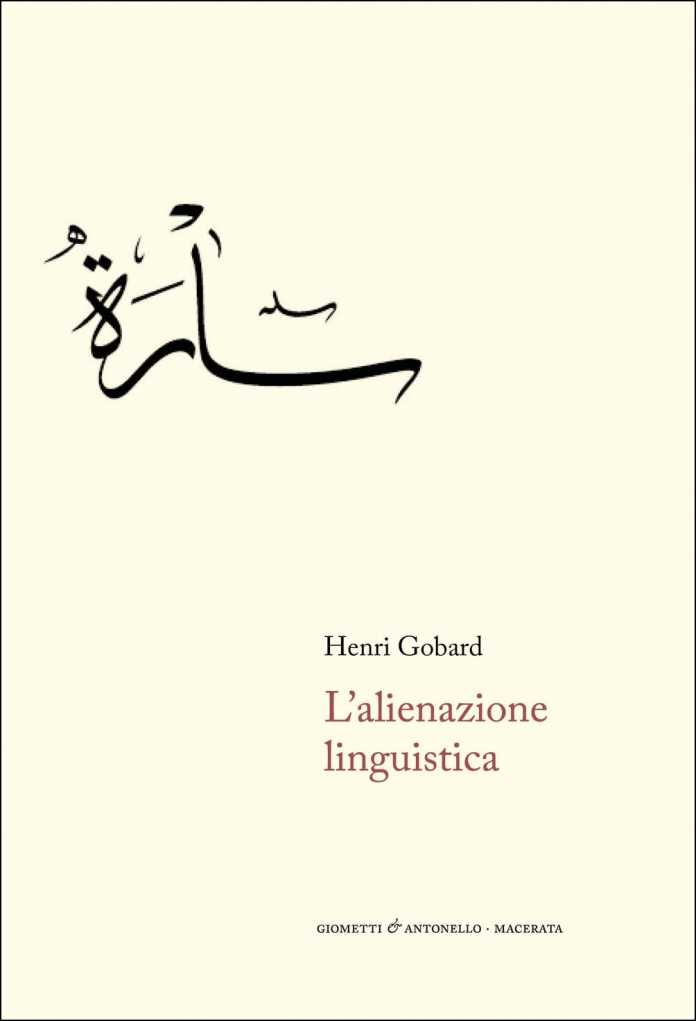Scorrendo la biografia di Henri Gobard sulla bandella di questo libro si ha l’impressione di avere a che fare con un personaggio tanto centrale quanto eterodosso nella cultura francese ed europea degli anni Settanta e successivi. Gobard è stato professore nel dipartimento di psicologia e inglese di Paris VIII Vincennes sin dalla sua fondazione, nell’annus mirabilis 1968, traduttore dall’inglese di alcune opere di Georges Devereux e precursore dello scritto di Deleuze e Guattari Kafka. Per una letteratura minore (1975), che tanta parte ha oggi – non di rado, tramite volgarizzazioni che ne esaltano alcuni aspetti a discapito di altri – negli studi letterari, anche italiani. Al tempo stesso, Gobard è molto più che una figura sfuggente: di lui si sa pochissimo altro, riferendosi ai suoi studi su Nietzsche, e le prime superficiali ricerche in rete non danno risultati confortanti.
La decisione di tradurre questo saggio, a più di quarant’anni dalla sua pubblicazione originale, nel 1976, reca dunque lo stigma del preziosismo, ma anche della follia creatrice, arricchendo un catalogo già noto per il suo grande valore. L’alienazione linguistica – nelle parti, almeno, che sono ora note al pubblico, perché la (comprensibilissima) scelta editoriale è stata quella di omettere “contenuti legati a un contesto e a un periodo troppo specifici” – è un testo che presenta un discreto commercio con la sociolinguistica, cioè con una disciplina che negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorsa è rifiorita, fino ad arrivare alla sua complessa e sofisticata formulazione contemporanea. Al tempo stesso, è un’opera intessuta di molti altri riferimenti politici, culturali e letterari, che colpisce per il suo carattere ondivago, brioso, mai scontato – sempre fuori, insomma, da ogni pastoia accademica.
Si prenda, a titolo di esempio, la citazione riportata in quarta di copertina e che da sola vale l’acquisto del libro: “…E dire che ci sono professori d’inglese che parlano inglese per parlare inglese e che così si guadagnano il pane: siamo a Ionesco! Che d’altronde ha trovato la sua ispirazione geniale in un celebre manuale d’inglese. Questi manuali in fondo ci dicono: prima imparate a parlare, dopo potrete dire qualcosa! Non capiscono nulla del processo di acquisizione del linguaggio: si parla solo se prima si ha qualcosa da dire: SENZA DESIDERIO NON C’È PAROLA”. Si lasci perdere – se non si è toccati in prima persona, come chi scrive, dal riferimento agli insegnanti di lingua inglese – il vaghissimo sciovinismo, poi puntualmente corretto e deviato in altre parti del testo, con il quale Gobard approccia, nello specifico, l’insegnamento della lingua inglese nelle scuole dove la prima lingua veicolare è il francese, nonché la conseguente trasformazione dei francofoni in “gallo-ricani”: quei sudditi, in altre parole, di un potente imperialismo culturale e linguistico, che devono a questo punto recuperare una connessione profonda, quasi “sentimentale” (lo splendido esergo iniziale del libro è tratto, manco a dirlo, dai Quaderni del carcere), con la loro lingua, le loro lingue.
 Si guardi invece alla frase conclusiva, a caratteri cubitali. È una regola ben nota (magari in altre forme, accademicamente impostate) a chiunque oggi si avvicini all’insegnamento – passando per un’esperienza altrettanto, se non più, vicina al teatro dell’assurdo di Ionesco come quella dei concorsi nazionali per la cattedra (e questo, tanto in Italia quanto altrove) – ma è anche un mantra per un filosofo come Gilles Deleuze. Quest’ultimo è non per caso autore di una brillante prefazione, dove si legge: “Le lingue […] sono delle poltiglie, dei quarks alla Joyce, che non sono sostenuti da strutture, ma in cui soltanto delle funzioni e dei movimenti giungono a mettere un po’ di ordine polemico. Gobard ha ragione perché, quando si ha qualcosa da dire, si è come uno straniero nella propria lingua. […] Fino adesso i linguisti hanno saputo troppe lingue, il che ha permesso loro di compararle, e di fare della scienza nient’altro che scienza pura. […] Per lui il problema è altro, alla maniera dei grandi medici-malati del linguaggio. Come essere balbuziente, non balbuziente di parola nella parola, in una lingua, ma essere balbuziente del linguaggio? (Il più grande poeta in lingua francese, ma per l’appunto è di origine rumena, è Ghérasim Luca: ha inventato quel balbettio che non è quello di una parola, ma del linguaggio stesso)”.
Si guardi invece alla frase conclusiva, a caratteri cubitali. È una regola ben nota (magari in altre forme, accademicamente impostate) a chiunque oggi si avvicini all’insegnamento – passando per un’esperienza altrettanto, se non più, vicina al teatro dell’assurdo di Ionesco come quella dei concorsi nazionali per la cattedra (e questo, tanto in Italia quanto altrove) – ma è anche un mantra per un filosofo come Gilles Deleuze. Quest’ultimo è non per caso autore di una brillante prefazione, dove si legge: “Le lingue […] sono delle poltiglie, dei quarks alla Joyce, che non sono sostenuti da strutture, ma in cui soltanto delle funzioni e dei movimenti giungono a mettere un po’ di ordine polemico. Gobard ha ragione perché, quando si ha qualcosa da dire, si è come uno straniero nella propria lingua. […] Fino adesso i linguisti hanno saputo troppe lingue, il che ha permesso loro di compararle, e di fare della scienza nient’altro che scienza pura. […] Per lui il problema è altro, alla maniera dei grandi medici-malati del linguaggio. Come essere balbuziente, non balbuziente di parola nella parola, in una lingua, ma essere balbuziente del linguaggio? (Il più grande poeta in lingua francese, ma per l’appunto è di origine rumena, è Ghérasim Luca: ha inventato quel balbettio che non è quello di una parola, ma del linguaggio stesso)”.
Comprendere la qualità desiderante delle lingue vuol dire, dunque, passare attraverso i fuochi incrociati del modernismo novecentesco, traendone una consapevolezza completamente diversa rispetto all’impianto burocratico delle abilità e delle competenze normalmente richiesto ai glotto-discenti. Si tratta di un approccio poetico, si potrebbe dire, che mette una certa concezione della poesia e della letteratura al centro, facendo emergere, di rimbalzo, il potenziale veramente trasgressivo – al di là di ogni facile rinvio alle situazioni di diglossia tipiche, ad esempio, della cosiddetta “letteratura migrante” o della “letteratura postcoloniale” – della “letteratura minore” descritta, appunto, da Deleuze e Guattari negli stessi anni.
L’analisi tetraglossica (il linguaggio è, per Gobard, vernacolare, veicolare, referenziale o mitico – lasciamo a chi vorrà leggere di indagare le peculiarità di ogni categoria) che viene proposta da Gobard è, in effetti, fungibile anche in ambito postcoloniale e diasporico e ha qualche addentellato, come si diceva, nella moderna sociolinguistica. Ha, però, dei tratti poetici, e intimamente eversivi, che hanno finito inevitabilmente per allontanare il libro di Gobard dai dibattiti più seri (o seriosi). Le quattro lingue di Gobard, in fondo, sono anche definibili come: linguistica, letteratura, politica e spirito critico. E un’analisi che mantenga insieme questi livelli non può che far bene a chi la leggerà, e vorrà avere a che fare con questo eclatante oggetto testuale non identificato proveniente dal cuore degli anni Settanta, o forse da molto prima.