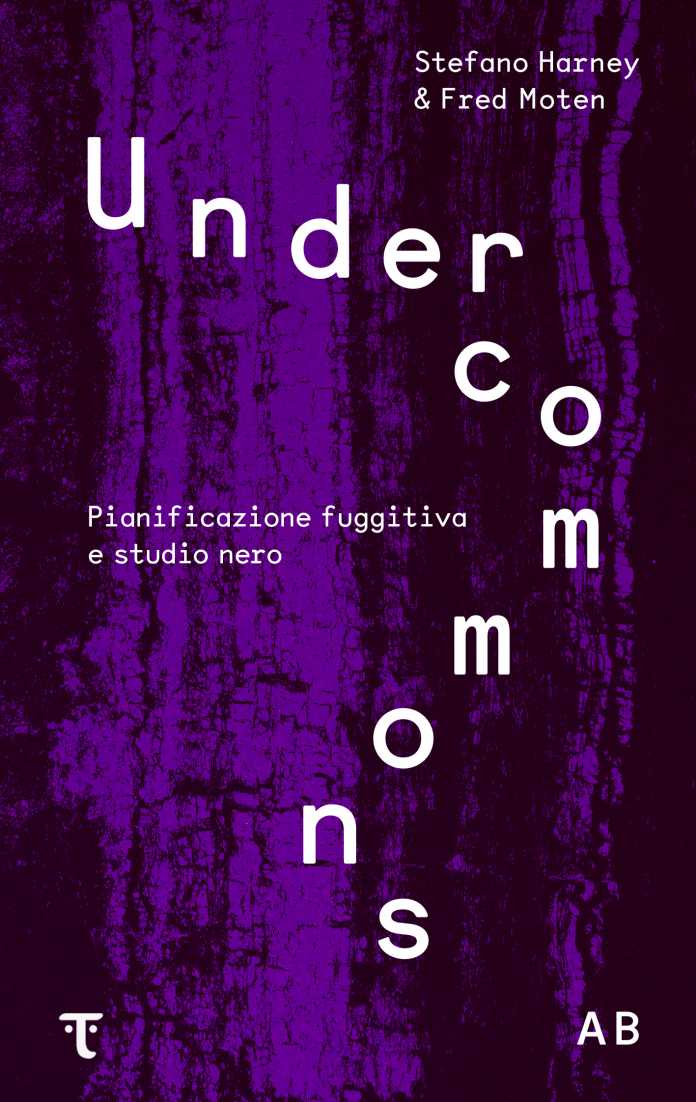Undercommons è un testo potente e meraviglioso, un assalto programmatico allo stato delle cose, a partire dalla scelta stessa di una scrittura che si addensa con pennellate concentriche attraverso sette saggi, fino a risultare poeticamente dirompente. Fino a entrarti sotto pelle un lessico che può suonare esigente e difficile come tutto quello che non si conosce prima di cominciare. Perché è un linguaggio sicuramente originale, quello tradotto in queste pagine, che sconfina a volte nel gioco, come nel rimasticamento colloquiale o nell’urgenza intellettuale, sperimentando e trasmettendo una libertà a cui non si è preparati, pur nel dichiarato debito degli autori con Deleuze, Fanon, per non dire con tutto il pensiero radicale afroamericano e quello dell’autonomia operaista italiana. E forse anche per questo lo si continua a leggere, Undercommons, a distanza di anni (è del 2013), perché anziché criticare le storture e le oscenità del presente prende di petto le antinomie alla base della società neoliberale che danno poi vita a “questo schifo”. Che non passano mai.
È un libro, non secondariamente, pensato e scritto nel regime di una conversazione e di un’amicizia, quella tra Fred Moten, poeta, teorico di Black studies, di estetica e cultura afro-americana, e Stefano Harney, studioso interdisciplinare e professore di management attualmente alla School of Business at Singapore. Sviluppato a partire dal nucleo di un loro saggio precedente, The University and the Undercommons: Seven Theses (2004), va anche detto, che è un libro sullo studio e non sull’Università. E tra le due cose, capisci subito, c’è tutta la differenza del mondo. Per gli autori l’università infatti è un furto, e lo resterà sempre. La sua professionalizzazione, cioè la sua trasposizione in senso individualista, non può essere stigmatizzata in chiave critica o elitista. Né la sua traduzione in fabbrica delle figure eroico-produttive del ciclo neoliberale (l’imprenditore, l’artista, lo shareholder, etc.) può essere colta come storpiatura o deviazione dalla sua purezza originaria, elevando grida ai mercanti nel tempio illuminista. Al contrario, è solo l’ultimo atto di uno spettacolo collaudato e ritrito, l’accerchiamento del comune da parte dei colonialisti, che decenni di film western e assalti indiani hanno raccontato alla rovescia. Uno spossessamento del sapere collettivo e della nerezza che filtra oggi attraverso il lavoro intellettuale precarizzato da razza, genere e classe. Questo “stare di sotto”, restando spesso invisibili al dominio o, più spesso, evitando di regalargli i propri codici, si raggruma in ciò che Moten & Harney definiscono gli undercommons: i sotterranei dell’Illuminismo, dell’esclusione e della differenza, dove si respira oggi più o meno la stessa aria e la stessa comunanza della stiva delle navi schiaviste.
Come osserva nell’introduzione la TRU (Technoculture Reasearch Unit), curatrice dell’edizione italiana per Tamu Edizioni: “Gli undercommons ci invitano a vedere i commons dal punto di vista dei colonizzati, e il lavoro dal punto di vista dello schiavo, per ripensare il modo in cui oggi i commons ritornano nella forma degli undercommons, l’underground dei commons, in cui lo studio, cioè la pratica di un intelletto sociale, persiste come forma di un ‘antagonismo generale’”. Suo malgrado l’università è infatti anche rifugio materiale per l’intelligenza fuggitiva, per la ricerca sovversiva esodata dalla società, per chi approda all’insegnamento come diserzione e non come carriera. Dice il proverbio: “L’intellettuale sovversivo arriva sotto false credenziali, documenti sbagliati, poco amato”. Per chi frequenta e vive gli undercommons l’unico legame rispettabile con l’università resta quindi il furto, e l’unica attività di (ri)programmazione dell’esistenza propria e collettiva resta lo studio (che l’università, con le sue policy, di fatto impedisce). Qualcosa che, citando letteralmente Tronti, Harney traduce: “lavoro dentro e contro istituzione”.
Come gli undercommons – una concettualizzazione nata dall’esperienza accademica diretta degli autori – non vanno necessariamente ricercati o colti nel legame con l’università, così lo “studio” come attività non corrisponde ad alcuna organizzazione formale o politica ma semmai proprio a quella informalità del sociale che per Moten & Harney è consistente con quanto chiamano “antagonismo generale”. Come mette in chiaro Fred Moten nell’intervista a Stevphen Shukaitis che conclude il libro: “Quando penso al termine ‘studio’, penso che ci siamo impegnati a favore dell’idea che lo studio è quello che si fa con le altre persone. È parlare, è andare in giro con le altre persone, lavorare, ballare, soffrire, una qualche irriducibile convergenza di tutte e tre le cose, tenute assieme sotto il nome di pratica speculativa”.
Nell’ordine post-disciplinare che si estende alla società nel suo complesso non meno che alla realtà universitaria, lo studio si sottrae quindi alle lusinghe e alla chiamata della policy, la voce ragionevole e autorevole della governance, la sua estensione sul piano etico e comportamentale. Dove “governance” è “la gestione dell’autogestione” che emerge oggi come paradigma del livello organizzativo: esterno al tradizionale ambito governativo, rivolto al controllo dell’informale pubblico-privato e al drenaggio salvifico del sociale, la cui autonomia costituisce una sfida aperta all’interesse del Capitale. Chi si sottrae alle imposizioni della policy si rivolge dunque alle pratiche dello “studio nero”, si raccoglie nel laboratorio, nella jam session, esemplificati dell’invenzione jazzistica afroamericana, che, da Mu di Don Cherry e Ed Blackwell a Nation Time di Joe McPhee, attraversano il libro e Moten è ben felice di chiamare a raccolta.