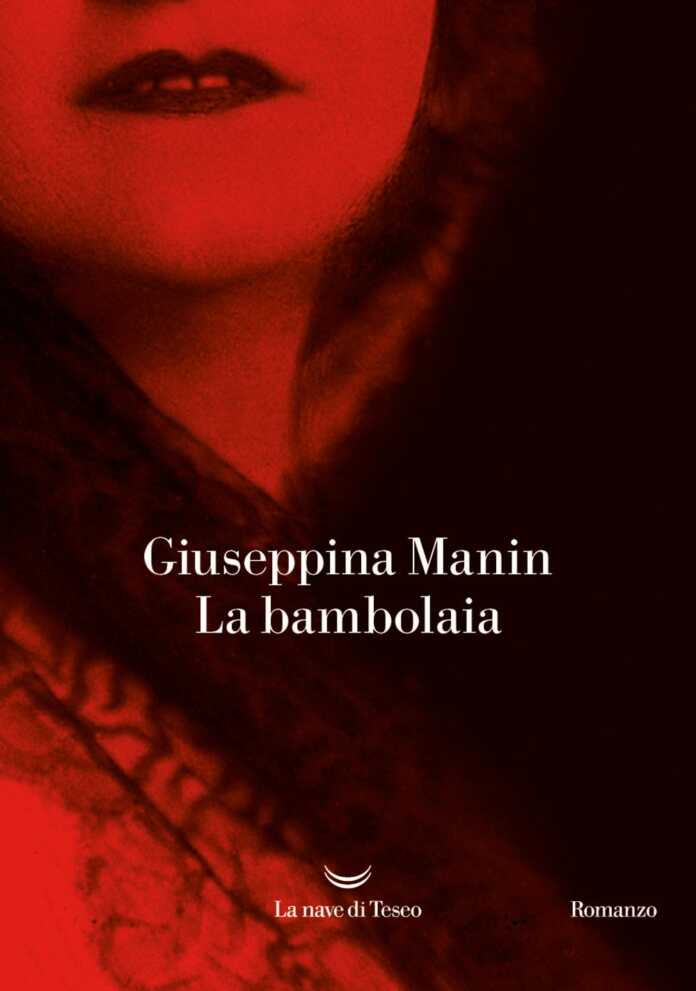La metafisica al servizio dell’ambiguità carnale degli artisti, della sottile malvagità che alcuni iniettano nell’arte. La trama del velour trattiene in sé fantasie e cose poco pertinenti, se guardiamo al mestiere della confezione sartoriale – perfino mostruosità ripugnanti che ci inseguono nelle storie di castelli (Walpole, sì) e di gabinetti autoptici (Frankenstein, sì) più o meno inventati dall’ingegnosità di scrittori aristocratici e consumatori di sostanze. Nel caso della Bambolaia, romanzo in cui passione e intrigo artistico-sessuale non smentiscono gli effetti (molto noti) del perturbante, siamo a Monaco di Baviera, anno 1918. Chi ha frequentato la storia artistica e politica di quel periodo sa quanto i cosiddetti “illeciti” conflittuali guizzino nelle menti europee, che siano “poetici” o “bellici”, che siano apocalittici o degenerativi. In questo tempo prostrato vive la fabbricante di bambole Hermine Moos, abitante nel quartiere degli artisti Schwabing dove si possono incontrare Klee, De Chirico, Kandinsky, Savinio, ma anche Rilke, Brecht, i fratelli Mann (mentre da qualche parte il giovane Hitler dipinge acquerelli). Hermine, abile con colori e pennelli ma di più intrecciando “fili di ferro e fili di lana” costruisce bamboline buffe e infantili che riscuotono un certo successo. Al debutto della storia, Oskar in uno spazio d’arte – una galleria prestigiosa – vede Hermine. Le rivolge la parola. Mentre le sue mani impudenti palpeggiano e frugano gli arti delle bambole lì esposte. “Mi chiamo Oskar, Oskar Kokoschka”. Una presentazione più che novecentesca. E la storia inizia.
Moos è stata menzionata all’artista da Charlotte, detta Lotte, “sinuosa predatrice” e di gran moda quanto le sue bambole Pritzel, sensuali danzatrici alte mezzo metro, definite con rara competenza da Giuseppina Manin “creature gotiche” sontuosamente vestite e portatrici di depravazioni e sventure. Prezzo talentuoso: 500 marchi d’oro. Kokoschka, dagli occhi folli, chiede un appuntamento privato, e Hermine pur con scarsa convinzione lo invita nel suo atelier. La domanda è: “cosa vuole da me il grande K.?” – già, cosa ispira quella donna all’intimo scomposto del pittore austriaco? Cosa lo spinge a viaggiare per cinquecento chilometri, da Dresda, su uno scomodo treno per raggiungerla a Monaco? Si fa presto a capirlo, nelle nicchie accoglienti del racconto di Manin che fruga ogni periodo del rapporto fra la bambolaia e l’artista, evidenziando follie maschili e fugaci derive sentimentali femminili – quest’ultime senz’altro care alla scrittrice (e a noi) perché mai sfrondano la dedizione all’intrapresa. Una mania perfezionista, destinata al fallimento, che non lascia scampo a Hermine Il “grande K.” commissiona la creazione di una bambola che riproduca le sembianze di Alma Mahler, amata da Kokoschka (non certo l’unico) tanto da non riuscire a liberarsi da una vera e propria ossessione.
Salgono zaffate di ombre sulfuree da alcune pagine del romanzo, e spezie dal sapore di laudano. L’oppio rievoca non solo la smania possessiva di Kokoschka per Alma Mahler che pretende di vedere riprodotta nel fantoccio (tale si rivelerà) in costruzione: d’ogni sorta di materiale, liscio e morbido all’inverosimile, simulacro delle pieghe più intime dell’amata. L’osceno sta nei pensieri abnormi di Oskar, nella descrizione canagliesca del sesso, non nella bellezza originale di una donna senza dubbio fascinosa. L’orribile simulacro lo si può vedere in una fotografia, di fronte la sua creatrice in una posa che dimostra un attaccamento per così dire “esotico”. Vicende si mescolano, fra il cortese e l’oscurità macabra, tenendo sempre a mente La sposa del vento, quadro del 2014 di Kokoschka dove il pittore e Alma sembrano corpi fatti di stracci sull’orlo della decomposizione (erotica? Cadaverica?): posa finale che lascia ben pochi dubbi sulla sorte a loro riservata. L’epilogo della Bambolaia ha la competenza curativa di un dossier, come antidoto all’uso abbondante da parte dei protagonisti di morfina, oppio e veronal. Di quest’ultimo morì la povera Hermine nel 1928. Alma, filonazista nonostante i matrimoni con due ebrei, vivrà sprezzante fino al 1964. Oskar, antinazista, visse fino a quasi novantaquattro anni.