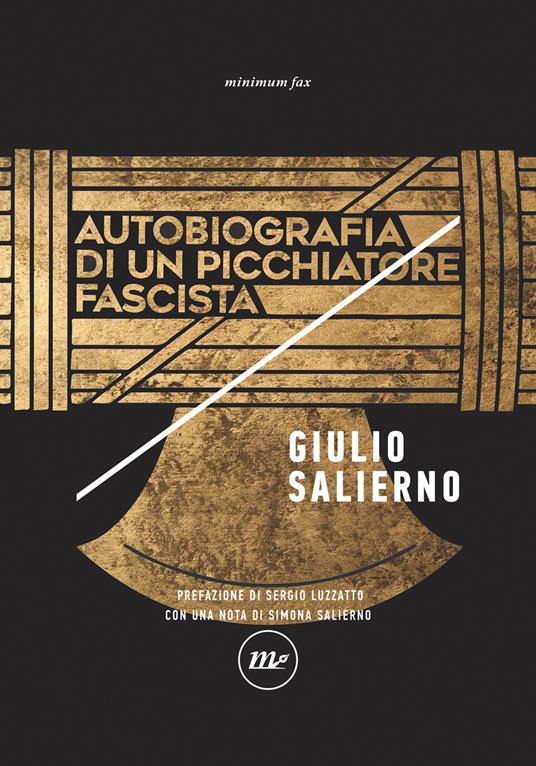L’opera più famosa di Giulio Salierno (1935-2006) fu pubblicata per la prima volta da Einaudi nel lontano 1976, con una nota introduttiva di Corrado Stajano. Questa, recentissima, del 2024 è la seconda edizione della ristampa uscita per minimum fax nel 2008, con una prefazione di Sergio Luzzatto e una nota finale di Simona Salierno, figlia dello scrittore. Confrontando i due testi introduttivi, quello di Stajano e quello di Luzzatto, ci si può fare un’idea precisa di quanto la prospettiva critica su un testo così delicato e controverso sia cambiata (quasi ribaltandosi) tra gli anni cosiddetti “di piombo” in cui uscì e quelli della “globalizzazione” quando fu ristampato. Se infatti per Stajano l’Autobiografia «è la cronaca di una conversione politica, l’itinerario di un giovane che attraverso la cruda esperienza del carcere ritrova un altro sé stesso […] la reclusione è stata una scuola, la conquista di coscienza umana e poi di coscienza politica gli sono venute dalla disciplina dei libri e dall’analisi del passato di cui questa autobiografia è il segno…», per Luzzatto «è un libro postumo per diverse ragioni […] evoca mondi irrimediabilmente lontani da noi, la cui distanza pare doversi misurare in anni luce […] fascisti contro comunisti, camerati contro compagni, neri contro rossi […] Un tempo in cui certe distinzioni valevano ancora, tra la destra e la sinistra, la conservazione e il progresso, i valori e i disvalori. Un tempo in cui si poteva ancora pensare che le cose fossero evidenti e i confini fossero netti, da una parte i buoni, dall’altra i cattivi». E là dove Stajano osserva che la «condizione dei reclusi, il ruolo dell’istituzione carceraria, la scoperta obbiettiva dell’esistenza delle classi rappresentano le molle profonde della sua crescita», Luzzatto invece rinfaccia a Salierno il “vocabolario” e “l’armamentario” del militante rivoluzionario degli anni ’70, con le “formule” e «le forme ideologicamente più stereotipate di denuncia del ‘sistema’ […] Il sapore di un vino presto scaduto in aceto, in un foucaultismo di maniera, o addirittura nell’elogio della popolazione carceraria italiana come avanguardia della rivoluzione proletaria a venire».
Nel 2024, che non è più il 2008, oggi che i figli e i nipoti di quei fascisti descritti da Salierno ce li ritroviamo al governo e la rispettabilissima premier, come molti suoi accoliti, provengono proprio dalla stessa sezione storica del MSI che è lo scenario costante del libro, Colle Oppio, possiamo constatare – ritrovando forse, finalmente, quei “confini netti” che Luzzatto aveva perso – come niente sia mai cambiato in essenza tra gli ex repubblichini da poco scarcerati per l’amnistia Togliatti degli anni ’50, i golpisti bombaroli ma in doppio petto degli anni ’70 e i callidi “post-fascisti” di oggi: identica è l’ipocrisia e il doppiogiochismo (nell’uso strumentale della costituzione per scardinarla dall’interno, nel culto della violenza ripudiato a parole e fomentato nei fatti, nel razzismo e nel nostalgismo totalitario sconfessato in pubblico e coltivato in privato), tutti aspetti rilevati per esperienza diretta e descritti con precisione autoptica nell’Autobiografia di Salierno, stigmi incancellabili di una parte politica sconfitta o data per tale, e a cui invece, passo dopo passo, abbiamo alla fine consentito con disarmata e disarmante docilità la possibilità della rivincita: il degrado politico contemporaneo potrebbe paradossalmente riattualizzare il libro assai più secondo la “vecchia” lettura di Stajano, così intransigente e inattuale, che secondo la “nuova” di Luzzatto, espressione di quell’antifascismo troppo rilassato che ci ha condotto alla situazione presente.
Ma veniamo ai fatti narrati. Salierno, rampollo di una tipica famiglia della borghesia romana, costellata di militari di carriera e di burocrati, fascista per risentimento e per rivalsa, si iscrive a quindici anni al MSI, siamo nei primissimi anni ’50 e i neofascisti stanno strumentalizzando le manifestazioni nazionalistiche per Trieste italiana. Il ragazzo, intelligente e coraggioso, fa una rapida carriera nella sezione di Colle Oppio, «uno scantinato», così riassume Stajano, «sotto il piano stradale, con una nicchia-sacrario dedicata ai caduti della RSI, una croce illuminata, un’aquila sopra la croce, un immenso ritratto di Mussolini» (chissà se l’arredamento era rimasto lo stesso quasi trent’anni dopo, ai tempi in cui lo frequentava la Meloni). Il giovane Salierno cresce nel culto della violenza, un apprendistato squadrista fatto di pestaggi, risse, vandalismi contro le bacheche dei giornali di sinistra e spedizioni punitive: gli amici e maestri, di qualche anno più grandi, sono ex repubblichini che si vantano, ad esempio, di aver spaccato a calci la mandibola a una partigiana slava catturata durante la guerra e di averle poi sparato in faccia, e che lo invitano a provocare da solo una rissa in strada con dei giovani comunisti come prova di iniziazione. «I personaggi», continua Stajano, «sono i fantasmi della repubblica di Salò, ex paracadutisti, reduci della X Mas, marescialli della ‘Folgore’ in pensione, ufficiali epurati del battaglione San Marco […] E, nel grigiore del sottobosco, spuntano talvolta i capi, Junio Valerio Borghese, il maresciallo Graziani, Rauti, Almirante e Julius Evola…». In un vitalismo sfrenato quanto sterile, tra corse in moto a rotta di collo, traffico di armi ed esplosivi, campi d’addestramento paramilitari, il giovane Salierno elabora il sogno di un’azione vendicatrice e rigeneratrice: assassinare Walter Audisio, il colonnello Valerio, presunto uccisore di Mussolini e della Petacci – quando gli aspiranti attentatori obbiettano che il grilletto presumibilmente l’abbia premuto Lampredi e non Audisio, la conclusione è che «Audisio è ritenuto da tutti colui che ha fatto fuori il duce e politicamente è il vero uccisore. Che abbia o meno sparato è un problema che interessa solo gli storici; politicamente è irrilevante». Oltre che vendicare il duce, l’esecuzione di Audisio metterebbe il gruppo dirigente del MSI – in cui ha da poco trionfato l’ala non “socializzatrice” di Michelini e De Marsanich che trama alleanze coi “badogliani” monarchici e con le ali destre e atlantiste della DC – nell’imbarazzo di condannare il delitto, inimicandosi così gran parte degli iscritti e degli attivisti, o non condannarlo, mettendosi nei guai con il Parlamento (un dilemma che ci ricorda altri recenti analoghi imbarazzi meloniani…). Salierno e il camerata a lui più vicino Serse, preparano l’attentato con scrupolo, ma poco prima della data prevista, la solita scapestrata abitudine all’atto gratuito e alla violenza immotivata impediscono loro di portare a termine l’impresa: tentano, per pura bravata, di rubare l’auto a un ragazzo sconosciuto che reagisce e viene abbattuto a colpi di pistola. Una lettera anonima proveniente dagli stessi ambienti missini, che ora li vogliono scaricare, denuncia i loro nomi all’autorità, come colpevoli dell’omicidio, nei giorni immediatamente successivi. Salierno fugge in Francia e si arruola, come nel copione di un noir scontato, nella Legione straniera, ma prima di venir spedito in Indocina a combattere a Dien Bien Phu, un colonnello dell’esercito regolare applica, per la prima volta dopo 153 anni, un regolamento disatteso e lo fa arrestare. Carcere in Algeria – dove impara a conoscere e solidarizza con i patrioti algerini del FLN – poi nel 1954 l’estradizione in Italia. Nei 13 anni di carcere, prima di essere graziato per meriti di studio – primo detenuto iscritto in un’università italiana, economia e commercio – Salierno attraversa una vera metanoia che lo porterà ad abbracciare il marxismo e diventare in seguito, da uomo libero, professore di sociologia: collaborerà con Franco Basaglia nella lotta contro i manicomi e suoi saranno i maggiori saggi dell’epoca sul problema carcerario, Il carcere in Italia (con Aldo Ricci, 1971); Il sottoproletariato in Italia (1972); La repressione sessuale nelle carceri italiane (1973), e molti altri, fino ai primi anni 2000, fiancheggiando Papillon, l’associazione culturale dei detenuti di Rebibbia.
Con uno stile secco e incisivo e un montaggio quasi cinematografico che spazia nel tempo alternando le varie fasi dell’educazione politica e della spietata carriera di picchiatore, fino alle sue naturali conseguenze carcerarie, passando per i momenti tragici dell’omicidio, della fuga e della cattura, Salierno descrive un amaro percorso di redenzione che per molti aspetti ricorda quello di Giose Rimanelli (1925-2018) in Tiro al piccione (Einaudi, 1953), storia di un giovane volontario di Salò che attraverso l’esperienza sanguinosa della guerra civile matura una nuova coscienza e passa nelle file dei partigiani. Un libro, quello di Salierno, utilissimo, soprattutto oggi, per aver ben chiaro quali siano i fondamenti di quell’estrema destra ormai data per sdoganata e rispettabile. Particolarmente inquietante è la descrizione, dietro le quinte, delle figure di certi capi, ormai omaggiati come i padri costituzionalisti. Pino Rauti, che negli anni ’50 già descrive perfettamente la strategia della tensione messa in atto nei due decenni successivi: «La guerra rivoluzionaria […] deve estendersi a macchia d’olio, penetrare negli ambienti più consistenti e influenti della vita del paese […] Dobbiamo sfruttare l’aiuto diretto o indiretto di certe istituzioni chiave dell’apparato statale e quello di alcuni servizi stranieri per arrecare, col concorso di plurime e diverse attività clandestine e pubbliche, il maggior danno possibile ai nostri avversari, intaccandoli nell’apparato organizzativo, nella capacità di risposta ad un’offesa esterna, nel morale e soprattutto nelle alleanze che hanno con gli altri settori della popolazione. Solo così gli attentati, le bombe, acquistano peso politico. La dinamite e la rivoltella devono diventare immagini, pubblicità subliminale. Il loro ruolo effettivo deve essere quello di agire a livello dell’emotività individuale e collettiva. Opporre alla ragione le istanze del profondo della psiche umana» (pag. 144). Giorgio Almirante – ex segretario editoriale di La difesa della razza, il maggior periodico razzista e antisemita durante il regime – un abile politico che riesce a destreggiarsi come un equilibrista fra l’ala atlantista e quella socializzatrice del partito e resta gradito ad entrambe proclamando: «Ripeto oggi che i nostri giovani debbono prepararsi allo scontro frontale con i comunisti. E poiché l’altra volta sono stato male interpretato o si è pensato che per scontro frontale io intendessi soltanto scontro fisico, questa volta vorrei essere bene interpretato e dichiaro che per scontro frontale intendo anche lo scontro fisico. E non ho alcuna ragione per non dirlo» (pag. 213). E più di tutti Julius Evola, il guru mistico, al cui appartamento sopra corso Vittorio, antro dall’aria irrespirabile tappezzato dei quadri del suo periodo dadaista e di una bandiera con la svastica, si accede solo dietro raccomandazione del suo segretario e a patto di “non contraddirlo mai”: Evola che pontifica dalla sedia a rotelle, servito da una governante altoatesina simile a una kapò alla quale si rivolge solo in tedesco, che chiama Hitler un genio, gli italiani Italioti e le donne pupattole; e che proclama oracolarmente «Con la legalità non si risolve nulla. Il cancro comunista va estirpato con il ferro e il fuoco. Contro i sindacati e i partiti occorre agire come fece Hitler il 10 maggio. L’Italia si salverà solo se avremo una guerra civile come in Spagna. […] La formazione di una élite, di un Ordine ascetico-guerriero […] significherebbe […] la costruzione di un centro storico-vivente dell’Europa più pura e legata ai suoi originari valori storici. Un centro che diverrebbe luogo geometrico del processo di concentrazione della gente aria…» (pp. 203-204). Pur intimorito dalla figura lugubremente ascetica del vecchio infermo, che sorbisce rumorosamente un brodino vegetale davanti ai suoi ospiti, Salierno, da persona intelligente commenta: «Invece di eccitarmi, come un modello superiore, la figura tremolante di Evola mi faceva leggermente pena, ricordandomi in qualche modo le ultime immagini di Hitler, precedenti il suicidio nel bunker della Cancelleria. Occhi allucinati ma anche deboli […] Evola, come l’ultimo Hitler, mi sembrava un automa sopravvissuto al suo meccanismo».
La diagnosi finale di Salierno, da tenere ben presente, è inesorabile: «nessuno di noi aveva un futuro. Avevamo imboccato tutti una strada senza uscita: una strada in fondo alla quale c’era solo il carcere, o la fuga in qualche paese straniero, o la morte. Sembra retorica. Non lo è. Del gruppo di punta della sezione di Colle Oppio, la mia sezione, non è rimasto più nessuno. Io ho preso trent’anni. Un altro dieci. Un altro ancora si è ucciso. Due sono morti nella Legione straniera. Uno è crepato facendo bravate con l’aereo. Un altro ancora si è ammazzato a correre in Lambretta. Un terzo è morto con la gola tagliata in Africa. Mi son salvato solo io». Ma è una prospettiva che vale solo per i fanti non per i generali, e poi i tempi sono cambiati: oggi c’è un’altra possibilità, si può perfino finire al governo.