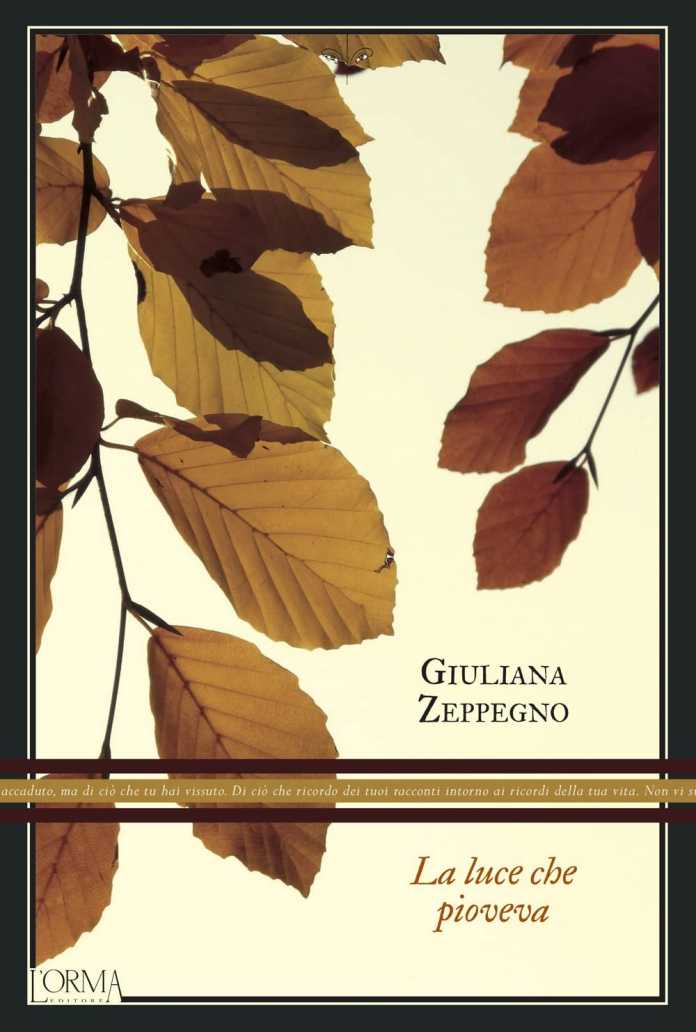Non deve sorprenderci che un seme cattivo come quello di Susanna Tamaro abbia prodotto anche splendidi frutti: cadendo lontano dall’albero, ravvivandosi con menti e cuori giovani, gli intrecci generazionali sono uno strumento ideale per mettere a fuoco insieme il passato e il presente, per guardarsi allo specchio e osservare il mondo che ci circonda. Autrici all’esordio, soprattutto, che dialogano con le generazioni che le hanno precedute, in un confronto necessario a loro stesse e alla comprensione tanto dei vertiginosi cambiamenti che attraversano e sconvolgono il nostro tempo quanto dei punti fermi ai quali si ancorano i sentimenti, gli affetti e la percezione della realtà: questo era il caso di un romanzo passato fin troppo sotto silenzio come Non è vero che siamo stati felici (2020) di Irene Salvatori, classe 1978, ed è il caso di questo La luce che pioveva di Giuliana Zeppegno, quasi coetanea di Salvatori e che, come lei, sceglie la strada della rievocazione della propria madre per costruire una storia che è insieme mosaico, quadro d’insieme, e successione di tessere del mosaico stesso, piccoli quadri di una lucentezza quasi ipnotica, ognuno dei quali rappresenta un intero mondo a sé stante.
Romanzo narrato al presente e al passato, il romanzo scandisce la storia con il suo intreccio che segna insieme continuità e distacco nel dialogo continuo tra figlia, madre e madre della madre, in un arco di tempo che copre quasi cento anni, ma che la modalità narrativa annulla e rende attuale in una continua dialettica del divenire. Allo stesso modo agisce il ricorso alla seconda persona (gli incisi dei “mi dici”, “ricordi”, “mi racconti”) che provoca un effetto straniante, inducendo la sensazione di assistere a uno spettacolo e al tempo stesso di esservi coinvolti, di interpretarne il ruolo di attori e di spettatori insieme. Lo spettacolo di una vita, che si riverbera nelle vite di chi l’ha preceduta e di chi l’ha seguita, significativa e banale come tutte le vite che meritano un romanzo (e tutte le vite lo meritano, come prima di Gustave Flaubert e di Erving Polster affermavano già i romantici tedeschi), e per questo irresistibilmente coinvolgente. La vita di Maria (e di Margherita prima di lei), che passa il testimone a Giuliana, raccontandole di un’Italia arcaica, di un Piemonte contadino tra gli anni Cinquanta e Sessanta, appena sfiorato dalla storia, in cui il boom economico è un fantasma lontano e lei cresce come in un tempo non tempo, tra i molti fratelli, una madre incatenata ai suoi doveri di fattrice e custode di una morale ferrea, e un implacabile padre padrone che compra quasi per sbaglio “una 1100 così bella che ancora ti emozioni a parlarne”, ma che poi costringe la famiglia ad andare a messa a piedi anche quando piove.
Organizzato in capitoli brevi, organici eppure autonomi, il romanzo si dipana attraverso sequenze che potenzialmente potrebbero essere infinite, e ricostruisce una storia ai margini della quale la storia “vera” si intuisce appena: e così, il Sessantotto di Maria sembra svolgersi in un mondo parallelo, è segnato da un “trasloco, lento ed estenuante, da Casanova a La Loggia” e le giornate sono scandite dal “canto del cucu la mattina e la sera, in fondo ai campi”, mentre “non molto distante, a Torino, altri giovani si lasciavano crescere i capelli fino al sedere e occupavano le aule, le piazze, le strade. Ma queste cose le hai scoperte solo più tardi”.
Eppure a poco a poco la storia rientra nei binari a noi noti. È la nascita di un figlio (anzi, di una coppia di gemelli: Giuliana e Dario) a far maturare in Maria una consapevolezza diversa, a farla crescere e diventare padrona di sé e del suo mondo, per paradosso quando sembra essere oltre ogni maturazione possibile, in un processo che tuttavia Zeppegno rende sorprendentemente plausibile. E il prendere possesso della propria vita significa anche maturare una coscienza politica, come avviene nel capitolo 41, un breve ricordo, un efficace concentrato di realtà. Siamo nel 2001, alla vigilia dei fatti di Genova:
“Insistere con tua figlia perché non ci andasse, a quella manifestazione a Genova su cui aleggiava un indistinto timore, e vederle poi in tv, le scene degli elicotteri, della fuga verso la spiaggia, del bagno di sangue […]. Dovremmo lavorare meno e lavorare tutti, dicevi. Dovremmo smettere di comprare prodotti che vengono dall’altra parte del mondo e tornare a vivere come vivevamo noi, dei frutti della terra. Una persona, una macchina, ma siamo matti?, sbottavi. Le donne sono la metà dell’umanità. […] L’Italia non è mica “nostra”, è un caso se siamo nati qui e non altrove. Dovrebbero fare il cambio di campo, ogni tot anni, come nelle partite di calcio: mandare noi in posti poveri o devastati dalla guerra e far venire loro qui. Allora sì che capiremmo! Dicevi cose così, ricordi. Poi chiosavi: Che c’entra la politica? Non vedi che è solo buon senso? Umanità, soltanto. E mi guardavi sorridere.”
Il corto circuito con la realtà provoca anche uno scarto nell’andamento narrativo del romanzo. Si assiste a una progressiva contrazione del tempo, e dall’inizio lento, dilatato e fluviale si procede attraverso un’accelerazione che andando avanti si fa sempre più vertiginosa, e corrisponde alla vita, o almeno alla sua percezione in chi si fa carico di anni. Alla fine restano i tanti momenti, i tanti ricordi, e la voglia che si racconti ancora, che si definiscano altri particolari, si approfondiscano spunti appena accennati, che si venga a sapere che cosa ne è stato negli anni dell’orribile suocera Teresina, creatura di quasi fantastica natura spaventosa, di come sia morta, di che cosa sia accaduto a Pietro, il fratello prete di Maria che poi si spreta, agli altri fratelli e sorelle, a Dario il fratello di Giuliana. Restano tante curiosità, tanti punti interrogativi in cui sedimentano riflessioni ed emozioni, e ci si allontana con riluttanza dal mondo che La luce che pioveva ha evocato: prova che è un mondo vero, un romanzo riuscito.