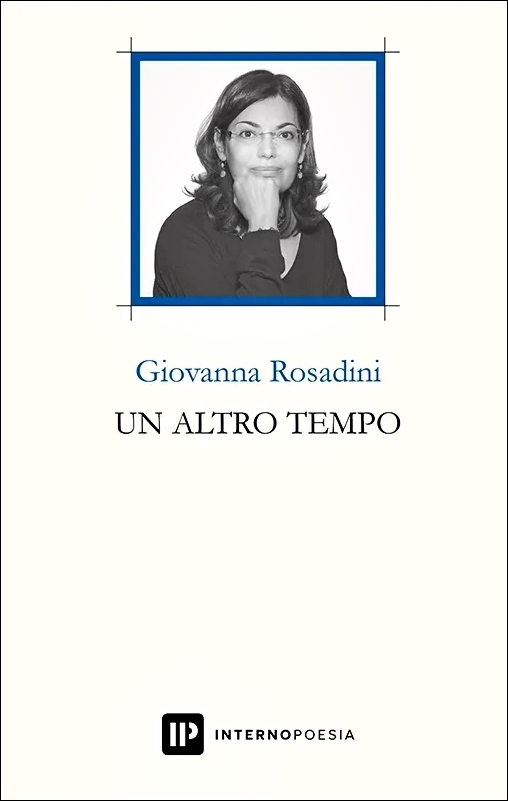“Spiegare con parole di questo mondo / che partì da me una nave portandomi” diceva Alejandra Pizarnick, nell’esprimere lo sforzo della parola, il tentativo votato, purissimo, di condividere il proprio essere altro, il proprio poetico e spirituale essere altrove. Si avverte una tensione simile tra le pagine di Un altro tempo, lavoro minuto e lucente, opera tersa, in cui l’autrice affronta la propria ostensione fisica e spirituale con la delicatezza e la dignità del fiore.
Giovanna Rosadini ha avuto una dolorosa esperienza ospedaliera alcuni anni fa, in seguito a un serio incidente che le provocò il coma, facendo di lei una paziente inerme; un corpo ostaggio dell’assenza e dell’accudimento forzato e assoluto. Al coma fece seguito un risveglio attonito, doloroso, inframmezzato da torpori trasognati e penosi, intrisi di lusinghe oniriche e di angosciosi richiami al presente. La sua condizione di parziale ritorno pareva volerla trattenere in un universo binario, fatto di incantesimi fluttuanti nelle fasi di mancata coscienza, e di spinosi assilli nella veglia. Un tempo pieno di miracolo e di azzardo, di letargo e di allarme, immerso nello scompiglio. In Un altro tempo l’autrice ripercorre questo itinerario, con il coraggio della fragilità svelata: dice sottovoce della propria inedita magrezza, che sporgeva nei grandi occhi smarriti, nelle ginocchia ossute; dell’intero corpo che era come una foglia riarsa, gracile da crepitare nel pugno. Lontano, forse perduto, il vigore atletico, la funzione ottimale, la programmazione perfetta dell’esistere; il controllo della propria fisicità e bellezza, la spocchia dell’autosufficienza, dell’autodeterminazione.
La poetessa si mostra con innocenza limpida, e non è nuova a questo: chi frequenta le sue vie e le sue parole lo sa. Ma qui ancora di più, perché la purezza disarmata della sua prosa va da subito a cercare il battito di chi legge e, in un patto di reciproca lealtà, offre il suo, nel tentativo di raccontare, qui sì, in essenza, nella chiarezza del particolare, il percorso di restituzione alla coscienza e alla vita. Rosadini, intera, si esplicita, si espone allo sguardo e, con candore, spiega ciò che la sua poesia altrove (in Fioriture capovolte, Einaudi 2018) aveva pennellato con contorni più sfumati, come in un morbido acquerello.
Ma ora, in questa nitida prosa, si affronta la parola precisa, il ricordo esatto, la mappa dello smarrimento e del rientro; ed è la topografia variegata di impotenze funzionali, mestizie fisiologiche, umilianti accudimenti, teneri conforti, vicinanze, rivelati tramonti; il viaggio del suo ritornare al più intimo e intenso amore per la vita: “Esserci, ancora. In una prossimità ritrovata col cielo, con l’aria che preme addosso leggera, una carezza quasi immateriale, con le onde che avanzano e si ritraggono di questo mare in cui mi immergerò, in un bagno rituale che, dopo l’esposizione alla perdita di me stessa, congederà i fantasmi e mi restituirà alla vita”.
Non vi è nulla di eroico né di retorico in queste pagine esili, accuratissime, in cui Rosadini si confida porgendo il suo cuore, diafano come un cristallo, forte dell’esperienza del corpo esposto, della remissione di sé nelle mani dell’altro, della consapevolezza profonda della costitutiva fragilità che tutti ci riguarda: “Questo è il tempo della precarietà e dell’impotenza, dell’impossibilità di controllo e di governo delle proprie azioni e funzioni, dell’intenzione che si perde il gesto, del movimento storto ed imperfetto, della volontà che non riesce ad incarnarsi”.
E, se Antonella Anedda ci richiama alla transitorietà dell’esistenza biologica e cellulare, smantellando provocatoriamente il concetto di identità fisica (“Eppure non ha senso / rimpiangere il passato, / provare nostalgia per quello che / crediamo di esser stati. / Ogni sette anni si rinnovano le cellule: / adesso siamo chi non eravamo. / Anche vivendo – lo dimentichiamo – restiamo in carica per poco”), è pur vero che ognuno esiste nella sua unicità, delimitata, configurata, identificata, quantomeno nel ricordo e nella percezione delle persone care. Ma questa nostra identità, custodita da chi ci ama – si interroga Rosadini – in che misura risiede nell’insieme “del patrimonio fisico/biologico/genetico racchiuso nel proprio corpo alla nascita” o piuttosto nella “somma delle esperienze fatte interagendo con l’ambiente…”? Entrambe queste dimensioni, violate dal male, sono ora disgregate e disperse. Il cammino è lunghissimo.
Nelle sue giornate di ritorno alla coscienza, la poetessa si cerca nelle reminiscenze, nelle abilità, nella proprietà di linguaggio, in tutto ciò che la differenzia dall’altro essere umano sofferente; la necessità è quella di ribadire a sé stessa la transitorietà della sua condizione, la sua aristocratica irripetibilità di persona colta, distinta, di rinfrancarsi sottraendosi al giogo di una vera comunione in anima e in sorte con le “esistenze residuali”, con i “diminuiti e i depotenziati”; con i “diseredati dalla pienezza e integrità del proprio corpo e delle proprie facoltà” che sono ospiti nelle camere di degenza altrimenti numerate. Salvo poi ritrovarsi intera, compiutamente umana, in ciò che più spaventa e agli altri unisce: l’accettazione dell’insufficienza, del bisogno, la tenerezza della vicinanza.
Un altro tempo approda via via a una narrazione commossa, pervasa di gratitudine, nel ricordare le mani di medici, infermieri, rieducatori del movimento e della parola, che le hanno somministrato, più di qualsiasi farmaco, la custodia e la cura. Lo sa, chi voglia dirsi medico, ma anche chi voglia dirsi genitore, o persona cara, o tenero e sincero amante, che la tutela del corpo inerme è cosa sacra. Quell’accudimento radicale, in cui non c’è vergogna, ma soltanto radioso amore, da cui non si torna se non rinnovati, nudi, indifesi e lucenti, nella propria fragile e potentissima umanità. Dalle prime trincee in cui la poetessa d’istinto si rannicchiava di fronte alla prova – io e voi – c’è il nascere di un noi, in cui il difetto, l’imperfezione, la disabilità sono perno di vicinanza con gli altri: il male attraversa con violenza, lascia riarsi e spenti, ma il dolore è come pioggia, e il cuore è terra in attesa.
È bene di quest’opera assaporare il nitore, la coraggiosa chiarezza, senza chiedersi se si tratti di poesia o autobiografia, o di un testo narrativo. Riceviamo in queste pagine un gesto dedicato, un’offerta in concave mani, una candida gemma. L’arcobaleno di moti del cuore dell’autrice, così raccontato, diviene percorso e via: dall’incredulità allo sgomento, dall’estraneità alla rassegnazione, fino all’abbandono e alla fiducia purissima, questa narrazione fa tremare di consolazione, di sollievo, di promessa, ed è un seme che deposita il proprio bene, stimolando una riflessione sul senso della vita.
 Un libro intriso di ombra e di grazia, direbbe Simone Weil, dove la pesanteur degli accadimenti fisici è mitigata da consapevolezze rivelate, celesti, con l’armonia dell’ossimoro: serenità nella tenacia dell’impegno, rassegnazione nella diligenza del compito. E accettare il contrasto è forse la chiave di tutto. Così Weil: “Solo la grazia può dare il coraggio lasciando intatta la tenerezza o dare la tenerezza lasciando intatto il coraggio”; e ancora: “La vulnerabilità nelle cose preziose è bella perché la vulnerabilità è un segno di esistenza”.
Un libro intriso di ombra e di grazia, direbbe Simone Weil, dove la pesanteur degli accadimenti fisici è mitigata da consapevolezze rivelate, celesti, con l’armonia dell’ossimoro: serenità nella tenacia dell’impegno, rassegnazione nella diligenza del compito. E accettare il contrasto è forse la chiave di tutto. Così Weil: “Solo la grazia può dare il coraggio lasciando intatta la tenerezza o dare la tenerezza lasciando intatto il coraggio”; e ancora: “La vulnerabilità nelle cose preziose è bella perché la vulnerabilità è un segno di esistenza”.
Ed è di nuovo quella grande lezione, che a ogni aurora dobbiamo reimparare, del non opporre resistenza. Rimanere morbidi e aperti di fronte al dolore spalanca il mistero: che quando si è tutto perduto, tutto ritorna, più potente, più vero, più vicino al centro; che dall’integrità incrinata ed erosa, dalla sofferenza che accetta e nulla chiede, nasce il miracolo dello sguardo, che volge all’altrui vulnerabilità la luce perfetta della compassione.