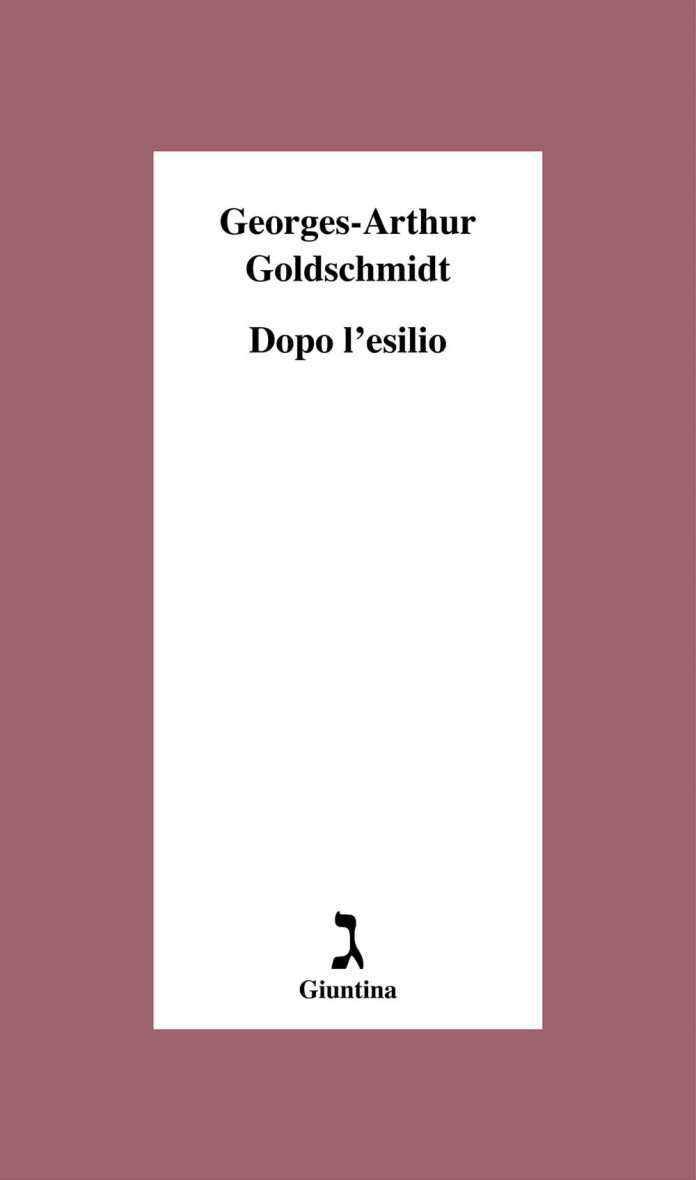Vom Nachexil è titolo originale di questo smilzo, ma intenso volumetto per il quale l’autore, tedesco di nascita ma naturalizzato francese, si avvale della possibilità, pressoché inesauribile per la lingua tedesca, di formare parole composte, coniando un pregnante neologismo, “Nachexil” (il “dopoesilio”), appunto. Se gli sconvolgimenti politici degli ultimi cent’anni hanno reso l’“esilio” una categoria biografica e psicologica familiare, più sottile e innovativa appare la categoria formulata da Goldschmidt del “Nachexil”, con cui egli indica, con la nettezza della singola parola, il blocco compatto rappresentato dalla seconda parte della vita dell’esule, radicalmente nuova ed eppure tragicamente avviluppata alla precedente. “L’esilio divide la vita in due metà d’ora in avanti incompatibili: il prima e il dopo; una constatazione molto banale, si può replicare, che tuttavia, come un doppiofondo, sostiene, mina e al tempo stesso divide la natura dell’esiliato” asserisce, infatti, Goldschmidt in apertura di questo testo, in cui egli, in età ormai assai avanzata, riflette sulla propria esperienza di esule.
Nato nel 1928 con il nome di Jürgen-Arthur Goldschmidt e discendente di una delle più antiche famiglie ebraiche di Amburgo convertitesi al protestantesimo, l’autore deve confrontarsi sin dalla prima infanzia con la contraddizione sussistente tra la dichiarata e orgogliosa appartenenza della propria famiglia alla cultura tedesca e lo stigma razziale impostogli dal Nazionalsocialismo che già nel 1933 destituisce il padre, sostenitore del Partito Popolare Nazionale Tedesco, dal suo ruolo di alto magistrato, in quanto “non ariano”. La persecuzione razziale si acuisce e l’autore annota come nel 1937 egli fosse stato escluso dalle celebrazioni delle messe per bambini della Chiesa evangelica locale. Ne nasce un senso di colpa, irrazionale e irredimibile: “Lo stupore fu enorme, eppure egli capì molto bene e all’improvviso sentì come, attraverso questa esclusione, la sua esistenza, per così dire, si definisse, racchiudendolo in una capsula che lo isolava dal mondo circostante; era colpevole di esistere, niente di più, era molto semplice”. Come si evince dal passo citato, l’autore narra la propria esperienza autobiografica utilizzando la terza persona, vuoi per raggiungere un certo distacco, vuoi per conferire all’esperienza individuale una patina di esemplarità; la scelta è del tutto conforme, del resto, allo stile sobrio, intessuto di scarne annotazioni cronachistiche, impressioni paesaggistiche, precise osservazioni linguistiche e perspicaci affondi psicologici, reso assai bene in italiano dalle due traduttrici in una lingua tesa e sorvegliata.
La vita nella grande villa a Reinbek, presso Amburgo, il mutare dell’ambiente e delle condizioni scolastiche all’avvento del nazismo, le disposizioni antiebraiche sempre più opprimenti vengono ripercorse da Goldschmidt nelle prime pagine del libro e sfociano nella decisione, maturata dai genitori in oscure confabulazioni, di inviare i due figli all’estero, e, precisamente, a Firenze: “I genitori l’avevano tradito, venduto (…). All’improvviso capì che da quel momento sarebbe dipeso solo da se stesso”. Lenta e inesorabile è la descrizione del giorno della partenza dalla stazione di Reinbek (18 maggio 1938), intessuta di impressioni indelebili: “Il giorno dell’addio rimane attaccato addosso fino all’ultimo giorno, monta dentro all’improvviso e inaspettato. Ogni esiliato, ogni emigrato porta dentro di sé questo giorno”. Il soggiorno a Firenze, presso la famiglia Binswanger, si rivela però di breve durata, poiché già nel novembre successivo il Governo fascista emana le leggi razziali, in base alle quali “gli esiliati dovevano sparire entro l’aprile del 1939”. I due bambini riescono a ottenere un visto per la Francia e trovano rifugio in Savoia, dove pure il bambino deve affrontare un ambiente scolastico rigido e punitivo. I traumi e le violenze subiti nel collegio ad Annecy sono qui accennati, ma sono stati oggetto da parte di Goldschmidt di più dettagliati racconti nel libro La linea di fuga (Donzelli 2010). Dopo l’occupazione tedesca della Francia, la situazione per il giovane ebreo si fa sempre più pericolosa e Arthur riconosce nel libro il proprio debito di gratitudine al gendarme che avvisò il collegio dell’imminente arrivo di un carro di ricognizione tedesco alla ricerca del giovane ebreo, alla direttrice del collegio che ne consentì la fuga e alla famiglia di contadini che ospitò il ragazzo in incognito tra il 1943 e il 1944. Dopo la fine della guerra, il giovane consegue il baccalauréat, studia germanistica e filosofia alla Sorbona e si integra pienamente nella società francese, dedicando la sua lunga vita alla traduzione dal tedesco al francese e dunque alla mediazione culturale (tra gli autori tradotti: Goethe, Nietzsche, Kafka, Walter Benjamin, Peter Handke).
Il libro di Goldschmidt non è infatti solo il resoconto, sobrio e al contempo appassionato, di un’infanzia in fuga, marchiata da un sentimento angoscioso di spaesamento, paura, esclusione e ribellione; è anche la storia di una maturazione psicologica e di un riscatto, avvenuti tramite la scoperta di una lingua e di una cultura nuova (quella francese) e la riscoperta, tardiva e dolorosa, della propria lingua madre, contaminata dalle scorie del nazismo: “sulla lingua madre, un tempo così amata, gravava un’ombra scura, come uno sfondo inquietante che teneva prigioniero colui che scriveva in esilio”.
Non mancano, in questa rievocazione di un passato ormai lontano, riferimenti all’attualità: chiude, infatti, il volume (già consegnato all’editore nell’aprile 2019) un accorato poscritto in cui l’autore ricorda il recente incendio della cattedrale di Notre-Dame (16 aprile), bastione di civiltà e simbolo della storia francese e anche europea: “Tutti noi, costretti a subire l’occupazione a volte in condizioni di grave pericolo, non abbiamo mai perso di vista Notre-Dame, bastava un solo sguardo alle due splendide torri per trarre nuovo coraggio e sapere che non tutto era perduto, che il simbolo della civiltà, il nostro faro, era ancora lì a guidarci nel futuro”.