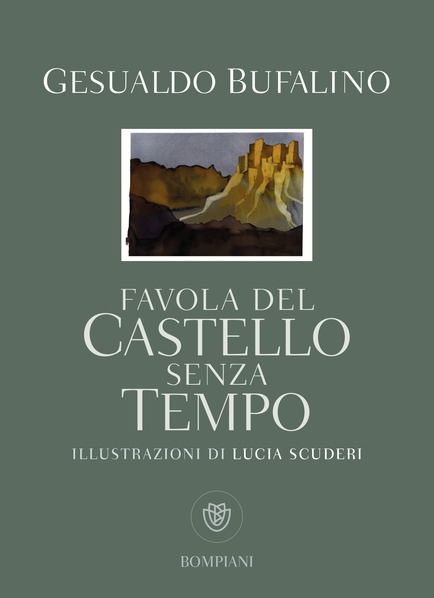Dino (cioè Gesualdino, per lo più Dino) insegue una farfalla che sul corpo ha il disegno di un teschio. Corre lei, e lo porta nel bosco, come si conviene a ogni avventura iniziatica.
“Atropo è il mio nome. Il mio reame sono le contrade della Notte”. Dino la cattura, ma la libera subito dopo, educato da savie letture a ”tutte le delizie della pietà”.
E qui inizia il patto, tra il bambino e la farfalla.
Favola del castello senza tempo è un libro di fattura preziosa, una favola illustrata in modo fatato dalla siciliana Lucia Scuderi, che ha grande esperienza di mondi sognanti, qui alle prese con i campi simbolici e la magia della lingua di Gesualdo Bufalino, ben illuminati nella prefazione di Nadia Terranova, scrittrice siciliana anche lei.
Nella favola c’è un castello dove il tempo si è fermato e le persone non possono morire. Sono paralizzate nella vita. “Sappi che noi da sempre soffriamo questa nostra esangue immutabile beatitudine. Fame e sete ci sono negate, non conosciamo riso né lacrime, il nostro stato è di pigro appagamento, di monotona inappetenza… Ora tu dimmi: può bastarci, questo? Può dirsi, questo, felicità?”.
Il tempo, la memoria, la morte: dice lo scrittore, quali altri temi dovrebbero esistere?
Ingannare la morte è il gioco delle perle di vetro, l’unica vera sfida per nobilitare la vita.
Ma qui il tema della morte è rovesciato: essere condannati all’eternità è una morte assai crudele. Atropo è imprigionato dentro una farfalla. Con leggerezza porta Dino di fronte a un viaggio di liberazione.
Entrerà Dino nel castello?
Domandiamo invece noi: da quale mondo viene Gesualdo Bufalino?
Dello scrittore poi si può solo dire: leggerlo, e leggerlo ad alta voce. Con lentezza.
Quello di Bufalino è teatro lirico. Versi camuffati in prosa, un’orchestrazione mahleriana dentro una struttura bachiana, travestita in lettere. La sua lingua può arrivare a sconcertare chimicamente, proprio come fa una grandissima musica. Bufalino considera infatti la scrittura ”come una medicina, come luogo di confessione, come possibilità di dialogo con me stesso, di approfondimento con me stesso. Ho sempre ricorso all’esempio di Sheherazade che racconta per esorcizzare la morte, per rinviare l’esecuzione”.
Anche in Favola, il lessico di Bufalino mira apparentemente all’eccesso. Quanto è barocca la sua scrittura? La risposta, spiazzante, arriva dallo scrittore mediata dai più opportuni contrappassi: “il barocco – dice – è un componente dello spirito siciliano. Così come il gusto per l’iperbole, il gusto dei gesti, le parole eccessive, il volersi moltiplicare ed esprimersi sopra il rigo, per usare una terminologia musicale. È anche vero che nella psicologia siciliana, questo fa il paio con un tipo di comportamenti esattamente contrari. Con l’avarizia della comunicazione, con l’affidarsi al segno o al messaggio cifrato, all’allusione… Questi due comportamenti contraddittori, dell’eccesso dell’oralità – la sovrabbondanza del gesto e dell’avarizia – sono presente entrambi in me, perché io nonostante opti per la soluzione barocca, per la torrenzialità dell’espressione, in fondo cerco di ricorrere o ricorro quasi inconsapevolmente ad una estrema rarefazione dell’espressione, attraverso un gioco di metafore allusive, lasciando dei vuoti che deve essere il lettore a colmare”.
Attraverso le interviste che si trovano in rete, sentiamo dalla sua voce quali sono stati i miti della sua vita, la vocazione poetica che l’ha portato a vivere sempre nella sua piccola Comiso, involucro protettivo della sua sterminata biblioteca. Su insistenza ostinata di Sciascia e Sellerio che gli chiedono di leggere il libro nascosto nel cassetto, Bufalino si decide a pubblicare – a sessant’anni – Diceria dell’Untore, con cui vince il Campiello. Seguono altri libri e premi, uno Strega, e traduzioni in tutto il mondo. E se i due siciliani non si fossero incaponiti? Dove finiscono i libri nel cassetto come questo, luminosi come comete, quando un forcone non li tira fuori?