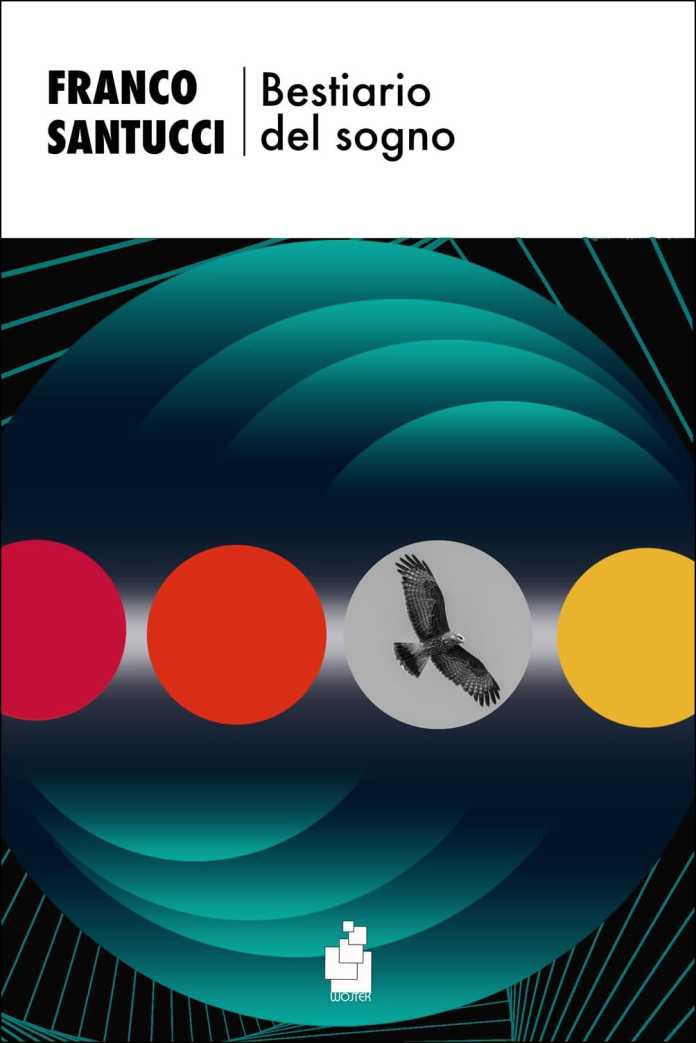Anche se vi è un doppio richiamo nel titolo, il Bestiario del sogno – esordio in volume di Franco Santucci, per la sempre attenta e ricettiva casa editrice Wojtek – non è soltanto un bestiario, né è soltanto onirico. Ridurre la raccolta dei racconti a questi due elementi, infatti, significherebbe sminuire la complessità di immaginario e di stile dell’autore, già firma per alcune delle migliori riviste online degli ultimi anni, spingendola inoltre verso quegli orizzonti già codificati che la sua scrittura continuamente rifugge.
Correndo il rischio, a partire dall’accettazione di questa sfida radicale, di una certa disomogeneità di fondo, i sedici racconti brevi che compongono il volume non risultano facilmente incasellabili in alcun genere – nemmeno nel bestiario, dunque, né in tematiche o dinamiche narrative ben definite – come quelle che ormai fanno riferimento, per diritto o per consuetudine, alla dimensione dell’onirico. In ottemperanza con un certo gusto new weird, a dominare è invece una permeabilità dei tempi, degli spazi e dei corpi, alla base, innanzitutto, di una osmosi tra animali umani e non–umani che rende discutibile, appunto, la distinzione appena usata – politicamente corretta, forse, e comunque ancora basata su un’implicita differenziazione e gerarchizzazione.
In questo senso, il vero abbrivio della raccolta non coincide con il primo racconto, Dreamaker, suggeritore di una cornice onirica che, a lettura ultimata, non riesce a reggere per tutti i racconti inclusi; sembra, invece, il successivo Io e l’avvoltoio a poter dare il “la” al valzer di fusioni e contaminazioni – non di rado perturbanti, oltre ogni possibile accezione irenica del cosiddetto “post-umano” – che segna tutto il libro. Questo succede anche attraverso un incipit che si rivelerà poi inverosimile secondo le più convenzionali coordinate spazio-temporali (“Quando racconto questa storia”, esordisce il narratore, ma nelle ultime righe del racconto lo si vedrà avviato senza scampo alla morte) e alcune altre spie linguistiche rivelatrici, contenute sempre nelle prime righe del testo: “Altri – analisti naturalmente, junghiani soprattutto – pensano che l’avvoltoio sia un interlocutore immaginario, un guru interiore, una sorta di spirito guida con cui imbastivo un discorso fittizio alla ricerca della totalità del vivere. No: l’avvoltoio era un avvoltoio (per correttezza, un grifone)” (corsivo aggiunto).
 Di conseguenza, il racconto sarà da affrontare senza attingere necessariamente a saperi già codificati, come ad esempio quello psicanalitico, e conferendo invece un giusto, per quanto enigmatico, rilievo alle incursioni sapienziali o gnomiche che costellano questo come anche altri racconti inclusi nel volume. Croce e delizia, la ricerca della gnome, di una scrittura che non vuole né può restare impigliata nella propria fluvialità immaginifica – già costretta, peraltro, negli spazi piuttosto angusti del racconto breve o brevissimo, e spesso adattata a una generale asciuttezza narrativa di fondo – e che lotta continuamente, talora vincendo talora perdendo, con quelle caratteristiche dell’ispirazione letteraria che si possono leggere alla fine di Matricola BC01: “Avrei detto, infine, che l’ispirazione può avvenire solo in un regno similare, per vezzo, per riempire un vuoto non necessario, per il solo piacere di un’altra frase senza significato, parole umane a cui mi piaceva affidarmi”.
Di conseguenza, il racconto sarà da affrontare senza attingere necessariamente a saperi già codificati, come ad esempio quello psicanalitico, e conferendo invece un giusto, per quanto enigmatico, rilievo alle incursioni sapienziali o gnomiche che costellano questo come anche altri racconti inclusi nel volume. Croce e delizia, la ricerca della gnome, di una scrittura che non vuole né può restare impigliata nella propria fluvialità immaginifica – già costretta, peraltro, negli spazi piuttosto angusti del racconto breve o brevissimo, e spesso adattata a una generale asciuttezza narrativa di fondo – e che lotta continuamente, talora vincendo talora perdendo, con quelle caratteristiche dell’ispirazione letteraria che si possono leggere alla fine di Matricola BC01: “Avrei detto, infine, che l’ispirazione può avvenire solo in un regno similare, per vezzo, per riempire un vuoto non necessario, per il solo piacere di un’altra frase senza significato, parole umane a cui mi piaceva affidarmi”.
La fonte di queste narrazioni è ancora diversa da questa sorta di ecolalia compiaciuta che è da sempre, in realtà, identificata con l’ispirazione letteraria, facendosi prisma del mondo che vi sta dietro, come si legge nel racconto Lo zoo: “Quando si è troppo immersi in un contesto, non si riesce ad accorgersi nemmeno dei suoi confini, che comunque potrebbero rivelarsi transitori; da un finale si può uscire e rientrare, ma nel mondo che vi sta dietro, che lo presuppone, si continua a vagare per sempre”.
Santucci, in altre parole, ricorre a forme aggiornate di straniamento – nei temi, nelle figurazioni, nelle dinamiche architettoniche dell’opera, più che nello stile, che resta sempre piuttosto levigato, talora marmoreo – per togliere i lettori dal loro contesto più confortevole, anche in senso letterario, e portarli a vagare nel “mondo che sta dietro”: paesaggio metafisico, non nell’accezione filosofica, ma à la De Chirico, nel quale vagare vuol dire passare di corpo in corpo, e quindi di storia in storia.