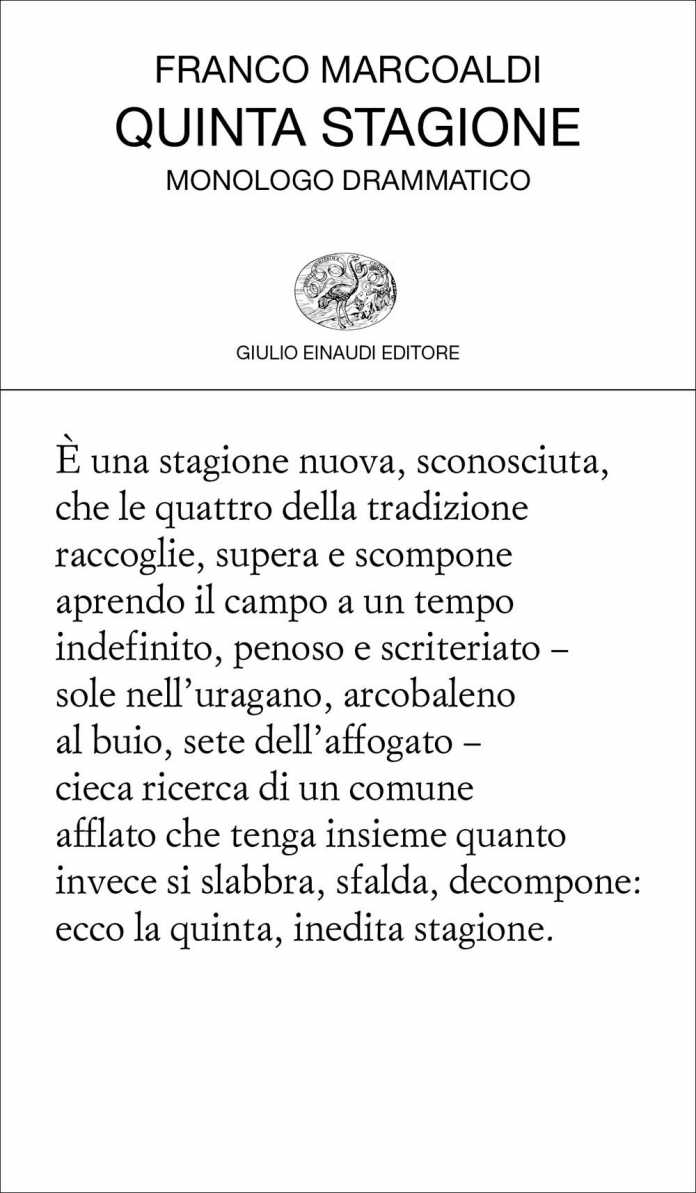La stagione inedita del nostro scontento è qui, non sappiamo quali conoscenze porterà oltre agli incagli che osserviamo da sottotetti e terrazze e da schermi LCD mentre poco ci s’intende su presente e passato. Una stagione in cui le storie sono smontate e i linguaggi appiattiti come forse mai negli ultimi tre secoli, e i mostri non sono più nelle trasparenze dei sogni ma nelle gerarchie della rete. In uno scambio inedito fra amici e nemici, e traiettorie sbilenche, Franco Marcoaldi lancia questo Monologo come un dardo sottile e affabile che senza alzare la voce si prende il posto istruttivo del racconto, del documentario.
Marcoaldi snoda la sua personale poetica divagando e discorrendo: questo l’attuale vantaggio, in risposta all’ormai consueta fragilità della poesia corrente. Alla fragilità che vive il mondo intero. Inteso come umanità, pigra e inutilmente saputella di fronte ai massi giganteschi che le stanno arrivando addosso. I dodici atti vedono il protagonista di fronte al gorgoglio delle acque, alla schiuma riversata da un acquedotto in rovina – ma non per questo egli intende abdicare alla fedeltà che lo ha condotto lì. Dalla nuvola degli anni passati trae il tempo che ancora ha un valore, indicando il trauma delle perdite, dello spreco. Non è più stagione di sane tramontane, ma di eccitazioni simil-mondane sugli schermi. Nemmeno l’invasione terrestre (attenzione, non aliena) da parte dei virus annulla il tacere del dolore che riscattava. Nemmeno autori (da Samuel Beckett a Pier Paolo Pasolini, da Paul Celan a Primo Levi e Zerocalcare) abitanti un tempo devastato. Già Marina Cvetaeva, in una dedica a Boris Pasternak, reclamava la permanenza di una quinta stagione, da un po’ giunta a pilotare gli animi: lo scrive affabilmente l’autore impegnato a orientarsi nella comprensione dei passaggi stagionali fin qui vissuti.
Come riuscire a godere di luci passate, ancora distese nelle profondità dell’animo, dopo che certe vicende hanno stroncato mondi? In questo libro il movimento è grande, per mare e nei cieli tutto si muove ed è come se vedessimo il protagonista viaggiare da un lato all’altro del palcoscenico. E il palcoscenico è spazio gentile, spazzato dalla polvere. La cosa nuova che accade alla nascita di una poesia (diceva T.S. Eliot), qui è presente nella sua piena disposizione, né appelli né facili condanne ma orizzonte di pensiero sull’attualità e specchio di quanto potrà ancora accadere. L’ombra dei Cantos non è minacciosa, Marcoaldi rasenta integrità e falle di un aspetto finalmente molto umano, anche troppo, ma che mai, negli anni di Ezra Pound, avrebbe contrastato e sbarrata l’inestinguibile volontà di poesia. Infine potrebbe essere l’oceano, talmente eterno da non avere più memoria, a tenere vive le condizioni del cuore e gli ultimi barlumi di verità e storia.
Impigliati ancora, legati a irredimibili incidenti, potremmo scomparire e dunque cosa ne sarebbe della realtà? Questioni in mano ai fisici, molto più interessanti di coloro (troppi) che oggi non sanno edificare una poesia assolutamente nuova. Nella costellazione di questa impresa teatrale però il poeta immagina il manifestarsi di maschi e femmine nel corpo di un uomo-donna in grado di “ruggire dolcezza” contro la frana in atto. I templi possono essere pericolosi, ma le preghiere no, sebbene mancando queste sia difficile aspettarsi nuove estati. All’epilogo il distico “Cenere di rapina, / che deprime e che reprime” cade sulle nostre teste come uno schianto, relazione utile nel viaggio terrestre intrapreso da Marcoaldi su quel palcoscenico che potrebbe essere l’ultima visione del mondo. Ma poco prima, l’invito a misurarsi con la tempesta e ai profughi di guardare a questa terra “sempre, e ancora, pronta a farsi fecondare”.