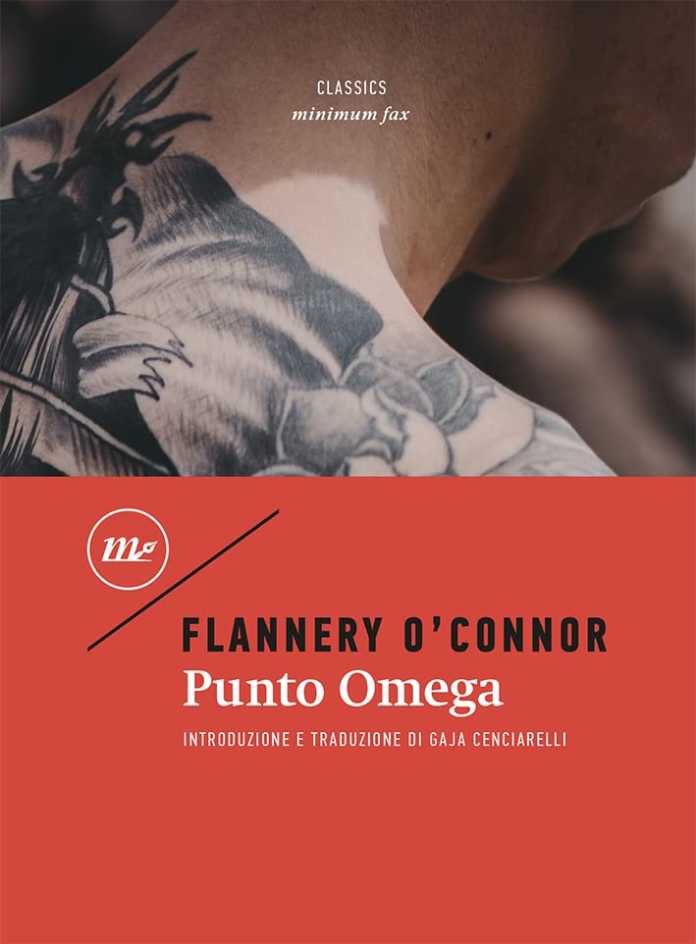Everything That Rises Must Converge è la raccolta di nove racconti di Flannery O’Connor pubblicata postuma, nel 1965, con un’introduzione di Robert Fitzgerald. Il titolo – “tutto ciò che sale deve convergere” – è tratto da un’opera di Pierre Teilhard de Chardin (il “gesuita moderno” montaliano), che descrive il cosiddetto Punto Omega, evoluzione massima di complessità della coscienza, verso cui tutto tenderebbe. Con la nuova traduzione del collected della scrittrice di Savannah, Gaja Cenciarelli sceglie di far riferimento direttamente al Punto Omega forse per valorizzare ciò che, in termini narratologici e spirituali, è sempre presente negli arcigni bozzetti di O’Connor: la Spannung, il punctum saliens (condiviso con Čechov), il momento cioè di trazione apicale e di completo cambiamento nella vita dei personaggi. Un incidente di percorso, un’azione fatale, un trito fatto che assume dimensioni macroscopiche e raggiunge, per di più, uno stato di sofferta irreversibilità: questa è la scomoda (e inquietante, ma anche sardonica) parola del Southern Gothic con cui l’autrice della Georgia intende salutare il suo Vangelo della spada (“non sono venuto a metter pace, ma spada. Perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera”, Mt 10,34-35). Non una visione conciliante – non poteva essere altrimenti con la sventurata malattia che le gravava addosso –, ma una ferita aperta, un «segno di contraddizione», attraversato dalla sproporzione interiore ed esteriore che porta con sé questo stile in tutta evidenza grottesco, compiaciuto dello stridore provocato.
 La title-track è un pugno nello stomaco contro i pregiudizi razziali. Uno scrittore in erba, tal Julian, costretto ogni mercoledì sera ad accompagnare in autobus sua madre “a un corso per dimagrire”, si deve sorbire le idee vetuste e misere sull’integrazione della platea di bianchi. Deciso a dare una lezione ai falsi benpensanti, si siede accanto a un uomo di colore. Ma la scarsa empatia della madre non coglie la portata metaforica del gesto né, più empiricamente, gli umori della signora afroamericana salita con il figlioletto Carver. È proprio la non visione dell’altro a causare un finale davvero catastrofico e viscoso.
La title-track è un pugno nello stomaco contro i pregiudizi razziali. Uno scrittore in erba, tal Julian, costretto ogni mercoledì sera ad accompagnare in autobus sua madre “a un corso per dimagrire”, si deve sorbire le idee vetuste e misere sull’integrazione della platea di bianchi. Deciso a dare una lezione ai falsi benpensanti, si siede accanto a un uomo di colore. Ma la scarsa empatia della madre non coglie la portata metaforica del gesto né, più empiricamente, gli umori della signora afroamericana salita con il figlioletto Carver. È proprio la non visione dell’altro a causare un finale davvero catastrofico e viscoso.
Sono indimenticabili, poi, le pagine centrali di La schiena di Parker: il protagonista, Obadiah Elihue, in uno slancio di rivolgimento dinamico, si fa incidere sul dorso il Cristo Pantocratore: “Voltava le pagine sicuro, pensando che quando fosse arrivato all’immagine predestinata avrebbe ricevuto un segnale. […] Su una pagina, un paio di occhi gli scoccarono un rapido sguardo. Parker proseguì in fretta, poi si fermò. Anche il suo cuore sembrò andare in corto circuito; il silenzio era assoluto. E diceva chiaro e tondo, come se il silenzio stesso fosse stato un linguaggio: ‘Torna indietro!’ Parker tornò al disegno – la testa austera e piatta, circondata dall’aureola, di un Cristo Bizantino dagli occhi divoranti. Restò seduto lì, scosso dai tremiti; il cuore riprese lentamente a battere, come se fosse stato riportato in vita da una forza profonda e misteriosa”. Anche qui la scelta umana approda a un contrasto insanabile: Sarah Ruth, la moglie credente, per la quale Obadiah aveva fatto il tatuaggio come sintomo di conversione, lo reputa un’idolatra e in un finale altamente simbolico ritroviamo Parker bastonato e appoggiato a un albero di “noce americano”, che piange “come un bambino” (l’albero è una rappresentazione della croce e Obadiah diviene così figura del Christus patiens). O’Connor non conosce minimalismo, anzi precede il massimalismo pynchoniano con la gravidezza del segno. Non sono da meno Malattia mortale, Gli storpi entreranno per primi e Il giorno del giudizio: storie a prima vista brutali, disperate, ma dove in realtà ad agire, in modo imperscrutabile, è sempre la grazia che risospinge incessantemente l’uomo neghittoso, dalla “marea di oscurità” del “mondo della colpa e del dolore”, alla luce.