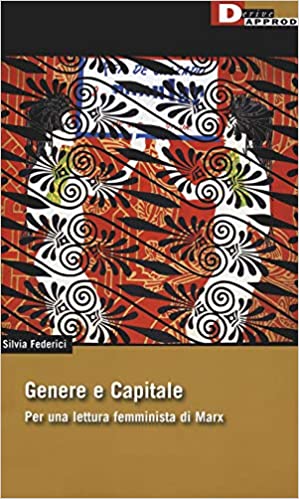Nel VI volume dedicato alla ricostruzione della storia dell’Autonomia operaia italiana (Derive Approdi, 2020) Piero Despali uno dei protagonisti dei Collettivi politici per il potere operaio di Padova scrive: “è indubbio che ci risultava difficile considerare la casa il luogo esclusivo della lotta e la donna in quanto donna la figura centrale della sovversione sociale”. Despali sta ricostruendo le lotte delle operaie a domicilio di una fabbrica di bambole e il riferimento è evidentemente al “Movimento per il Salario al lavoro domestico” nato a Padova proprio in quegli anni Settanta e del quale faceva parte anche Silvia Federici, autrice di questo saggio.
Eppure la galassia dell’Autonomia Operaia era la più attrezzata per comprendere la critica femminista al concetto di lavoro e di composizione di classe che arrovellava entrambi i movimenti. Un rapporto mancato, quindi, nonostante anche i Collettivi politici mettessero negli stessi anni in questione la figura dell’operaio salariato di fabbrica e si rivolgessero e organizzassero piuttosto quella figura composita che verrà poi chiamata “operaio sociale”, riconoscendo che la produzione della ricchezza sociale era uscita dai cancelli della fabbrica e stava “sfondando” la giornata lavorativa.
Ciò che probabilmente era inaccettabile anche per i movimenti e le organizzazioni più avanzate presenti allora in Italia non era l’enfasi che il Movimento per il salario al lavoro domestico metteva sull’importanza centrale del lavoro di riproduzione (allevamento, cura della casa e dei familiari, lavoro sessuale nelle camere da letto, disciplinamento della forza lavoro) e sulla mistificazione della sua gratuità che permetteva al capitale di nascondere la reale estensione della giornata lavorativa. Andava bene anche il fatto che il terreno del salario non fosse una rivendicazione puramente sindacale ma direttamente politica, includendo nella richiesta di reddito sganciata dal tempo di lavoro (attraverso le autoriduzioni, le lotte per i trasporti gratuiti e gli affitti equi, etc.) i costi della riproduzione.
Credo che la divaricazione si ponesse invece sulla soggettività e sulla cosiddetta composizione politica di classe, sempre cercata nella pratica delle lotte dei movimenti autonomi alla luce della lezione impartita da Marx nel celebre Frammento sulle macchine secondo cui la cosiddetta sottomissione reale del lavoro al capitale – già allora data per acquisita – riconduce tutte le forme di lavoro a unità. Cos’altro dicevano le ronde degli autonomi che spazzolavano le piccole fabbriche del padovano e del vicentino se non, per l’appunto, che quel lavoro nero, all’apparenza coatto e schiavistico, non era una forma residuale e arcaico di sfruttamento e perciò incapace di lotte efficaci?
Un pregiudizio che il Movimento per il salario al lavoro domestico contestava, rifiutando l’idea che la mancanza di salario e un basso sviluppo tecnologico significassero residualità e arretratezza politica, sostenendo “che non solo la coesistenza ma la necessaria compenetrazione di diversi regimi lavorativi è una caratteristica strutturale del sistema capitalistico” dove “la maggior parte del lavoro che si compie anche nei paesi più tecnologicamente avanzati è irriducibile alla meccanizzazione” e sempre lo sarà.
Un’intuizione teorico-politica preziosissima che come una freccia arriva al cuore dei giorni nostri in cui è sotto gli occhi di tutti l’intreccio strutturale di più livelli di sfruttamento: quello fondato sull’estrazione e la privatizzazione della ricchezza prodotta dal lavoro altamente qualificato, quello coatto e razzializzato del lavoratore migrante, quello di cura delegato a badanti e domestiche, finanche quello che fa perno sul lavoro gratuito. Logiche diverse di sfruttamento come il caleidoscopio di status e diritti sta lì a indicare. Siamo ormai ben oltre il classico rapporto salariato.
Altrettanto densa di indicazioni è l’idea che la “concentrazione di mezzi di produzione” e la cooperazione lavorativa prodotta dal capitale non siano semplicemente rovesciabili di segno per aprire un processo rivoluzionario e appropriarsi della ricchezza prodotta che è invece largamente distruttiva e mette a dura prova la sopravvivenza dell’intero mondo e la sua riproduzione. Non a caso Silvia Federici allarga il concetto di riproduzione alla cura dell’intero eco-sistema e sostiene (molto acutamente) che la cooperazione necessaria a un processo rivoluzionario è qualitativamente diversa dalla cooperazione lavorativa capitalistica che, come abbiamo visto, è strutturalmente innervata di differenze e gerarchie, aprendo anche qui uno squarcio sulla distruzione di saperi e cooperazioni costruite sulle lotte di resistenza da parte del capitale.
Conclude Silvia Federici: “Assumere che lo sviluppo del capitalismo è inevitabile, o necessario in qualsiasi periodo storico, nel passato come nel presente, significa (…) porci dall’altra parte delle lotte che tanti hanno fatto per resistere all’avanzare dei rapporti capitalistici”, e aggiunge che sono “le comunità più coese e non le più industrializzate che si sono mostrate capaci di resistere alla privatizzazione delle rimanenti risorse comuni”.
In questo versante si colloca l’aspetto più critico e attuale del lavoro di Federici quando, facendo riferimento alle lotte e alle pratiche delle comunità indigene, delle correnti di “femminismo popolare” e al pensiero di Vandana Shiva, Maria Mies e Ariel Salleh indica come via alternativa alla tradizione marxista quella che chiama la politica dei commons che si appoggia sulla difesa e la costruzione di comunità popolari e sul recupero di saperi e tecnologie locali che possono fare da argine alle devastazioni del capitalismo predatorio.
La politica dei commons vuole così rovesciare il primato marxista della produzione come terreno di lotta per privilegiare quello della riproduzione riscattandolo dall’isolamento capitalista per la sua riorganizzazione cooperativa.
Silvia Federici riporta varie esperienze “di forme più collettive di riproduzione e la creazione di commons riproduttivi” dove “la sfera domestica, così come i quartieri e le città” possono “essere trasformate costruendo nuove forme di vita e lavoro in comune”.
L’enfasi sul lavoro riproduttivo (e sulla sua gratuità intesa come dono e cura) nelle comunità rischia forse di “rinaturalizzare” l’identificazione delle donne con la funzione riproduttiva che proprio le esperienze da cui proviene l’autrice avevano così ben decostruito. In questo stesso volume sono contenuti due saggi molto rilevanti sulla questione. (“L’invenzione della casalinga a tempo pieno” e “Origini e sviluppo del lavoro sessuale negli Stati Uniti e in Gran Bretagna”).
In conclusione un libro di poco più di un centinaio di pagine dense e indispensabili che raccoglie scritti dagli anni ’70 fino ad oggi, a un passo dall’epidemia del Coronavirus, dandoci strumenti di lettura – e resistenza – anche per contrastare questa emergenza mondiale che mette al centro nel modo più drammatico la riproduzione della vita.