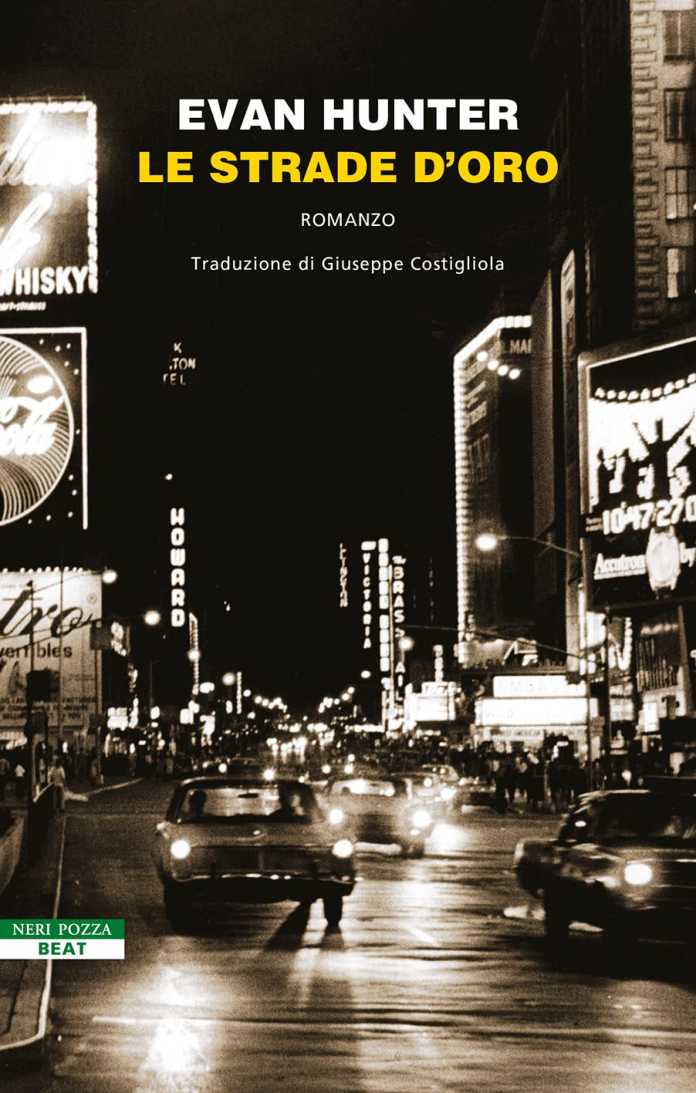Libro della memoria, Le strade d’oro narra la storia di una famiglia di immigrati, giunti negli Stati Uniti dalle remote lande italiche, e del suo rampollo, un musicista jazz cieco che si fa chiamare Ike, dietro le cui fattezze si cela in realtà l’autore stesso. Evan Hunter, all’anagrafe Salvatore Lombino, fu scrittore estremamente prolifico, impegnato nel cinema e nel romanzo giallo, del quale ridefinì i canoni con sagacia, sfuggente per il vezzo di occultare la propria autorialità dietro numerosi pseudonimi, come quello di Ed McBain. Libro autobiografico, dicevamo, segnato dall’intuizione, feconda di conseguenze, di marcare il protagonista con le stimmate della cecità, elemento che lo pone sin dal principio dalla parte degli emarginati: “C’è una certa analogia tra essere ciechi ed essere neri, e io ne compresi pienamente l’impatto per la prima volta negli anni Quaranta, quando iniziai a suonare il jazz. Fu allora che capii quant’erano stati sciocchi quei ragazzi di Park Avenue. Non li aveva sfiorati nemmeno per un istante l’idea che stavano solo picchiando un altro negro. […] Lasciamo stare la cecità; adesso mi rendo conto che siamo tutti negri”.
 Il sogno americano, quel paese immaginario lastricato d’oro vagheggiato dai migranti che lasciano l’Italia per inseguire la fortuna nel nuovo mondo, mostra sin dal principio le sue crepe. Il tempo, legato alla memoria e alla musica, è il protagonista del libro, così come accade per il cinema di Sergio Leone. Nel leggere il romanzo, è inevitabile pensare a C’era una volta in America, o alle grandi saghe filmiche di Scorsese, popolate da italoamericani; un mondo che viene restituito in tutte le sue ritualità e sfaccettature, perché Hunter è scrittore ardito, dallo stile vario e ricco di umorismo. Si pensi alla scena in cui il protagonista perde la verginità, orchestrata come un pezzo jazz, con la sua propulsione dinamica e i suoi assolo. C’è tutto in questo libro; c’è la dura vita degli immigrati italiani, descritta con partecipazione ma anche con ironia, c’è la guerra, con la morte insensata del fratello Tommy, e c’è la cultura pop americana, che si riflette nella pluralità stilistica.
Il sogno americano, quel paese immaginario lastricato d’oro vagheggiato dai migranti che lasciano l’Italia per inseguire la fortuna nel nuovo mondo, mostra sin dal principio le sue crepe. Il tempo, legato alla memoria e alla musica, è il protagonista del libro, così come accade per il cinema di Sergio Leone. Nel leggere il romanzo, è inevitabile pensare a C’era una volta in America, o alle grandi saghe filmiche di Scorsese, popolate da italoamericani; un mondo che viene restituito in tutte le sue ritualità e sfaccettature, perché Hunter è scrittore ardito, dallo stile vario e ricco di umorismo. Si pensi alla scena in cui il protagonista perde la verginità, orchestrata come un pezzo jazz, con la sua propulsione dinamica e i suoi assolo. C’è tutto in questo libro; c’è la dura vita degli immigrati italiani, descritta con partecipazione ma anche con ironia, c’è la guerra, con la morte insensata del fratello Tommy, e c’è la cultura pop americana, che si riflette nella pluralità stilistica.
Un inserto presentato come una pièce teatrale dal titolo Rashomon, nel quale si descrivono le presunte avance sessuali di un cinese nei confronti della piccola Stella, richiama la complessità stilistica e strutturale di Moby Dick, che Hunter ha certamente ben presente. L’allusione al noto film di Kurosawa implica una riflessione sulla menzogna, sull’impossibilità di decifrare la realtà e l’esatto svolgimento dei fatti. C’è ancora la cultura ebraica (la moglie di Hunter era ebrea), restituita con una sottile ironia che a volte evoca l’universo filmico di Woody Allen, altre quello narrativo di Philip Roth. La tematica del matrimonio interreligioso si esplicita nell’ostilità del padre di Rebecca, il quale non vorrebbe assolutamente accogliere un gentile nella sua famiglia, salvo poi ricredersi quando il genero diviene ricco e famoso. C’è infine la musica, una cavalcata negli anni ruggenti dal jazz, dall’esplosione del Bop, vera e propria rivoluzione culturale e linguistica, fino all’avvento del rock all’inizio degli anni Sessanta, che segna la fine della brillante carriera del protagonista. Il mondo muta continuamente, e chi non riesce ad adattarsi al cambiamento viene inevitabilmente escluso. Anche quando il jazz sembra vivere una seconda giovinezza, Ike non ne approfitta; ha perso ormai il gusto di suonare.
Hunter descrive le pericolose dinamiche del successo, insaziabile bestia famelica, che può giungere inaspettato e altrettanto rapidamente estinguersi. La fama, in definitiva, non è frutto di volontà ma deriva dal caso, dai capricci incontrollati della sorte. Assillato dai ricordi, l’autore è costretto a narrare, ben sapendo che non riuscirà a dire tutto, che dovrà riempire i vuoti, che molto resterà fuori dal suo libro, che la vita non si lascia rinchiudere in un numero, per quanto ampio, di pagine. “I sogni sono bugie”, afferma Ike, e allora non può far altro che assistere allo sgretolarsi delle proprie utopie, contribuendo volontariamente al loro annientamento, non può far altro che rovistare fra le macerie, sapendo bene che raccoglierà solo polvere. “E io non esisto. Io sono il prodotto dell’immaginazione americana”. Il mito dell’uguaglianza, garanzia di opportunità per tutti, motore del sogno libertario, nasconde masse di reietti, esausti e affamati. Realtà e illusione si mescolano restando indistinguibili, mentre l’individualità annega nell’oceano oscuro e profondo del sogno americano.