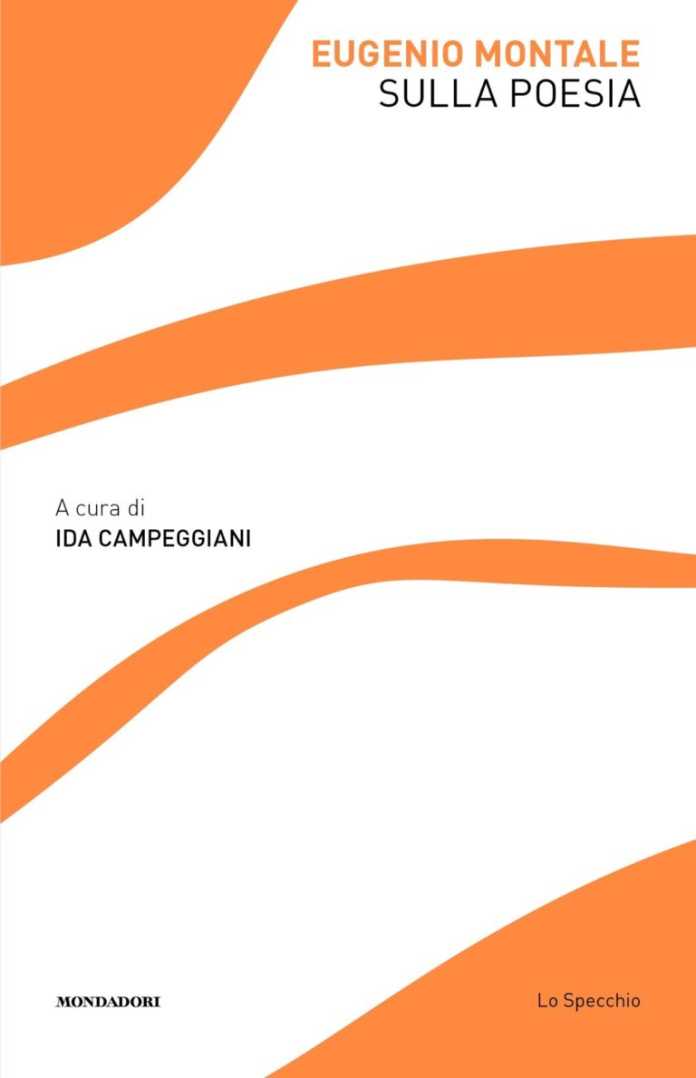Un classico che ritorna nell’opportuna cura di Ida Campeggiani, seguendo l’edizione curata da Giorgio Zampa nel 1976. E rimettendo gli scritti nella corretta cronologia e ripuliti di numerosi refusi e inesattezze nell’indice e all’interno di quel volume. Montale evitò sempre di ordinare un testo strutturato di critica letteraria, ma fu Zampa – concorde con l’idea che già Luciano Anceschi nei Lirici nuovi lanciava ritenendo opportuna una edizione degli “scritti letterari” del poeta – a ordinare un indice a cui Montale diede il suo consenso dopo aver abbozzato uno schema di massima. In questo caso, come il successivo Auto da fé, dato alle stampe nella pausa tra La bufera (1956) e Satura (1971), si tratta di un libro più che composito dove vengono riuniti articoli usciti su riviste e giornali, discorsi (come quello tenuto in occasione del Nobel), interviste e autocommenti, prefazioni e recensioni varie.
 La realtà della poesia osservata da Eusebius, poeta ligure a cui il mare infondeva più timore che fedeltà, e dunque quasi mai allontanandosi della concretezza terrestre (quanta attenzione è stata dedicata dai critici novecenteschi al suo “abbandono” delle radici optando per regioni e città ben lontane dalla Riviera?), si fonde in lungo e in largo e parallelamente alla scrittura dei suoi versi: quella famosa “leggerezza”, chiave che mette in chiaro la memoria, i sogni, le digressioni incontrate durante la lettura sia delle singole raccolte (il Libro a cui ha dato vita nel corso di un trentennio, e il successivo “secondo tempo”) che di questo Sulla poesia. Dove si comprende, ed è messo bene in evidenza da Campeggiani nel saggio introduttivo, che il Montale poeta fa perennemente a meno del Montale critico. La consapevolezza del primo è tale da consentirgli una netta mancanza di risonanza col secondo. Di questo siamo pacificati noi che amiamo Falsetto, Carnevale di Gerti e Dora Markus, così come lieti di ancorarci agli impulsi argomentativi su Sbarbaro, Zanzotto, Sereni e Shakespeare.
La realtà della poesia osservata da Eusebius, poeta ligure a cui il mare infondeva più timore che fedeltà, e dunque quasi mai allontanandosi della concretezza terrestre (quanta attenzione è stata dedicata dai critici novecenteschi al suo “abbandono” delle radici optando per regioni e città ben lontane dalla Riviera?), si fonde in lungo e in largo e parallelamente alla scrittura dei suoi versi: quella famosa “leggerezza”, chiave che mette in chiaro la memoria, i sogni, le digressioni incontrate durante la lettura sia delle singole raccolte (il Libro a cui ha dato vita nel corso di un trentennio, e il successivo “secondo tempo”) che di questo Sulla poesia. Dove si comprende, ed è messo bene in evidenza da Campeggiani nel saggio introduttivo, che il Montale poeta fa perennemente a meno del Montale critico. La consapevolezza del primo è tale da consentirgli una netta mancanza di risonanza col secondo. Di questo siamo pacificati noi che amiamo Falsetto, Carnevale di Gerti e Dora Markus, così come lieti di ancorarci agli impulsi argomentativi su Sbarbaro, Zanzotto, Sereni e Shakespeare.
Ci si chiede come questi autori abbiano influenzato la poesia di Montale, ma difficile rinvenirne reperti, se mai egli riesce a integrare come classici i poeti di Strumenti umani e La beltà nel canone messo in cantiere in quel lasso di Novecento da cui nessuno mai potrà prescindere. Si trova sguardo solerte in ogni pagina, ma come se una certa fretta dovesse compiersi nell’ambito certamente ristretto di uno scritto d’occasione: è l’idea di una tradizione a cui il poeta degli Ossi non può, e non vuole, rinunciare. Continuità vuole resistere a rinnovamento, l’ironia molto ligure si rivolge a quest’ultimo quando non possono sottrarsi all’attenzione del poeta certe esperienze di giovani autori toccati dalla “civiltà meccanica del nostro tempo” (in un’intervista datata 1931). Si ha come l’impressione, in queste interviste, che Montale tutto abbia visto e letto ma che si senta portato a far finta di niente. Ma, ancora accostandosi a Sereni, non si ammettono deroghe: nel campo recente (era il 1965) della poesia occorre “metter d’accordo l’occhio e l’orecchio”, né giustificarsi troppo col presupposto del “verso libero”, o accontentarsi di azzerare i vari livelli stilistici, azzardando un disastro. Gran epoca quella in cui si poteva affermare: “…i libri di poesia hanno il tempo dinanzi a sé e possono ignorare le leggi del rapido consumo”.