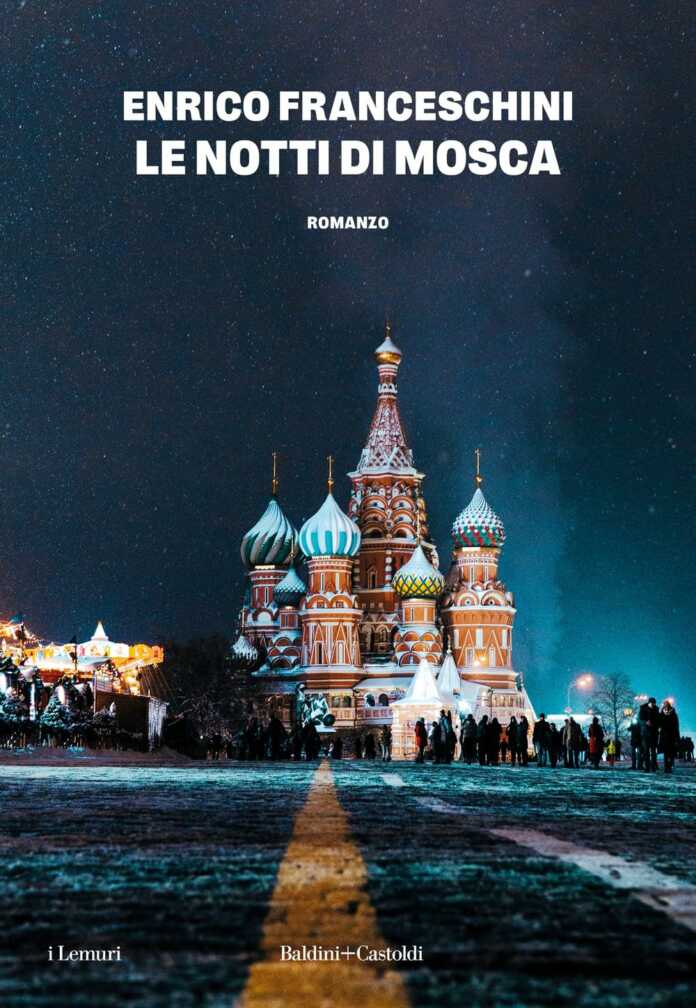La possibilità della riscrittura, di riscrivere, è forse una delle ultime – e ancora giovanissime – risorse che l’uomo ha per parlare a sé stesso e sopravvivere all’egoreferenzialità. Si possono riscrivere le storie e si può riscrivere la Storia. L’ucronia, così, nel suo oscillare tra la negazione dell’utopia e un tempo impossibile (che forse può prevedere tanti tempi, tutti insieme, nel dilemma shakespeariano di essere e di non essere), oltre a rappresentare un interessante genere di narrativa, è una prospettiva, un modo di vedere le cose.
Enrico Franceschini, già avvezzo all’uso dell’immaginazione in contesti storici (una sorta di realtà aumentata dallo scrittore che ne partecipa pur senza prendervi parte), nell’ultimo romanzo, Le notti di Mosca, rielabora la Storia della Russia a cavallo degli anni Novanta rovesciandone le sorti e ipotizzando uno scenario in cui, al posto di un capo guerrafondaio come Putin, fosse salito come presidente un europeista realmente democratico e amico dell’Occidente. Una Russia, quella immaginata alla fine di questo racconto, che non avrebbe attaccato, negli anni Venti del Duemila, l’Ucraina, evitando di provocare una ennesima e dolorosissima guerra di cui ha risentito l’economia di tutto il mondo.
La storia che presenta Franceschini, in cui storicità e storicizzazione si relativizzano in un tempo presente ipotetico ma del tutto verosimile, parla proprio della Russia di Eltsin al secondo conflitto contro la Cecenia, un conflitto evitabile che affonda le radici in storie di antichissime rivalità tra popoli, ma che trova l’espediente ultimo e feroce nella conquista del petrolio. Se già il filosofo Charles Renouvier aveva coniato il termine “ucronia” per riferirsi a quelle narrazioni che sostituiscono a eventi realmente accaduti in determinati momenti storici altri non reali ma credibili, moltissimi sono, nella Storia, i casi letterari, cinematografici, artistici e fumettistici che hanno sperimentato questo modello. Non ultimo, Emmanuel Carrère con il suo saggio omonimo (Adelphi), dissuasorio – fino a prova contraria – sull’esperimento di questa operazione intellettuale, affermando che “l’intento, scandaloso, dell’ucronia è invece quello di cambiare ciò che è stato”. Una prova contraria, a sostegno dell’ucronia, che Franceschini, con la sua lucida naturalezza espressiva, fornisce senza esitazioni, firmando un articolato e stratificato spaccato storico in cui il se dubitativo diventa un’alternativa che poteva essere possibile. E che, forse, possibile lo è tuttora.
Mi viene, a questo punto, in mente la provocazione di Adorno sulla possibilità – o l’inopportunità – di fare poesia dopo Auschwitz, riflessione a cui Paul Celan rispose con la sua indimenticabile poesia e, poi, con la sua morte. Ma, ancora di più, la proposta letterario-antropologica di Franceschini ricorda l’idea di tempo e di Storia di Walter Benjamin, tra materialismo storico e teologia rivoluzionaria (o meglio, una teologia che porta l’uomo a poter provocare la rivoluzione, ma l’elemento teologico non sembra presente in Franceschini, pur non mancando l’impeto rivoluzionario, tutto mondano e terragno).
Un diario storico-cronachistico, Le Notti di Mosca, con un andamento altamente verosimile che si basa su precisi riferimenti geografici e cronologici e che unisce la razionalità causalistica di un impianto storico – alle condizioni diversificatorie, però, succitate – al ritmo cinematografico di un thriller, di un action movie e di una spy story. La tipica, riconoscibile struttura di molti libri di Franceschini, che prende respiro dalla suddivisione in capitoli che sembrano vere e proprie scene di un film o di un atto teatrale, ricompone il quadro storico della Russia e del Regno Unito di fine secolo, ponendo il focus sul conflitto tra Russia e Cecenia, sulla dislocazione di molti oligarchi russi in una Londra ricchissima e fuori dal mondo, sui Troubles irlandesi con le loro lotte sanguinarie e, non ultimo, sul segreto lavorio delle intelligence locali, non senza l’aiuto di quei pochi individui che, divergendo dal sistema, cambieranno in concreto le sorti della storia.
La scena d’apertura è violenta quanto dolorosa e lascia affondare immediatamente il lettore nell’oscurità feroce di una efferata Russia di fine Novecento. Ma “i Russi non sono tutti uguali”, tiene a specificare con saggezza l’autore. Una donna è prigioniera, nuda, legata a una sedia e costretta a tenere le gambe aperte davanti a una schiera di soldati intenti a mangiare, come se nulla fosse: nelle loro uniformi si legge il simbolo dell’era zarista, l’aquila imperiale a due teste, ripristinato dopo il crollo dell’Unione Sovietica e la fine del comunismo. A terra, poco più lontano, giacciono i cadaveri martoriati di un uomo e tre bambini, immersi in una pozza di sangue: il marito e i tre figli di Selina, appena uccisi dai soldati proprio davanti ai suoi occhi. Una donna, Selina, che incarna lo spirito del suo popolo, i Ceceni.
La seconda guerra tra Russia e Cecenia era scoppiata solo quindici giorni prima di quella mattanza, dopo una serie di misteriosi attentati in case popolari alla periferia di Mosca: centinaia di morti furono ritrovati negli alloggi riservati alle famiglie della Milizia: prima vennero spacciati per vittime di una fuga di gas e poi furono confermati come vittime di esplosivo lì riposto intenzionalmente. Il nuovo ministro della difesa russo, Vladimir Volkov (nome d’invenzione ma con chiari riferimenti a fatti e personaggi contemporanei il cui operato è tristemente noto), non aveva tardato a specificare, mistificando le proprie responsabilità, che si trattasse di terroristi ceceni. Ma la verità, prima o poi, viene a galla, se non nella realtà almeno nelle storie. Era stato proprio Volkov, su esplicita autorizzazione del presidente Eltsin, in seguito a quegli attentati, a dare il via all’invasione della piccola regione a sud del Paese, la Cecenia. Era già la seconda volta in cinque anni.
Arsan, il marito di Selina, durante la prima guerra cecena contro la Russia aveva ucciso moltissimi soldati moscoviti, per questo lo chiamavano “la primula rossa”. Fino a poco prima di essere trucidato, era certo dell’innocenza dei ceceni: perché mai avrebbero dovuto attaccare di nuovo Mosca se erano stati vincitori? Ma, come spesso accade nella storia dell’uomo, dietro le faccende di principio, perfino e soprattutto quelle religiose e socio-politiche, si nascondono interessi economici, come quello per il petrolio.
La piccola ma preziosa Cecenia produceva, infatti, da sola, l’uno per cento dell’oro nero russo. I proventi di questa ricchezza, dopo il crollo dell’Urss del 1991, erano finiti nelle tasche degli oligarchi moscoviti che si erano spartiti tra di loro i beni dello Stato. Molti di loro, poi, scelsero una vita più agiata a Londra. Parte di questa enorme ricchezza finì anche a sostenere quella classe politica corrotta e senza etica che stava gestendo la privatizzazione dell’economia. «I Russi sono una stirpe di grandi guerrieri», come tiene a specificare Franceschini nelle sue accattivanti finestre di geopolitica. «Ma erano stati domati dagli zar. Si erano ribellati ancora e li aveva domati Stalin. Ci avevano riprovato qualche anno prima e nel caos della Russia post-comunista era parso davvero possibile liberarsi dalle catene. Poi Volkov è stato nominato ministro della Difesa». Volkov era un uomo senza morale e senza scrupoli, e i fatti che ci racconta l’autore lo metteranno ben in evidenza, così come la storia vera, che tutti conosciamo, ha messo in evidenza il sanguinario temperamento dell’attuale presidente del Cremlino. Selina, ancora viva, nuda e legata, aspetta il suo destino di tortura per mano dei russi. Ma, un attimo prima di ricevere quelle immani violenze sessuali davanti ai corpi straziati di suo marito e dei suoi figli, giunge una cascata di fucilate a falciare i suoi carnefici. E toccherà proprio a quei soldati russi di essere evirati, sgozzati e decapitati prima che possano fare ancora del male. Un attimo prima erano carnefici indefessi, appena dopo si sono ritrovati indifesi e, in meno di un minuto, erano tutti morti per mano degli abili combattenti ceceni.
Selina viene portata via, ancora priva di sensi per via di un forte colpo alla testa che aveva ricevuto da uno degli assalitori, assieme alle salme del marito e dei tre figli, avvolte in lenzuoli bianchi. Sarà in quell’occasione che Selina incontrerà Marco Bassani, il migliore amico di suo marito, colui che aveva condotto il commando di ribelli a uccidere gli assassini di Arsan e dei loro figli, e a trarla in salvo. Prima di abbandonare quella terribile scena, i ceceni lasciano un messaggio inequivocabile per i nemici moscoviti: appendono per i piedi i cadaveri dei soldati e conficcano le loro teste decapitate nei rami degli alberi. Sono certi che i destinatari del messaggio capiranno. La violenza è insita nella cultura cecena, è come un’altra faccia dell’amore, quella più coraggiosa e più istintiva forse, di certo quella più spietata. La mitologia racconta di tantissime avventure di eroi che si riprendono quello che gli era stato sottratto con la violenza o con l’inganno ma, nella realtà, dalla morte non si fa mai ritorno.
Marco Bassani aveva una storia particolare, era un italiano con un passato di “Giustizia proletaria” alle spalle. A quei tempi, pensava che fosse giusto ridistribuire la ricchezza dai ricchi ai poveri attraverso le rapine alle banche, evitando però la violenza. Non uccidere era la sua regola principale. Il periodo storico era complesso, era caduto il muro di Berlino e l’America aveva vinto la guerra fredda, non ultimo, era scomparsa l’Unione Sovietica. Marco, un giorno, aveva deciso di partire per un reportage in Cecenia, per seguire la prima guerra contro il Cremlino. Mentre era fuori, però, una delle rapine alle banche organizzate dalla Autonomia Operaia causò dei morti. Tutti i suoi compagni furono arrestati e uno di loro, decidendo di collaborare con la giustizia, fece il suo nome. Così, mentre si trovava in Cecenia, Marco divenne un ricercato.
I ribelli ceceni gli proposero ospitalità e Marco, a quel punto, preferì abbandonare la moglie e il figlio rimasti in Italia piuttosto che essere arrestato e condannato per qualcosa che non aveva desiderato e che, soprattutto, non aveva commesso. Viveva con la speranza, un giorno, di riuscire a dimostrare la sua innocenza o di ottenere un’amnistia ma, nel frattempo, scoppiava la seconda guerra di Cecenia. Sarà in questa circostanza che Marco imparerà a sparare davvero, a uccidere per difendere sé stesso e gli altri. Forse, però, le ragioni che spingevano Marco a rimanere lì, in una terra che aveva imparato a conoscere ma a cui non apparteneva, erano altre, battevano nel petto e avevano il volto di una donna inarrivabile. Selina, la moglie del suo migliore amico, ormai defunto. Una vedova musulmana che mai avrebbe potuto amare un infedele. Marco, come specifica Franceschini, è un personaggio ispirato alla storia di Adriano Sofri e, come sempre, l’immaginazione è un pezzo di realtà vista in modo diverso.
Un bravo narratore lascia che i presagi emergano dalla sua scrittura, così da poter creare un reticolo di storie apparentemente lontane e separate tra loro ma che si dimostrano essere tutte intimamente congiunte. La precisa scansione cronologica che opera Franceschini, reale o d’invenzione che sia, sembra reinventare quella narratologica, lasciando che si alternino i fatti, gli eventi, le persone, le storie e che si mischino i luoghi, per altro descritti sempre in modo puntuale, con un ritmo espositivo veloce, cinematografico. O, ancora meglio, giornalistico. I riflessi biopolitici, perfettamente evidenziati da un capitolo all’altro, creano una concatenazione temporale e geo-politica razionale e unitaria. Il narratore, quando è onnisciente ma sa porsi in dialogo con la curiosità del lettore, amalgama e intreccia eventi e personaggi in modo non solo logico ma anche psicologico, raccontando la Storia attraverso la lente dell’interiorità degli stessi personaggi che la costituiscono così come, in fondo, accade nella vita.
Non a caso, l’autore afferma che “Un bravo giornalista parte sempre per un servizio di lavoro con un romanzo in valigia, ambientato nel luogo che si appresta a visitare. La narrativa è la chiave per capire, o almeno per avere una bella citazione da inserire in un pezzo: ai giornalisti servono anche quelle”. Si passa velocemente – proprio a significare la consustanzialità di vite e di situazioni completamente diverse e distanti – dalla macroscopica Russia, gremita di popolazioni diverse e non sempre compatibili fra loro, alla Londra glamour degli oligarchi russi e dei loro ricchi avvocati, come all’Irlanda di metà anni Novanta, attanagliata da trent’anni di conflitti tra cattolici e protestanti. Il famoso poeta irlandese Michael Longley, da poco venuto a mancare, ha dedicato alla guerra in generale e alla guerra civile nell’Irlanda del Nord, cioè ai Troubles in particolare, molte poesie, tra cui spiccano questi versi dal titolo omonimo: «Pensa ai bambini/nascosti nelle bare./Guardalo in faccia, il dolore./Quei trent’anni chiamali/gli Anni del Disonore». Un “disonore”, scritto in lingua originale con il termine “disgrace”, che ha a che vedere con lo scandalo, con la rivolta, con la disgrazia portata dalla rivolta e con uno spirito prettamente antimilitarista. Due concetti, quello di onore e di disonore, due facce della stessa medaglia, che si incontrano lungo tutto il discorso letterario e metaletterario di Franceschini e che sondano le trame più fitte dei rapporti dinastici, antropologici e sociologici dei popoli che racconta.
La grande Storia influenza le piccole storie delle persone coinvolte ma sono proprio queste piccole storie a rivoluzionare la grande Storia. Una Storia che non è mai finita, men che meno nel XX secolo, come invece aveva, forse utopisticamente, ipotizzato il politologo Francis Fukuyama e che, oltre a non essere universale e a non tendere a modelli univoci, si costruisce anche in base alle vite dei singoli individui. Così, una storia d’amore improbabile e mai consumata funge da motore per la trasformazione della Storia della Russia. E a cambiare tutto sarà una donna, una “vedova nera” che con le sue azioni e il suo coraggio ha permesso alle donne e agli uomini del suo popolo di tornare a vedere il futuro a colori. Ciascun lettore, ciascun critico è quindi chiamato non solo allo sforzo di immaginazione di un testo che, ben lontano dalla fantascienza e dalla distopia, riscrive le risultanze storiche per continuare a sperare in tempi più umani, ma anche a quello ben più pesante di autocritica: cosa siamo disposti a cambiare di noi stessi per mutare il corso degli eventi?