“La vita che conduco a Parigi mi spinge ogni giorno verso un tracollo psichico […]. Non avrei mai creduto di essere capace di tanto fallimento e che la paura, insita in me, mi avrebbe spinto a tanta dissolutezza e a tanto vuoto. Da mattina a sera girovago tra immigrati, sfaccendati e imbecilli, oziando nei caffè in uno stato confusionale, sull’orlo della follia. […] Forse sono malato. Ma, ad essere sincero, a cosa mi servirebbe la salute? Non mi condurrebbe verso un disastro peggiore? Sento di non poter più avere amici, di non poter più avere nessuno. […] Sono esperto solo di agonie”. Così scriveva il ventisettenne Emil Cioran all’amica Jeni Acterian il 28 novembre 1938.
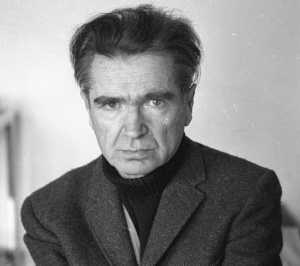 A Parigi il giovane Emil era giunto nel 1937 dopo aver ottenuto una borsa di studio dall’Istituto francese di Bucarest con l’“imbroglio”, dichiara egli stesso, di dover scrivere una tesi di dottorato; trovandosi cioè squattrinato – miseria nella miseria – si risolse in quell’astuzia, desideroso com’era di portarsi sotto al “cielo malinconico” di una città che riconosceva gemello della sua mestizia. Incapace di rinnovarsi la vita e fiaccamente abbandonata alla nostalgia di un passato fastoso, incastonato come una reliquia in ogni scorcio, la sterile Parigi andava infatti diventando ricettacolo di reietti e falliti che, ammaliati da quella grigia estetica della fine, lì si conducevano per coltivare la propria infelicità, tuttavia “gradevolmente”, come ebbe a scrivere il Cioran corrispondente per il giornale romeno Cuvântul.
A Parigi il giovane Emil era giunto nel 1937 dopo aver ottenuto una borsa di studio dall’Istituto francese di Bucarest con l’“imbroglio”, dichiara egli stesso, di dover scrivere una tesi di dottorato; trovandosi cioè squattrinato – miseria nella miseria – si risolse in quell’astuzia, desideroso com’era di portarsi sotto al “cielo malinconico” di una città che riconosceva gemello della sua mestizia. Incapace di rinnovarsi la vita e fiaccamente abbandonata alla nostalgia di un passato fastoso, incastonato come una reliquia in ogni scorcio, la sterile Parigi andava infatti diventando ricettacolo di reietti e falliti che, ammaliati da quella grigia estetica della fine, lì si conducevano per coltivare la propria infelicità, tuttavia “gradevolmente”, come ebbe a scrivere il Cioran corrispondente per il giornale romeno Cuvântul.
Devastato da una renitente insonnia e dagli assedi tesi dall’orrore di sapersi al mondo e, perdipiù, ripugnantemente pensante, l’“apolide metafisico” Emil, doppiamente disgraziato per sostanza e accidenti, in quel biennio decise di costringersi alla fatica per sottrarsi ai veleni della disperazione: con pochi franchi recuperò una bicicletta da corsa e per mesi si condusse per la Francia al solo scopo, scrive Antonio Di Gennaro nella Postfazione, di “camminare e pedalare” per non cedere alla tentazione di “gettarsi nelle acque della Senna e chiudere così, definitivamente e anticipatamente, i conti con la propria tormentata esistenza”. A quel provvidenziale sfiancarsi il corpo, sonnifero insperato, Cioran sommò la scrittura, sola terapia al ribollire delle sue radicate scissioni, impresse su carta tanto per la vanità e “l’orgoglio del sofferente”, direbbe Nietzsche, quanto per l’esigenza di indagarsi in uno specchio; prova ne è questo denso libricino.
Composto proprio tra il ’37 e il ’38, come Eugène van Itterbeek deduce nell’Introduzione, il Taccuino per stenografia dà l’idea d’essere un febbrile appuntarsi gli scarti dell’io, un addomesticarsi le ossessioni prima che queste possano indurlo a soccombere: “mi sono perso nelle Lettere per l’impossibilità di uccidere o di uccidermi. È stata solo questa incapacità, questa vigliaccheria a far di me uno scribacchino”, avrebbe infatti confessato più tardi nei suoi Cahiers. A questa urgenza, nucleare alla scrittura fin dagli esordi e quindi anche al suo Taccuino, l’autore affianca lo stile meglio atto a risolverla, il solo in grado di rifuggire il discorso e di resistere alle tentazioni del principio-di-non-contraddizione, straniero sgradito all’ondeggiare del disperato: aforisma e frammento, ecco le uniche chiavi di chi ha appreso “la paura in mezzo alle parole, quella paura di crollare con tutte le parole”, per citare il più noto Sillogismi dell’amarezza. Dunque accenni, folgorazioni, abbozzature, dispersioni che disdegnano paletti e fissità a vantaggio di uno scetticismo metodico con cui tallona il rischio dell’accordo, lasciando liberi i segni di immolarsi alla causa dell’al di sotto della vita e al di sotto della morte: eccedere la forma per eccellere nel lamento.
 “Lacerato dal desiderio struggente di morire”, che pur resistente rabbonisce, l’“incontaminato dalla felicità” Cioran raschia quindi il fondo della propria pena scongiurando la vergogna di una finale capitolazione: “fino a che punto/ veglierò la mia nullità?”, si chiede infatti e lo si immagina nella stoica ambascia del marmoreo Laocoonte, aureliano nel midollo, costretto a strozzarsi l’urlo nella bocca. Tuttavia l’inciampo e il rischio della resa alla forza annichilente saltano all’occhio nella continua riscrittura, nelle cancellature frequenti, nella calligrafia spesso indecifrabile che firmano la caduta evitata, raggirata, punita per un soffio. Ora in romeno ora in francese, alla ricerca forse di una radice-lingua o di un dizionario che possa infine rattenergli il delirio e contenergli il nomadismo del filosofo, si scarnifica dunque nell’esercizio del domatore che tenta d’ammansire la violenta indecenza dei suoi demoni e la voce sinistra che lo vorrebbe finito.
“Lacerato dal desiderio struggente di morire”, che pur resistente rabbonisce, l’“incontaminato dalla felicità” Cioran raschia quindi il fondo della propria pena scongiurando la vergogna di una finale capitolazione: “fino a che punto/ veglierò la mia nullità?”, si chiede infatti e lo si immagina nella stoica ambascia del marmoreo Laocoonte, aureliano nel midollo, costretto a strozzarsi l’urlo nella bocca. Tuttavia l’inciampo e il rischio della resa alla forza annichilente saltano all’occhio nella continua riscrittura, nelle cancellature frequenti, nella calligrafia spesso indecifrabile che firmano la caduta evitata, raggirata, punita per un soffio. Ora in romeno ora in francese, alla ricerca forse di una radice-lingua o di un dizionario che possa infine rattenergli il delirio e contenergli il nomadismo del filosofo, si scarnifica dunque nell’esercizio del domatore che tenta d’ammansire la violenta indecenza dei suoi demoni e la voce sinistra che lo vorrebbe finito.
Lungo il piano inclinato di tanto assillo, corrotto dall’implacabile necrosi del tempo che lo certifica fignolo effimero dell’universo, Cioran inoltre imita l’esercizio del mistico, provando a figurarsi l’eterno col tramite della bellezza, tempio lucreziano che si erge, tracotante poiché imperituro, sulle vite degli uomini inverminiti da affanni e travagli. “La mia aspirazione”, appunta, è “essere giornalista dell’eternità”, ovvero di strappare intuizioni all’eterno che lo rifiuta, dei lampi capaci di fargli assaporare l’ipostasi dell’atemporale e da fissare, con la prontezza dello stenografo, su carta. Lì dove il brutto gli documenta dunque l’umano fallire, il bello, specie se è della musica, gli apre invece le porte del paradiso perduto, benefica sbirciatina che si fa ristoro dall’“oscuro orrore carnale dei sentimenti quotidiani”. E aggiunge: “ciò che turba in maniera così misteriosa dinanzi alla bellezza è che in qualche modo essa ci dispensa dal vivere. Il tempo si pietrifica […]. La vita invidia tutto ciò che resiste al logorio inutile”. Dispensatosi dal vivere quanto dal morire, votato allo smacco come è chi esiste sapendo di esistere, Cioran avrebbe continuato dai Trenta a riversare sulle pagine quel trascinarsi nel bilico tra la “soglia del canto” e quella dell’abisso, non smentendo mai le ragioni della disperazione di chi vaga senza fari con l’irreparabile certezza di non addirsi al vicolo cieco del cosmo.
Ciò che questo Taccuino consente di comprendere è però il lavoro gestazionale che precede un’opera, l’annotarsi il rimescolio dei pensieri non solo con la necessità terapeutica di cui si è parlato, ma anche con l’intento di accumulare materia embrionale da riorganizzare per le stampe, fine che giustifica la presenza di ripetizioni tra le pagine, tipiche del rimacinare dello scrittore. Non è un caso, infatti, che in buona parte di questi frammenti, segnala ancora Eugène van Itterbeek nell’Introduzione, si ritrovino già dei passi di Amurgul gândurilor, pubblicato a Sibiu due anni più tardi, ragione che spinge a supporre l’esistenza d’altri quadernetti preparatori, veri e propri feticci per gli avidi lettori del pessimista. In secondo luogo il Taccuino, testimone di un tempo, ci permette di indagare il Cioran degli anni del transito, dapprima fisico, poi via via anche linguistico, in terra francese, consentendoci di spiarne le tribolazioni e i patimenti quotidiani, ulcere evidentemente antiche destinate a sanarsi mai.
Inchiodato al muro del pianto il suicidio come unica arma in suo potere, sebbene infine come deterrente per non cedere al proprio assassinio, lo si immagina dunque fin dalla giovane età stramazzato dall’impotenza della sua lucidità, che vorrebbe barattabile con la ridente pazzia degli idioti, e consumato dai tarli delle sue incurabili ossessioni. In andirivieni per l’angusta cella che la sua stessa solitudine metodica aveva eretto, a soli trentotto anni, egli stesso avrebbe poi listato il suo epitaffio in Sommario di decomposizione, donandoci l’autoritratto di chi ebbe in sorte il fardello della nascita al solo scopo di apprendere l’abominio del desiderarsi morti: “[…] Dimenticò felicità e infelicità, seti e paure; e se gli capitava di ricordarsene, disdegnava di nominarle e di abbassarsi così alla speranza o al rimpianto. Il minimo gesto gli costava più sforzi di quanti non costino ad altri per la fondazione o il rovesciamento di un impero. Nato stanco di essere nato, volle essere ombra: quando visse dunque? E per colpa di quale nascita? E se, vivendo, portò il suo sudario, per quale miracolo riuscì a morire?”.




