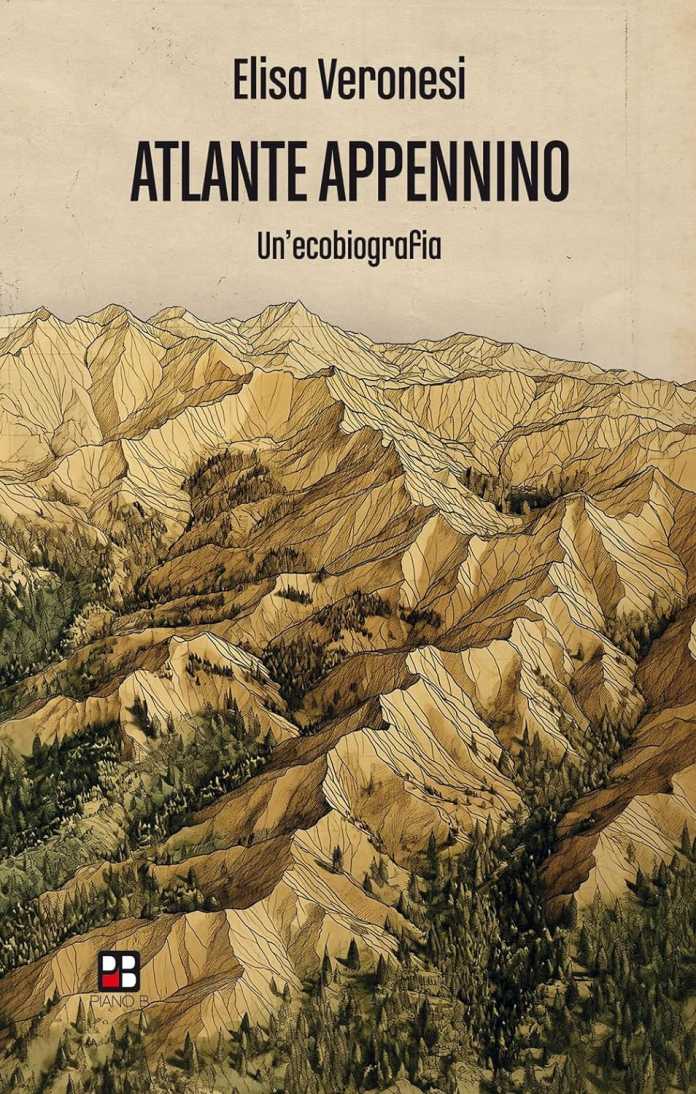Se c’è un modo eterodosso di accostarsi a questo libro di Elisa Veronesi, può essere quello di ricordare come negli ultimi tempi sembri essersi acquietata la tendenza letteraria verso l’autofiction, mentre si è aperta la strada verso autobiografie e biografie, per così dire, “ibride”. Lo si è accennato anche nel caso dell’Autobiogrammatica di Tommaso Giartosio: emergono ora varie testualità che, nell’architettura complessiva e nelle singole scelte formali, deviano dai canoni dell’auto/biografia e lasciano emergere spazi di manovra – spesso collocati al di là della semplice identificazione empatica – in genere inediti e molto interessanti.
È il caso di Ecobiografia, dove il côté autobiografico (per un’autrice, originaria dell’Appennino reggiano, che dedica il proprio libro in modo particolare all’Appennino nord-occidentale) è solo uno dei tanti risvolti del testo. Sulla scorta di un’altra “ecobiografia” dichiarata come Je est un nous. Enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant (Actes Sud, 2021) di Jean-Philippe Pierron, Veronesi mira, infatti, a delineare, nell’ecosistema testuale, un’ecologia vissuta e teorizzata che dia conto di quello che è, in effetti, racchiuso nel titolo: Atlante Appennino. E se, tra le tante direzioni, quella dell’Atlas warburghiano è solo rapidamente accennata dalla presenza di un’immagine (p. 128) – prospettandosi, nel corso della lettura, come un interessante sviluppo impensato per il futuro – Atlante Appennino è il risultato di aggregazioni testuali multiple, che vanno dal saggio alla narrativa breve, passando per elementi paratestuali che eccedono la mera funzione dell’esergo e tendono verso il collage di citazioni.
A questo proposito, la costellazione di riferimenti bibliografici è in effetti vastissima e copre territori che vanno dalla narrativa italiana del Novecento ingiustamente ritenuta, per lungo tempo, “minore” (Silvio D’Arzo, Raffaele Crovi o il Guido Cavani di Zebio Còtal) al saggismo internazionale più recente e più hype (Barry Lopez, Arne Naess, Baptiste Morizot e, soprattutto, quel Timothy Morton che consente a Veronesi, con arguta elaborazione, di parlare di “Iperoggetto Appennino”, p. 46). Non manca anche la produzione italiana contemporanea, con autori come Claudio Kulesko (soprattutto per Ecopessimismo, uscito sempre per le edizioni Piano B nel 2023), Matteo Meschiari (inevitabile il riferimento a Disabitare, del 2018, per un Appennino che, in molte sue regioni, si costituisce proprio come luogo paradigmadico del “disabitare”) o Marino Magliani (per le sue tante narrazioni liguri della verticalità montana, insieme all’orizzontalità della costa, come ad esempio Peninsulario, del 2022). Per non parlare di Silvano Scaruffi, ora nelle librerie con Romanzo di crinale per Neo Edizioni, che, tra l’altro, fa capolino nel libro all’interno di una delle parti autobiografiche più emozionate e emozionanti, il concerto notturno del gruppo garfagnino Staindubatta (“dove lo metti sta”, nel dialetto locale).
A proposito sempre delle narrazioni brevi che compongono il libro, Veronesi ricorre di volta in volta a marche generiche diverse e disparate per raccontare alcune storie che sono rimaste sottaciute, rispetto alle ultime decadi dell’Appennino, e sulle quali è invece importante tornare da molteplici prospettive culturali e politiche. Si può osservare, ad esempio, come l’impatto di una, seppur quantitativamente piccola ed economicamente debole, “turistificazione” abbia inciso sulla memoria dei luoghi: “il racconto di quegli anni partigiani venne messo a tacere da una famiglia che aveva altri ideali, e la liberazione femminile rimase incagliata in una vita di lavoro estenuante a preparare quintali di cibo per gli avventori di una trattoria” (p. 108). Ancor più rilevante la storia di come, nell’Appennino reggiano, ma anche in altre zone dell’Appennino settentrionale, “la roba aveva cominciato a risalire regolarmente il fondovalle negli anni Ottanta e Novanta. Arrivava dal fondale, dalla via delle ceramiche” (p. 142), intendendo con questo una forte trasformazione socio-culturale di fondo, arrivata con la diffusione di droghe precedentemente legate ai contesti urbani.
Negli stessi anni, emergono altri processi socio-economici più generali, come la fine della mezzadria (per effetto della legge 203/1982) o l’entrata in vigore del trattato di Schengen, ricordato attraverso un’intervista di Francesco Biamonti (autore caro a Veronesi, come anche a Magliani e Meschiari): “Noi europei abbiamo dei privilegi. Ci siamo creati una libera circolazione, un salotto tra le rovine. Sempre meglio di niente. Un sogno si è avverato: l’Europa legale e senza frontiere. Le tristi luci dei posti di guardia si sono spente sulla costa massacrata dal turismo di massa e dalla speculazione edilizia. Ma nei dirupi, che furono dei pastori di capre, la vita continua a far paura”.
I flussi migratori di classe e la loro disciplina hanno riconfigurato, almeno negli ultimi trent’anni, un paesaggio che, tuttavia, non è mai stato legato unicamente alle dimensioni localistiche del paese e della provincia. Anche questo è uno dei problemi della riconfigurazione, materiale e immaginaria, di un Appennino che, in questo Atlante, appare legittimamente identificato come luogo “plurale” (p. 14), “che non ha un immaginario preciso, […] luogo periferico, di passaggio» (p. 38) e molto altro ancora, insieme al «suo specifico genius loci che, tuttavia, permane refrattario a narrazioni e storie in grado di creare un immaginario radicato, una mitologia appenninica del racconto” (p. 79). Refrattarietà che Veronesi affronta, decostruisce e ricostruisce in un movimento continuo che è anche quello di un fintamente immobile Appennino: movimento, come purtroppo si sa, che è spesso sismico tanto a livello materiale quanto dell’immaginario. Dove lo metti sta, dunque, e al tempo sta non sta: anche grazie a questo libro, continua a muoversi.