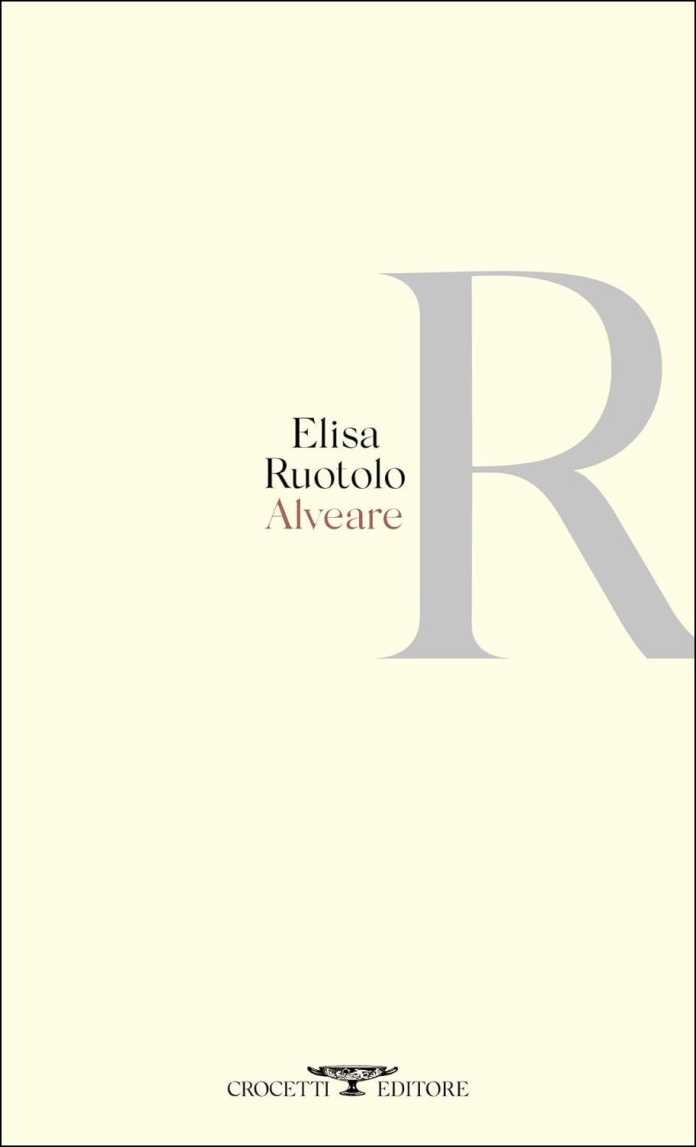Il punto di vista delle api è un destino, un pensiero “esteso” in singoli corpi uniti nello Sciame. Per questo, credere “in una casa significa ipotizzare Dio”. L’alveare è il mondo, è quel che noi umani possiamo ipotizzare – attraverso la vista e la poesia – sulle potenzialità della vita, mentre avviene, dando risorse a un tempo perché non avvenga la sua fine.
In fondo è uno dei compiti della poesia, della creazione umana quando afferma qualcosa di nuovo. Che accarezza e trafigge, molto più di quanto fanno le api. Saranno invadenti, come qualcosa di sacro, saranno eternamente rinnovate stagione dopo stagione, saranno cittadine di uno spazio buio però fervente, ma non certo sfrontate quanto l’uomo. Fanno del dovere il vuoto e il pieno di molteplici esistenze, da tempo immemorabile. Ogni singolarità è tutto il corpo dello Sciame, così come ogni verso è tutto il corpo della poesia, fuori e dentro questo libro che sembra emergere da una generazione perduta di poetesse, mai più riconfermata.
 Dopo lo scossone ai “tempi atrofizzati”, compiuto con Corpo di pane, Elisa Ruotolo entra nel destino della forma più composita della vita, accosta l’apicoltore nel suo penetrare gentile l’alveare, osservando il lavoro e la moltitudine dilaniato fra amore e calcolo, pretesa. È la stessa pretesa che fa fragili gli scrittori quando fra naturale e artificiale restano fuori scala nelle loro intenzioni alle prese con il pensiero poetico.
Dopo lo scossone ai “tempi atrofizzati”, compiuto con Corpo di pane, Elisa Ruotolo entra nel destino della forma più composita della vita, accosta l’apicoltore nel suo penetrare gentile l’alveare, osservando il lavoro e la moltitudine dilaniato fra amore e calcolo, pretesa. È la stessa pretesa che fa fragili gli scrittori quando fra naturale e artificiale restano fuori scala nelle loro intenzioni alle prese con il pensiero poetico.
Debolezza degli umani che li determina, al contrario delle api che – se mai attaccate dai veleni, dalla peste – dopo il nulla per loro esiste la Città, dove nessuno riposa e l’ordine genera il sapore. Bisogna intendersi: la città degli uomini non è come la Città delle api, la nostra peste è diversa dalla loro, anche se al dunque la stessa condanna apparterrà a entrambi.
In Alveare ci sono geometrie che riguardano le due specie, Ruotolo trascorre tra l’una e l’altra senza confondersi ma additando a ogni pagina l’oggettività della sua creazione e cosa ha visto e vede intorno a sé. Certi temi di schiavitù e ferocia intasano la realtà umana, più di quanto lo specchio “mellifero” faccia scorgere all’infestante sanguigno. Ma se di contagio può parlarsi, infine risalta l’innocenza che nutre l’alveare fino a quando lo sfinimento non si dà un epilogo nella “sciamatura”. Evento mancante agli uomini, nonostante il lavorio sulle macchine che potrebbero farli emigrare dal Pianeta. Ma qui si tratta di poesia, di un principio d’esilio che porta da una dimora scossa alle radici a una Città Nuova: per le api e per i poeti – per un fine di tregua, per una lingua rinnovata.
Questo libro è un corpo domenicale, del tutto nuovo per quanto riesce a iniettare nelle nuove generazioni il bene di un mondo che sembra fossile ma è vivo, così come attestano le singole voci, corpi nel corpo unico dello Sciame, voci “spezzate” perché risuonano singolarmente, ma non abbattute come spesso accade per noi umani che vediamo l’inferno (nelle opere) là dove non dovremmo.