Di seguito l’introduzione a Domani urbani, antologia del futuribile metropolitano (e non) a cura di Alberto ‘Abo’ Di Monte e Giulio D’Errico. Il volume nasce come sforzo immaginativo e riflessione collettiva dal basso tra attivisti, futurologi e progettisti davanti a un futuro – di città, società, opzioni umane – che appare oggi sempre più malaticcio e restio a fornire alcuna nuova idea di se stesso. Ringraziamo Agenzia X per la pubblicazione.
Si può parlare del futuro come di quanto non è ancora accaduto o, su una scala relativa, come di quanto accadrà successivamente al presente continuo in cui siamo immersi come in un fluido viscoso. Nonostante l’imbroglio del titolo, questa collettanea non si occupa tanto di futuro quanto di futuribile: un set di opzioni, se non plausibili, a tutti gli effetti (almeno nel nostro presente-passato) ancora possibili e, perché no, desiderabili!
Quando guardiamo al “nostro” futuro, al futuro che ci appartiene, è bene dichiarare sin d’ora un sospetto di incombenza. Da qualche tempo infatti l’avvenire si è guastato e, persino alle più confortevoli latitudini sociali, non gode affatto di buona salute: il carattere rassicurante del domani, la promessa di emancipazione, la perfettibilità che deriva da esperienza, relazione e conoscenza, hanno perso molto del loro fascino.
La possibilità stessa di un’alterità spazio-temporale pare sbiadita, inesorabilmente soffocata da socialismi deludenti e truci, dall’ineluttabilità della mega-macchina capitalista, dall’ansia generalizzata di un pianeta in crisi da clima alterato e scarsa ossigenazione cerebrale, oltre che oceanica. In questa cornice di senso il soluzionismo solipsista e prestazionale, prima di quello tecnologico e geoingegneristico, non è che un epifenomeno della rinuncia a un piano di azione globale. In assenza di un progetto corale ciascuna e ciascuno è solo, condannato a tentativi di riscatto dal sentore di familismo amorale, microfama, o ancora evasione individualista dal fatto sociale.
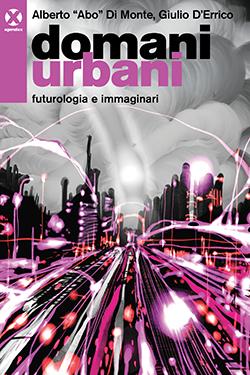
Occorre a questo punto una precisazione: invocare un piano d’area vasta non significa, perlomeno in queste righe, rincorrere uno schema omnicomprensivo e univoco di civiltà utopica. Non siamo in alcun modo alla ricerca del modello messianico cui demandare le risposte alle grandi questioni della convivenza umana nel rapporto con il pianeta che ospita la nostra specie (non senza segnali di ribellione) da uno o più centinaia di migliaia di anni. La domanda di ricerca da cui muove questa piccola (per umiltà e paginazione) antologia (per essenzialità e modalità di fruizione) di futurologia urbana, è perimetrata come suggerito dal titolo all’interno di uno spazio conosciuto e prossimo a quello del nostro quotidiano, benché proiettato… in là.
Nello sviluppo del testo non incontrerete tardigradi a cavalcioni dei raggi laser preconizzati dal Project Starlight per liberare dal propellente fossile l’esplorazione spaziale. Nemmeno ci addentriamo tra i suggestivi meandri dello sfruttamento energetico dell’acqua supercritica per mezzo di tunnel vetrificati a colpi di onde millimetriche. E se rinunciamo alla produzione di pensiero critico su queste e altre linee di fuga non è certo per spocchia, piuttosto per ignoranza. Tiriamo dunque la matassa a partire da altre e a noi più prossime domande di ricerca. Quando la performance si fa custodia di un’espiazione non condivisa, che senso ha coltivare interesse per un futuro a misura di comunità?
La nostra ipotesi di lavoro è che il momento sia propizio per riprendere la sfida immaginativa, e con essa la prassi, di un futuro incredibile e conviviale, incredibile perché conviviale. Un esercizio di stile dunque? Non solo. Ci hanno insegnato che non si può parlare di cosa avverrà dopo l’insurrezione anarchica, il comunismo di guerra o l’accensione dei fuochi di Gondor, perché sarà il processo (mai l’evento!) a determinare i modi di vita all’indomani dell’esito rivoluzionario. Parlare di cosa accade dopo una rivoluzione è tabù sin dai tempi remoti, una ritrosia che non può che confermarsi in una fase tellurica di scossette sociali, piuttosto che dalla magnitudo catastrofica. Alle nostre orecchie tutto ciò suona più casto che razionale, e più dettato dalla nota paura di distrarre energie da ciò che si ritiene impellente, che dall’urgenza di liberarne di nuove. L’attitudine all’esplorazione non è peraltro antitetica a un’adeguata preparazione al cosiddetto worst scenario. Non vi è alcuna tentazione solarpunk nell’illustrare un domani che, pur aperto all’improbabile, non può essere scevro dal conflitto, da interessi incompatibili, dall’incontro-scontro che germina dal libero arbitrio. Iscrivetevi dunque con noi all’accademia del disastro del rettore Virilio, senza mettere da parte la curiosità di sapere quali buone idee ci sono in circolo e liberi dall’immanenza del cataclisma che produce solo ansia, passività e frustrazione.
Altra intuizione che muove le pagine che verranno è quella di armare le lotte sociali e le scelte di ciascun* di capacità letteraria e letterale di ideare nuovi modi e nuovi mondi, la sua prassi esagerata (e talvolta contraddittoria) è quella di spingere oltre l’orizzonte dell’adeguato, del fattibile, del consono, l’offerta di visioni e scenari sottratti alla capacità di cattura dell’azienda-famiglia de Il cuore esploso. Abbiamo condiviso questo sforzo di anticipazione con una manciata di sognatrici e futurologi, dissipatori di traiettorie certe, funamboli della progettazione dal basso di comunità e degli strumenti per abitarle. Nessuno spazio per utopie razionali e predeterminate. Niente suggestioni bushcraft, trucchi per prepper bunkerizzati né stratagemmi survivalisti: abbiamo in bisaccia poco più di una dozzina di proposte disorganiche per la città di domani. Sì, perché è questo il perimetro di attenzione in cui muove la nostra ricerca: che forma può avere lo spazio urbano che viene? Un campo di azione sterminato, eppure inadeguato a riprogettare tante altre domande che sono insite nello sguardo intersezionale, ma che proprio questa tensione lega in una fila di vagoncini liberi da binari lucidi, paralleli e rassicuranti. L’ibridazione uomo-macchina che tanta importanza ha avuto nella letteratura science-fiction prima, e che sempre più permea di innesti il nostro quotidiano, non precipita esclusivamente nei vagheggiamenti di un metaverso più o meno orientato da perniciose piattaforme digitali. Lo stesso ambito urbano si fa cyborg, interfaccia e interprete di una condizione non solo postumana ma, nel corso di una nostra lettura, posturbana. Tuttavia se tecnologia, big data e cryptocurrency non costituiscono il nerbo del testo, è perché è la città “organismo plurale” (la città agita dunque dal protagonismo della comunità piuttosto che la città framework in cui agisce una governance più o meno “digital”) a offrire la rappresentazione più icastica del presente-futuro qui affrescato a più voci.
Ordine e legalità, giustizia e democrazia, diritti e doveri o piuttosto libertà nell’uguaglianza? Le società immaginarie che affollano la tua mente privata esprimono razionalità e abnegazione o creatività e propensione al cambiamento? La desiderabilità è, a nostro modo di vedere, il grimaldello della critica radicale e l’anticamera della messa in discussione di ogni modello di vita proposto e storicamente dato in porzioni crescenti del globo terracqueo. Non solo una proiezione, quanto un mosaico di narrative plurali, in grado di qualificare il margine di azione delle nostre scelte e del nostro sforzo immaginativo.
C’è un’arma più potente della minaccia termonucleare nell’arsenale dell’ordine neoliberale e delle relazioni internazionali: l’averci persuaso che l’emersione da questa normalità è del tutto improbabile. Il successo planetario del lemma resilienza ne è un indicatore cristallino: è tempo di abituarsi e adattarsi alla catastrofe ecologica, alla prossima guerra, alla crisi che incombe, ai sacrifici necessari, alle responsabilità dell’adultità, alla necessità di lavorare quaranta se non cinquanta ore a settimana, a ritagliare un tempo liminare per gli affetti e le passioni.
Che aspetto avrebbe una settimana in cui si lavora trentadue ore? O venti ore? Un giorno in più per sbloccare i condizionamenti, uno per gli affetti, l’esplorazione, l’ozio, le passioni. Lavorare tre, quattro giorni a settimana non è solo possibile, è un’opzione politica necessaria a disarticolare la reperibilità, liberare le proprietà inutilizzate, chiudere le città al trasporto inquinante, combattere la mefitica estetica del puccioso, del virtuoso e pure del tenebroso. Eppure persino a una scala ben modesta, quella metropolitana (che sovente ci appare regimare e agire l’intera sfera del possibile mentre non è che una macchia sulla tovaglia del pianeta) occorre ripensare radicalmente i modi di vita, e prima di questi aggiustare le focali a partire da una sana abitudine al plurale. Siamo abituati a pensare “Come ti vedi tra trent’anni?”. Mai a come “Ci vorresti vedere”? Anche questa flessione sulla forma singolare offre una rappresentazione icastica della difficoltà a disegnare un tempo fondato sul protagonismo di libertà e uguaglianza (e per questo necessariamente plurale) piuttosto che sulla messa al lavoro perpetua, e per questo dissennata.
Non c’è bisogno (o forse sì?) di sottolineare che i curatori del volume non necessariamente condividono le visioni che palpitano tra le righe di ciascun contributo, né che potreste smarrirvi nel perpetuo oscillare di registro e lessico, narrativa e saggistica, metropolizzazione e fuga tra gli astri. Indossate le vostre tute distillanti, dal canto mio vi auguro un viaggio confortevole tra futuri prossimi e mondi lontanissimi.



