Michael Herr Dispacci, tr. di Margherita Bignardi, Rizzoli BUR, pp. 285, euro 15,00 stampa, euro 7,99 epub
C’è qualcosa di speranzoso nell’espressione “opera prima”. Inevitabilmente si pensa che a quella faccia seguito un’opera seconda, e magari pure una terza, e così via; che quella pubblicazione sia l’inizio di una carriera. Difatti in questa rubrica abbiamo parlato per lo più di esordi di scrittori di un certo peso, che hanno pubblicato altro (spesso ben altro!), che hanno percorso molta strada dopo il loro esordio. Però c’è una diversa categoria di opere prime, se vogliamo più drammatica, anzi, decisamente tragica: l’opera prima che è anche opera unica. Penso a Emily Brontë, che prima di pubblicare Cime tempestose aveva dato alle stampe (sotto pseudonimo maschile, anche allora c’era il patriarcato) solo una manciata di poesie; nel 1847 fa uscire un capolavoro assoluto della letteratura mondiale – e l’anno dopo ci lascia senza completare il secondo romanzo, del quale si sono perse del tutto le tracce. Una cosa da mangiarsi le mani.
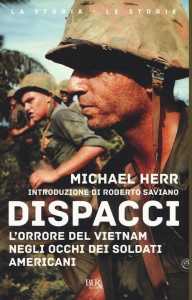 Poi c’è una terza categoria, un po’ meno tragica: lo scrittore che pubblica un libro che ha un successo strabiliante, per poi continuare senza ripetere mai più l’exploit iniziale, né in termini di vendite, né in termini di critica. A questa terza tipologia tristanzuola appartiene sicuramente Michael Herr e il suo libro d’esordio, Dispatches (Dispacci), pubblicato nel 1977. Herr, per fortuna sua, visse fino al 2016, quindi la sua sorte fu molto meno amara di quella di Emily; ma niente di quel che scrisse dopo la sua opera prima ebbe un successo paragonabile. Successo commerciale, si badi bene, ma anche impatto; prima però di approfondire questo aspetto del libro, è opportuno spiegare di cosa si tratta (o tentare di farlo).
Poi c’è una terza categoria, un po’ meno tragica: lo scrittore che pubblica un libro che ha un successo strabiliante, per poi continuare senza ripetere mai più l’exploit iniziale, né in termini di vendite, né in termini di critica. A questa terza tipologia tristanzuola appartiene sicuramente Michael Herr e il suo libro d’esordio, Dispatches (Dispacci), pubblicato nel 1977. Herr, per fortuna sua, visse fino al 2016, quindi la sua sorte fu molto meno amara di quella di Emily; ma niente di quel che scrisse dopo la sua opera prima ebbe un successo paragonabile. Successo commerciale, si badi bene, ma anche impatto; prima però di approfondire questo aspetto del libro, è opportuno spiegare di cosa si tratta (o tentare di farlo).
Se volessimo semplificare, potremmo dire che Dispacci è un reportage sul Vietnam. Herr era all’origine un critico cinematografico di poco successo (era stato licenziato dalla rivista “The New Leader” per cui aveva scritto nei primi anni Sessanta); aggiungiamo che gli studi iniziati alla Syracuse University li aveva mollati. Herr fino al 1967 è uno di quei tanti giovani senz’arte né parte che allora volevano vedere il mondo senza averne i mezzi, e per questo coglievano qualsiasi opportunità di viaggiare; nel suo caso questa indole nomade da hippie era associata alla venerazione per un altro scrittore e viaggiatore, Ernest Hemingway. E così, quando un amico di Herr che fa il redattore alla rivista “Esquire” gli propone di andare in Vietnam e di mandare dei pezzi sulla guerra che infuria da quelle parti, ma senza esser costretto spedire un articolo al giorno o a settimana (come dovevano fare altri inviati), Michael non ci pensa due volte. Hemingway era stato corrispondente di guerra prima di diventare narratore; e la sua carriera era iniziata proprio quando era stato mandato a seguire il conflitto tra greci e turchi che tra le altre cose ispirò alcuni dei suoi primissimi racconti (e pure qualche pagina di Addio alle armi). Come si faceva a dire di no?
Ma il Vietnam del 1976 non è il fronte italiano del 1917, né la Smirne del 1922; chiede un prezzo molto più salato. Herr resta nel paese asiatico per un anno e mezzo, vede molto (forse troppo), rischia la pelle non una volta sola, fa amicizia con diversi reporter americani e inglesi e di altri paesi, è presente alla presa di Hué, all’assedio di Khe Sanh, all’offensiva del Tet, scrive qualche pezzo per “Esquire”, raccoglie materiali con l’idea di ricavarne un libro, infine nel 1969 torna negli Stati Uniti con qualche cicatrice. Soprattutto, torna a casa ossessionato da quello che ha visto in Vietnam, al punto che per diciotto mesi lavora febbrilmente alla scrittura di quello che diventerà Dispacci; ma il peso delle esperienze traumatiche fatte e la notizia della sparizione di un caro amico (e modello) – il corrispondente e fotografo Sean Flynn – lo mettono mentalmente al tappeto. Herr ha un esaurimento nervoso che lo blocca completamente dal 1971 al 1975. Ovviamente è l’effetto di una sindrome che è stata compresa completamente proprio a partire dai disturbi mentali dei reduci del Vietnam, nota con la sigla PTSD, o Post-Traumatic Stress Disorder – e, coincidenza ironicamente tragica, si tratta dello stesso disturbo mentale che afflisse i reduci della Prima guerra mondiale, quella cui aveva preso parte brevissimamente Hemingway, solo che allora il PTSD veniva chiamato shell-shock (shock da granata).
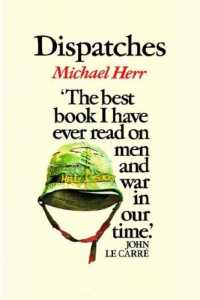
Proprio quando cade Saigon, abbandonata precipitosamente dagli americani e da tutti quei vietnamiti che avevano collaborato strettamente con loro, Herr si riprende; è il 1975. L’ex corrispondente di guerra rimette mano al manoscritto, che viene finalmente stampato due anni dopo; ed è il successo. L’edizione tascabile americana che ho letto riporta in copertina, in caratteri belli grossi, l’apprezzamento di John Le Carré (all’epoca era uno dei principali bestselleristi): “Il miglior libro che abbia mai letto su uomini e guerra nel nostro tempo”. E sulla quarta di copertina troviamo William S. Burroughs, Hunter S. Thompson e Tom Wolfe a cantarne le lodi.
Ebbene, come dicono gli americani, “Believe the hype!”, e cioè credete alla pubblicità. Il libro è potente e scritto con un’originalità stilistica invidiabile; il linguaggio di un giornalista musicale o cinematografico (e la musica gioca un ruolo importante nel testo) prestato alla cronaca di una guerra persa, di una guerra assurda, di una guerra atroce; un linguaggio irto di metafore e similitudini originali, come questa: «Una notte, come una scheggia che ci mette anni a fuoriuscire, sognai e vidi un campo affollato di morti». Il ricordo traumatico esce lentamente dall’inconscio (se lo volete chiamare così), come una scheggia che resta per anni nella carne finché pian piano non ne viene espulsa: il lento lavorio del trauma è illustrato con la causa stessa del trauma. Oppure «se il cannoneggiamento era particolarmente intenso, le facce sarebbero state distorte tutte dal tipo di panico più semplice, gli occhi spalancati più degli occhi di cavalli intrappolati in un incendio». E fulminee giustapposizioni: «La credenza puritana che Satana dimorava nella natura sarebbe potuta nascere qui [sugli altipiani del Vietnam], dove anche sulle cime montane più fredde e più fresche si poteva sentire odore di giungla e quella tensione tra marciume e genesi che emanano tutte le giungle». La scrittura di Herr è densa, lussureggiante come la foresta pluviale vietnamita; e l’architettura del libro è del tutto non-lineare. Non c’è una narrazione ordinata come in un altro libro fondamentale che esce nello stesso anno, La voce del Vietnam di Philip Caputo; c’è un saltare da un momento all’altro, da un posto all’altro. La prosa di Herr riproduce la vita di Herr in Indocina, alternando periodi passati in qualche albergo di Saigon a brevi incursioni in elicottero nei vari punti del fronte, dove passava ore, talvolta giorni, insieme ai marines o ai soldati della cavalleria americana, per poi spostarsi sempre in elicottero in qualche altro punto caldo, o tornando al sicuro.
Immagino che qualcuno leggendo le righe precedenti possa farsi tornare in mente una pellicola ben nota, risalente al 1979, considerata generalmente uno dei capolavori del cinema americano, e cioè Apocalypse Now di Francis Ford Coppola; ebbene, leggendo Herr si rientra in quel film, ci si sprofonda fino al collo, anche perché lo scrittore lavorò alla sceneggiatura assieme a John Milius e al regista. Leggendo Herr si trovano di tanto in tanto frasi che vennero poi messe in bocca ai personaggi di Coppola, e soprattutto si sente tutta la musica che risuona in quel film, soprattutto i Doors che Herr ascoltava ossessivamente a Saigon, senza i quali l’allucinatoria sequenza d’apertura perderebbe molta della sua intensità visionaria; e Jimi Hendrix, che in Apocalypse Now ha un piccolo cameo sonoro in una delle scene più caotiche e grottesche, l’eliminazione con un singolo colpo di lanciagranate di un Vietcong agonizzante le cui urla infastidiscono i soldati americani. E quella scena è presa di peso proprio da Dispacci.
Insomma, per quanto lo scheletro del film di Coppola sia, come si sa, adattato dal conradiano Cuore di tenebra, molta della muscolatura che lo muove viene dal libro di Herr. E se teniamo conto che lo scrittore prese anche parte alla stesura della sceneggiatura di un altro caposaldo del cinema sulla guerra del Vietnam, Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, possiamo misurare l’impatto del libro sull’immaginario collettivo, almeno nei paesi di lingua inglese (nonostante Apocalypse Now sia del 1979 e il film di Kubrick del 1987, per una traduzione italiana del libro di Herr bisognerà attendere il 1991: l’editoria italiana non si smentisce mai). Entrambi i registi vedevano l’autore di Dispacci come un testimone privilegiato e insostituibile della guerra del Vietnam, uno che era stato sul posto e aveva visto tutto; come impatto del suo libro, non mi pare affatto trascurabile.
Quest’opinione però non era condivisa da un altro scrittore che collaborò con Kubrick, e cioè Gustav Hasford, autore del romanzo autobiografico Nato per uccidere (1979), uscito solo due anni dopo il libro di Herr, altro bestseller “vietnamita”. Hasford era stato anche lui corrispondente di guerra, ma in qualità di membro del corpo dei marines, ed era stato anche decorato per il suo comportamento durante la sanguinosa battaglia di Hué; e nutriva per Herr una malcelata antipatia, quella classica del soldato che deve stare in zona di guerra nei confronti del giornalista che è libero di andarsene. Una situazione tra l’altro discussa dallo stesso Herr nel suo libro, che manifesta un’acuta consapevolezza della condizione liminale del corrispondente di guerra. Hasford, il marine, non riteneva Herr sufficientemente autorevole per dire com’era veramente andata in Vietnam, perché alla fine era solo e soltanto un giornalista.
Del resto, Dispacci non può essere letto come un puro e semplice reportage, e non solo per la scrittura tutt’altro che giornalistica, o per la sua mancanza di linearità. Lo stesso autore ha ammesso che alcune situazioni, alcuni personaggi, alcuni aneddoti, alcune battute messe in bocca a soldati e civili erano frutto della sua immaginazione, ma sostanziate di quel che aveva visto e sentito in zona di guerra. I due soldati Mayhew e Day Tripper, uno bianco l’altro nero (Herr è anche attento alla questione del colore: siamo pur sempre negli anni Sessanta di Martin Luther King e delle lotte per i diritti civili), coi quali il giornalista convive nei giorni trascorsi nell’inferno di Khe Sanh, due figure che letteralmente escono dalla pagina, non sono realmente esistiti, anche se probabilmente sono brillanti assemblaggi di atti, parole, atteggiamenti di veri marines. Insomma, Dispacci è uno strabiliante mix di fact e fiction, come direbbe lo stesso Herr, nel quale memoria e dimenticanza, fedeltà ai fatti bruti e invenzione letteraria entrano in un rapporto intimo e complesso, dal quale scaturisce il libro come ci è pervenuto.
Del resto un grande conoscitore delle narrazioni sulla guerra del Vietnam, Stefano Rosso, ha da tempo fatto notare quanto siano importanti per capire il libro le sue pagine iniziali, quella sorta di prologo nel quale Herr descrive la mappa del paese che era appesa su una parete del suo appartamento a Saigon, la mappa “che era una meraviglia, specialmente adesso che non era più reale”, perché è una vecchia cartina risalente ai tempi in cui il Vietnam era parte dell’impero coloniale francese, divisa nei territori del Tonchino, dell’Annam e della Cocincina. Toponimi desueti, su una mappa obsoleta e ingannevole; un autentico emblema di Dispacci, libro veritiero pur essendo non del tutto realistico.
E proprio l’approccio realistico, cioè rispettoso dei protocolli narrativi del realismo, viene messo in crisi da Herr col suo reportage-romanzo postmodernista; e quei protocolli abbandonerà un altro scrittore reduce, Tim O’Brien, col suo romanzo Inseguendo Cacciato, che esce non a caso l’anno dopo Dispacci. E certo non si potrà parlare di realismo per Apocalypse Now, o per Full Metal Jacket, i cui esterni vennero girati in Inghilterra. D’altronde, quelli della guerra del Vietnam sono gli anni del cosiddetto new journalism di Tom Wolfe, Truman Capote, Norman Mailer e altri, dove il reporter ci mette del suo, dove non ci si limita a rispondere alle tradizionali domande del bravo giornalista (chi? dove? quando? ecc.); sono gli anni del gonzo journalism di Hunter S. Thompson, forse lo scrittore più prossimo a Herr. Potremmo dire che si cercava la fedeltà allo spirito di un avvenimento, alla sua atmosfera, anche al costo di non esser tanto fedeli ai fatti, o di aggiungere quel che mancava.
Ed è alquanto interessante che il saggista e scrittore Vietnamericano Viet Thanh Nguyen, che ha sottoposto a uno spietato processo Apocalypse Now, accusando la pellicola di Coppola di non aver mai dato voce, neanche per un momento, ai vietnamiti (nonché di averli sostituiti con comparse tutte filippine), e che nel suo romanzo Il simpatizzante ci ha regalato tra le altre cose una ferocissima satira sulla realizzazione di quel film; Viet Thanh Nguyen, dicevo, che da anni denuncia come le narrazioni statunitensi del Vietnam siano sempre unilaterali, e facciano dei marines martiri quando furono assai spesso carnefici (ricordiamo: quasi 60.000 morti statunitensi a fronte di due milioni di vietnamiti massacrati), e comunque raccontino sempre dal punto di vista americano – ebbene, curiosamente Viet nel suo saggio Niente muore mai cita un paio di volte Herr, ma non lo mette sul banco degli imputati. E se si fa attenzione alla sua narrativa, ci si rende conto che questo scrittore nato in Vietnam da una famiglia di vietnamiti fuggiti dal loro paese e cresciuto negli Stati Uniti, è in effetti un discepolo dell’autore di Dispacci, pur con le sue differenze stilistiche, nel suo combinare ricostruzione storica e invenzione letteraria.
 Come si diceva prima, a Herr non arrise più un successo paragonabile alla sua opera prima. Successivamente scrisse The Big Room (1987), una raccolta di ritratti di celebrità hollywoodiane, frutto anche della sua frequentazione dell’ambiente del cinema in qualità di sceneggiatore; Mr Winchell (1990), biografia romanzata di Walter Winchell, uno dei più famosi giornalisti degli anni Trenta; Con Kubrick (2000), ritratto ravvicinato del grande regista col quale, come s’è detto, aveva collaborato per la sceneggiatura di Full Metal Jacket. Libri non privi di pregio, specie il secondo, ma che non ebbero l’impatto di Dispacci, battistrada di tutta la fiumana di narrazioni della sporca guerra del Vietnam a seguire. Per chi scrive, leggerlo oggi fa un effetto di macchina del tempo, mi fa tornare all’infanzia, quando ogni sera nel televisore in bianco e nero c’erano immagini da quel lontano paese asiatico bombardato e defoliato di cui parlavano tutti; a leggere ora Dispacci, quelle immagini si sono colorate di verde, il verde della giungla, delle divise, delle fusoliere degli elicotteri. In effetti, per la mia generazione è assolutamente vera la memorabile chiusa del libro, «Vietnam Vietnam Vietnam, siamo stati tutti lì». Ma Dispacci potrebbe avere qualcosa da dire anche alle generazioni successive, perché, come stiamo ben vedendo, può capitare a chiunque, in qualsiasi paese, di svegliarsi la mattina e di ritrovarsi in Vietnam – magari con meno elicotteri e più droni.
Come si diceva prima, a Herr non arrise più un successo paragonabile alla sua opera prima. Successivamente scrisse The Big Room (1987), una raccolta di ritratti di celebrità hollywoodiane, frutto anche della sua frequentazione dell’ambiente del cinema in qualità di sceneggiatore; Mr Winchell (1990), biografia romanzata di Walter Winchell, uno dei più famosi giornalisti degli anni Trenta; Con Kubrick (2000), ritratto ravvicinato del grande regista col quale, come s’è detto, aveva collaborato per la sceneggiatura di Full Metal Jacket. Libri non privi di pregio, specie il secondo, ma che non ebbero l’impatto di Dispacci, battistrada di tutta la fiumana di narrazioni della sporca guerra del Vietnam a seguire. Per chi scrive, leggerlo oggi fa un effetto di macchina del tempo, mi fa tornare all’infanzia, quando ogni sera nel televisore in bianco e nero c’erano immagini da quel lontano paese asiatico bombardato e defoliato di cui parlavano tutti; a leggere ora Dispacci, quelle immagini si sono colorate di verde, il verde della giungla, delle divise, delle fusoliere degli elicotteri. In effetti, per la mia generazione è assolutamente vera la memorabile chiusa del libro, «Vietnam Vietnam Vietnam, siamo stati tutti lì». Ma Dispacci potrebbe avere qualcosa da dire anche alle generazioni successive, perché, come stiamo ben vedendo, può capitare a chiunque, in qualsiasi paese, di svegliarsi la mattina e di ritrovarsi in Vietnam – magari con meno elicotteri e più droni.
Se poi la lettura di Dispacci vi farà venire voglia di approfondire l’argomento, mi sembra giusto raccomandare tre saggi assolutamente necessari sulla narrativa del Vietnam: Musi gialli e berretti verdi, di Stefano Rosso (Bergamo UP 2003), Niente muore mai, di Viet Thanh Nguyen (Neri Pozza 2018), e il recentissimo Riflessi di guerra, di Giacomo Traina (Ombrecorte 2024).



