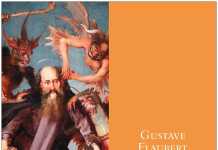Nel celebre saggio L’amore in occidente Denis de Rougemont individua nella tradizione letteraria adulterina le radici del mito amoroso occidentale che, opponendo il matrimonio alla passione, giustifica spiritualmente l’adulterio santificando l’Amore nella Morte.
Un mito di cui si alimenta non la sola produzione tragica, ma anche quella comica che si appropria unicamente di una parte del teorema declinandolo, fin dal principio, nei fabliaux e nelle novelle su su fino alla pochade: rivendicando un immaginario più cinico (e vitale), capace di far convivere, allegramente, gli appetiti degli amanti alle spalle del coniuge beffato. In questo senso La Signora Bovary di Gustave Flaubert è uno strano ircocervo, un romanzo tragico costruito sull’impianto di una farsa, con tutto quel che occorre: un marito stolido e cieco, un paio d’amanti spacconi (soprattutto Rodolphe) e un’eroina che, pur coltivando il ‘sublime’, non lesina sulle astuzie tipiche delle sue omologhe farsesche. Scrittore immenso, Flaubert consegna scientemente ai posteri un personaggio sempre al limite del parodico tanto che l’avvento di

Anna Karenina, con tutta la sua dolente ambivalenza, suona quasi una riparazione: un riposizionamento dell’adultera in un alveo indubitabilmente tragico. Tragedie borghesi, quelle di Flaubert e Tolstoj, in cui il mito di cui parla de Rougemont diviene passione unilaterale e dramma sociale. Benvenuti nel romanzo d’adulterio ottocentesco in cui a pagare il conto esistenziale e sociale del tradimento è solo la Signora. Con qualche eccezione, come vedremo.
Intanto. Intanto nel paese del Retto e Onesto Amore manzoniano, vent’anni dopo l’uscita di Madame Bovary e un anno prima della pubblicazione di Anna Karenina, nel 1876 per l’esattezza, Vittorio Imbriani dà alle stampe Dio ne scampi dagli Orsenigo, ovvero il contributo della nuova Italia alla causa del romanzo adulterino.
 Spaccato di straordinaria vitalità linguistica, il romanzo di Imbriani non raccoglie il plauso dei suoi contemporanei, né avrà miglior fortuna in seguito, essendo l’eclettico napoletano uno sperimentatore autarchico, un espressionista corrosivo: quello che oggi definiremmo outsider. Outsider sì, ma dotato di uno spirito eccezionalmente reazionario che professava con ardore e acrimonia così spropositati da sfumare nell’astrazione, almeno per quanto riguarda le opere di carattere narrativo; difficile, per esempio, individuare in Dio Ne scampi dagli Orsenigo un tratto ideologico chiaro tanto la voce guizza, si spezza, divaga nel magma della prosa; tanto si diletta, quella voce, delle proprie digressioni, dei giochi linguistici, del gusto della sperimentazione.
Spaccato di straordinaria vitalità linguistica, il romanzo di Imbriani non raccoglie il plauso dei suoi contemporanei, né avrà miglior fortuna in seguito, essendo l’eclettico napoletano uno sperimentatore autarchico, un espressionista corrosivo: quello che oggi definiremmo outsider. Outsider sì, ma dotato di uno spirito eccezionalmente reazionario che professava con ardore e acrimonia così spropositati da sfumare nell’astrazione, almeno per quanto riguarda le opere di carattere narrativo; difficile, per esempio, individuare in Dio Ne scampi dagli Orsenigo un tratto ideologico chiaro tanto la voce guizza, si spezza, divaga nel magma della prosa; tanto si diletta, quella voce, delle proprie digressioni, dei giochi linguistici, del gusto della sperimentazione.
Imbriani invita ad assaporare la lingua, spinge il lettore a ‘sentirle’ le parole, rigirandosele sul palato. Prendiamo il nome dell’eroina adultera del romanzo: la Radegonda Salmojraghi Orsenigo; ecco, già in questa sonorità (in quell’articolo davanti al nome) c’è, oltre alla malizia dell’erudito napoletano che si diverte a mimare una lingua lombarda, il gusto per le potenzialità iperboliche e quasi materiche che l’Italiano offre a chi le voglia cogliere. Non a caso, Contini riconobbe in Imbriani un precursore di Gadda. Riconoscimento tardivo e tutto sommato non ancora compiuto, restando questo grande lunatico un autore, parrebbe, per eccentrici.
Tornando al romanzo e ai suoi protagonisti: che dire di Donn’Almerinda Ruglia Scielzo, la melanconica napoletana costretta a prendersi un amante (perché così fan tutte), accettando i servigi di Maurizio della Morte, ufficiale devoto all’Almerinda non meno che alla mamma? Maurizio della Morte! Insomma, la scelta di nomi sembra già un’indicazione del modo di procedere di Imbriani, quasi decidesse di racchiudere lo svolgimento tragi-comico dei destini dei personaggi a partire dalla ghianda.
 Come il gagliardo ufficiale scivoli dal cuore dell‘Almerinda nelle mani della Radegonda spetta al lettore scoprirlo, sappia però, il lettore, che la faccenda ha ben poco di romantico: Imbriani manovra i personaggi come un puparo folle, padrone del canovaccio, ma ben felice di tradirlo. Così, il travaglio amoroso della coniugata Orsenigo Viganò, lungi dall’essere illustrato attraverso i languori che converrebbero al genere, viene vivacemente descritto come la scelta volontaristica di una pratica signora lombarda che capisce, all’improvviso, di voler sperimentare la passione. Viziata dalla nonna e poi dal marito, la nostra eroina non è donna abituata a rinunciare: il Della Morte ha da esser suo. E, galeotta una sera d’estate e un tasso alcolico fuor di misura, l’ufficiale si trova aggiogato al carro di un amore che non corrisponde ma che le ragioni dell’onore cavalleresco lo obbligano ad accettare. Tanto più che la Radegonda, spiccia quanto infatuata, non esita a lasciar per amor suo figlia e marito, rispettabilità e posizione, obbligando l’amante ad un ‘rapimento’ riparatore.
Come il gagliardo ufficiale scivoli dal cuore dell‘Almerinda nelle mani della Radegonda spetta al lettore scoprirlo, sappia però, il lettore, che la faccenda ha ben poco di romantico: Imbriani manovra i personaggi come un puparo folle, padrone del canovaccio, ma ben felice di tradirlo. Così, il travaglio amoroso della coniugata Orsenigo Viganò, lungi dall’essere illustrato attraverso i languori che converrebbero al genere, viene vivacemente descritto come la scelta volontaristica di una pratica signora lombarda che capisce, all’improvviso, di voler sperimentare la passione. Viziata dalla nonna e poi dal marito, la nostra eroina non è donna abituata a rinunciare: il Della Morte ha da esser suo. E, galeotta una sera d’estate e un tasso alcolico fuor di misura, l’ufficiale si trova aggiogato al carro di un amore che non corrisponde ma che le ragioni dell’onore cavalleresco lo obbligano ad accettare. Tanto più che la Radegonda, spiccia quanto infatuata, non esita a lasciar per amor suo figlia e marito, rispettabilità e posizione, obbligando l’amante ad un ‘rapimento’ riparatore.
In questa prima parte del romanzo la vena sulfurea (e in apparenza misogina) di Imbriani si dispiega in un modellamento irresistibile della prosa con cui chiosa gli eventi, divaga satirico, mima i vizi, ma soprattutto, i vezzi dei personaggi; vezzi che non esita a far discendere, almeno in buona parte, dalla diversa provenienza culturale dei protagonisti: una lombarda brutalmente pragmatica (anche in un campo in cui attesa e indugio sarebbero di rigore), e un napoletano scontrosamente arreso ai propri codici d’onore. Ed è in questo ribaltamento dei luoghi comuni del romanzo sentimentale, in questa versione dell’adultera carnefice e nell’amante vittima, che rintracciamo la palese intenzione parodica del romanzo.
Nella seconda parte, però, gli accenti parodici si smorzano, la pirotecnia sintattica e linguistica si acquieta. Qui, a fronteggiarsi, non ci sono una lombarda e un napoletano, ma un maschio e una femmina del 1876, in una torsione del rapporto vittima carnefice che diviene critica di costume singolarmente lucida, visti gli anni in cui è espressa.
 Entrambi fedeli alle maschere che si sono scelti (Passione e Onore) i protagonisti sono obbligati, in questa seconda parte, a reggere il peso delle conseguenze: l’attaccamento volontaristico della Radegonda alle leggi della Passione si traduce in un masochismo trepido, la fedeltà di Maurizio ai propri codici militaristico-cavallereschi si vena di rancido disprezzo verso la donna che l’ha costretto ad attivarli. In una paradossale forma di coerenza, l’uomo non esiterà a segregare e malmenare l’amante; d’altro lato, l’essere malmenata e aborrita non apparirà alla Orsenigo ragion sufficiente per abiurare la Passione cui si è votata.
Entrambi fedeli alle maschere che si sono scelti (Passione e Onore) i protagonisti sono obbligati, in questa seconda parte, a reggere il peso delle conseguenze: l’attaccamento volontaristico della Radegonda alle leggi della Passione si traduce in un masochismo trepido, la fedeltà di Maurizio ai propri codici militaristico-cavallereschi si vena di rancido disprezzo verso la donna che l’ha costretto ad attivarli. In una paradossale forma di coerenza, l’uomo non esiterà a segregare e malmenare l’amante; d’altro lato, l’essere malmenata e aborrita non apparirà alla Orsenigo ragion sufficiente per abiurare la Passione cui si è votata.
La misoginia si stempera: non è l’adultera che Imbriani mette alla berlina, ma l’astratta fede nella passione che la donna impugna come arma contro se stessa. La stessa astrazione che regola i pomposi codici d’onore del suo amante. Codici che, in prospettiva, si mostrano per quel che sono: vuote formule che ipostatizzano l’Onore a scapito del rispetto.
Sarà proprio questa visione narcisistica dell’onore a perdere il Della Morte, ma questo è il finale, e non è il caso di rivelarlo.
Ricapitolando: Dio ne scampi dagli Orsenigo nasce come una satira dal gusto misogino e finisce per trasformarsi (quasi) in un romanzo di critica sociale. Del resto, il lungo racconto La bella bionda è stato recentemente ripubblicato con un claim curioso: «il primo romanzo femminista italiano».
Non esageriamo. Certo è che la figura di Imbriani – multiforme, cangiante, capricciosa – sfugge alle facili catalogazioni; tanto più, allora, si stenta a comprendere perché un autore così magmatico sia stato ridotto, per decenni, a voce minore della Scapigliatura. Ammesso e non concesso che l’etichetta abbia una sua (vaga, ma vaga) appropriatezza, non sarebbe ora di sottrarre Don Vittorio al destino di ‘minore’ che l’accademismo scolastico gli ha incollato addosso? Minore di chi poi?
 Fido allievo di De Sanctis (che finì per detestare, prima per questioni private, poi per ragioni politiche), fautore dello stato assoluto di stampo hegeliano, e volontario nella Terza guerra d’indipendenza; eretico della Destra storica che non gli perdonava intransigenze e intemperanze; erudito straordinario, incline all’azione, all’insofferenza e facile al duello; appassionato conoscitore e raccoglitore della tradizione orale della fiaba; inesausto studioso di dialetti ma, soprattutto, avversario giurato di una posticcia lingua unitaria di sapore toscaneggiante e insipido; fautore di una prosa aperta ai dialetti, ai gallicismi, ai latinismi e ai neologismi; sabotatore della sintassi, Vittorio Imbriani è forse troppo ‘moderno’ per entrare nel pantheon delle sacre lettere. A tutt’oggi, infatti, benché, molti dei suoi scritti abbiano ripreso a circolare e gli studi critici si siano infittiti, il grande misantropo viene trattato dai più come un oggetto curioso scovato sugli scaffali di un robivecchi.
Fido allievo di De Sanctis (che finì per detestare, prima per questioni private, poi per ragioni politiche), fautore dello stato assoluto di stampo hegeliano, e volontario nella Terza guerra d’indipendenza; eretico della Destra storica che non gli perdonava intransigenze e intemperanze; erudito straordinario, incline all’azione, all’insofferenza e facile al duello; appassionato conoscitore e raccoglitore della tradizione orale della fiaba; inesausto studioso di dialetti ma, soprattutto, avversario giurato di una posticcia lingua unitaria di sapore toscaneggiante e insipido; fautore di una prosa aperta ai dialetti, ai gallicismi, ai latinismi e ai neologismi; sabotatore della sintassi, Vittorio Imbriani è forse troppo ‘moderno’ per entrare nel pantheon delle sacre lettere. A tutt’oggi, infatti, benché, molti dei suoi scritti abbiano ripreso a circolare e gli studi critici si siano infittiti, il grande misantropo viene trattato dai più come un oggetto curioso scovato sugli scaffali di un robivecchi.
Destino cinico e baro? Non tanto: una risposta plausibile la fornisce Celati in un suo notevole e consigliatissimo saggio “Imbriani, il favolare, l’ingenuità e lo scarabocchio“. Ecco cosa scrive Celati: «Imbriani è un transfuga dalla nostra pesante tradizione umanistica e dalla sua seriosità d’obbligo».
 Due righe folgoranti che sintetizzano la piaga della tradizione letteraria patria (pesantezza e seriosità) e interrogano la responsabilità dei suoi guardiani che, mutatis mutandis, in ambito accademico o editoriale, non cessano la tetra consuetudine al verbo prescrittivo, castigando (tuttora) i giochi dell’aggettivazione e le forme avverbiali, le formule esclamative o sospensive, il ricorso espressionistico al falsetto per dar corpo all’intenzione satirica. E, in generale (ancora: sempre) sospettano del ‘comico’ (così come del patetico), ammesso solo in certe forme direi canonizzate.
Due righe folgoranti che sintetizzano la piaga della tradizione letteraria patria (pesantezza e seriosità) e interrogano la responsabilità dei suoi guardiani che, mutatis mutandis, in ambito accademico o editoriale, non cessano la tetra consuetudine al verbo prescrittivo, castigando (tuttora) i giochi dell’aggettivazione e le forme avverbiali, le formule esclamative o sospensive, il ricorso espressionistico al falsetto per dar corpo all’intenzione satirica. E, in generale (ancora: sempre) sospettano del ‘comico’ (così come del patetico), ammesso solo in certe forme direi canonizzate.
Che farsene, dunque, di uno scrittore che arzigogola con l’aggettivo, provoca risate schiaccianti, fiocca esclamazioni e si permette di falsettare a volontà, drappeggiando le pieghe di una lingua palpitante, digressiva e musicalissima? Di un autore eclettico al limite della schizofrenia: di uno che, a differenza del gran Lombardo che era pur sempre un ingegnere, con la lingua gioca in maniera svagata e dissennata. Libera.
Imbriani resta quel che è stato in vita: un cattivo maestro. Per questo è vivamente consigliato ai giovani scrittori quale antidoto all’ufficialità della cosiddetta ‘prosa scarna’, implicitamente (insopportabilmente) solenne, proprio perché mira, senza pudore, al drammatico. La prosa seriosa di cui parla Celati e di cui troppi scrittori (e lettori) sono tutt’oggi vittime quasi ignare.
Dio li scampi dall’ira dell’Imbriani. E dalla sua risata.