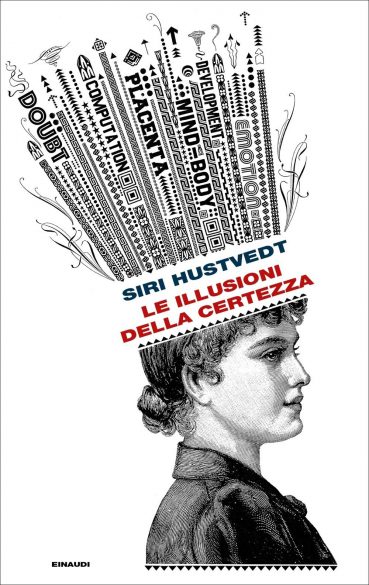«Il dubbio è una virtù per l’intelligenza»
Simone Weil
È vero che il patrimonio genetico determina il nostro destino? Come si passa dai neurone al pensiero? Qual è il rapporto tra la mente e il corpo? Come ci ricorda Siri Hustvedt in questo libro affascinante, solo una cosa è certa: che ci piaccia o no, a quanto pare la scienza non ha ancora trovato una risposta soddisfacente a questi interrogativi così basilari. L’autrice passa in rassegna alcune delle teorie scientifiche e filosofiche più autorevoli, e traccia una differenza significativa tra le ipotesi più popolari nel mondo scientifico e nella nostra società. Testi divulgativi che propugnano la natura computazionale della mente e quella del cosiddetto «gene egoista» (Hustvedt cita in particolare Come funziona la mente di Steven Pinker) hanno un forte seguito nei media; eppure si tratta di teorie che incontrano resistenze e confutazioni crescenti in vari ambiti nella comunità scientifica. Perché questa concezione meccanicista – eredità cartesiana e baconiana – che vede il pensiero come calcolo, e la mente come un computer razionale ha così tanto successo, se una parte consistente della comunità scientifica è contraria?
Anche se, fedele al titolo, Le illusioni della certezza sembra fornire più domande che risposte, in questo caso la spiegazione è abbastanza chiara: il pubblico tende ad accogliere le idee che preferisce sentirsi raccontare – quelle che confermano determinate credenze già presenti e diffuse a livello di senso comune, soprattutto se sono esposte in modo chiaro e facilmente comprensibile. Hustvedt ci mostra come i concetti introdotti da alcuni grandi pensatori che mettevano in dubbio la visione meccanicistica (Giambattista Vico e la brillante Margareth Cavendish, contemporanea di Cartesio e Bacone, su tutti) siano stati a lungo ignorati, o piegati alle credenze dell’epoca e parzialmente stravolti: citando Goethe, «se una falsa ipotesi […] diventa generalmente accettata e si trasforma in una convinzione che non è più messa in dubbio […], diventa il male a causa di cui si soffrirà per secoli». Qualcosa di simile è avvenuto in parte con le idee di Darwin, che era influenzato dal contesto romantico, fieramente anti-meccanicista; le sue «gemmule» portatrici delle caratteristiche ereditarie in origine erano unità «morbide», passibili di mutamento in seguito all’interazione con l’ambiente; nel pensiero dei suoi epigoni sono diventate unità più rigide, portando alla icastica (e quindi popolare) concezione del «gene egoista» sviluppata da Richard Dawkins e sposata da Pinker e altri scienziati che promuovono una corrispondenza rigida e necessaria tra patrimonio genetico e identità.
Hustvedt si avvale delle sue doti di professionista della scrittura per indagare ambiguità e preconcetti che emergono dai testi scientifici specialistici e divulgativi, presenta esperimenti neurologici e teorie filosofiche note e meno note con grande agilità e competenza, evidenziando come la preferenza per una visione rigida e immutabile del patrimonio genetico nasconda una concezione deterministica e soprattutto conservatrice; sotto le pretese di oggettività, queste teorie non appaiono solo culturalmente determinate, ma sono frutto di una visione del mondo ben precisa: «oserei dire che la nozione di fisso o cablato dev’essere molto più piacevole per chi è soddisfatto del proprio destino nel mondo» (ovvero il maschio bianco, suggerisce Hustvedt). Forse l’autrice esagera un po’ quando vede l’uomo presentato da Dawkins come «un inarrestabile robot maschio egoista, arrapato ed eterosessuale che non si fermerà davanti a nulla pur di diffondere il suo seme», ma se gli scienziati sono prevalentemente maschi e se la loro mentalità è frutto di una costruzione socio-culturale, è inevitabile che il loro pensiero ne risenta e la loro ricerca ne sia in qualche modo plasmata.
Al moderno meccanicismo Hustvedt oppone un approccio più costruttivista, ricordandoci come la consapevolezza dell’interazione mente-corpo e individuo-ambiente rivesta un’importanza crescente nella ricerca; in questo senso, la nostra natura di mammiferi – nati nel grembo materno prima che da esso, – e di animali sociali svolge un ruolo cruciale. È sempre più evidente che l’interazione tra madre (e/o figure parentali) e bambino nei primi anni di vita è fondamentale per lo sviluppo dell’individuo; anche qui niente di nuovo, si potrebbe dire – ma Hustvedt osserva che da importanti studi è emerso come una quantità impressionante di caratteristiche dell’individuo, non ultimo una fetta consistente della sua personalità, dipende proprio dallo stile di interazione tra madre e figlio. Non solo: certi traumi possono addirittura influenzare l’espressione del patrimonio genetico. Alcuni scienziati si sono spinti a ipotizzare che l’effetto placebo, uno dei fenomeni più misteriosi che riguarda la nostra mente, possa essere riconducibile a queste interazioni primarie: la mente innesca il meccanismo di guarigione perché associa la situazione (es. medico gentile che ci offre promettenti pillole rosa) ai ricordi inconsci di una situazione di benessere originaria derivata da un’interazione simile avvenuta con la figura materna. E che dire dei numerosi casi di cecità e di gravidanze isteriche? Anche in questi casi, pensieri, paure e desideri creano alterazioni importanti nelle funzioni corporee. La verità è che «non sappiamo come i fattori psicologici si relazionino a quelli neurobiologici. L’anello mancante è di enormi proporzioni». È evidente che la teoria computazionale della mente ne esce fortemente ridimensionata.
A questo proposito, Hustvedt propone un’interessante disamina degli esperimenti legati alla creazione di un’intelligenza artificiale, che finora si sono scontrati con una serie di fallimenti inequivocabili; nonostante l’ottimismo di molti scienziati, sempre pronti a giurare che la creazione di una macchina pensante pressoché indistinguibile dall’uomo sia dietro l’angolo. In realtà Hustvedt dimostra come questo traguardo sia di fatto lontanissimo. I robot sembrano ben lontani dal produrre forme di pensiero autonomo, e men che meno provare emozioni – che forse hanno un ruolo più importante del previsto nella produzione e articolazione del pensiero. D’altro canto, l’importanza dei tropi e in particolare delle metafore (già individuata da Vico, che le radicava nelle nostre esperienza corporee) nell’articolazione del pensiero è sempre più chiara. Hustvedt cita anche filosofi e studiosi come Maturana e Varela e Simone Weil, secondo la quale la realtà non esiste a prescindere, ma è plasmata dalle nostre percezioni. Se davvero la nostra mente funzionasse come un computer, se il nostro pensiero fosse assimilabile a mero calcolo razionale, dovrebbe essere possibile produrre macchine intelligenti. A quanto pare non è così – il che semina ulteriori dubbi sull’attendibilità del modello computazionale della mente, giudicato un’eccessiva semplificazione.
Nella ricerca di una nuova razza immortale e asciutta, senza inizio e fine, nascita e morte (recentemente esemplificata anche da Don DeLillo nel romanzo Zero K), Hustvedt legge un rifiuto, se non una paura, del corpo mortale che corrisponde al rifiuto/paura della donna nella tradizione culturale occidentale, e stabilisce un’equivalenza tra mente razionale e uomo da un lato, e corpo impuro e donna dall’altro. Viene da chiedersi però come giustifica l’autrice la tradizione trobadorica e stilnovista nella cultura occidentale: forse un tentativo dell’uomo di riscattare (o negare?) il principio femminile astraendolo dal corpo impuro e caduco e attribuendogli una valenza salvifica (vedi Dante con Beatrice?). La questione è affascinante e certamente complessa.
In alcune delle pagine più suggestive del libro, H. indaga ulteriormente il significato del binomio puro/impuro e ripropone le tesi dell’antropologa Mary Douglas in Purezza e Pericolo, che collega il concetto all’idea di confine: «l’inquinamento si manifesta quando i confini di una qualsiasi struttura, forma o corpo sono minacciati in quei luoghi minacciosi e indefiniti». Viene da pensare: quella del superamento dei confini – geografici e non solo – non è forse la grande paura del nostro tempo? È chiaro che se un essere umano potesse essere «disincarnato, tradotto e riprodotto sotto forma di informazione» queste preoccupazioni verrebbero placate. Questo distillato asciutto di umanità non coincide forse con un’idea di anima? «Un’anima per una nuova era», finalmente priva dal timore di contaminazione che ha plasmato il cristianesimo paolino ed è arrivata fino a noi passando per Cartesio. Chissà cosa ne penserebbero grandi scrittori di fantascienza come Philip K. Dick, che hanno contribuito a forgiare il nostro immaginario anche per quanto riguarda il rapporto tra corpo, mente e anima. Da questo punto di vista Hustvedt è forse un po’ evasiva, limitandosi a citare gli esempi cinematografici più famosi (L’invasione degli ultracorpi e 2001 Odissea nello spazio), ma che dire per esempio di film come Matrix e serie tv come Black Mirror e Westworld, al contempo specchio e laboratorio culturale di queste idee? Pur non prendendo in considerazione queste serie tv il saggio di Hustvedt (uscito nel 2016, lo stesso anno della messa in onda della prima stagione di Westworld) ha l’importante merito di fare il punto su alcuni snodi fondamentali della cultura del nostro tempo, adottando un approccio interdisciplinare ma allo stesso tempo rigoroso e aperto a stimoli diversi. «Le mie stesse opinioni sono soggette a una revisione continua» ammette. Ma «la disponibilità al ripensamento non significa incapacità di discriminazione […]. Significa considerare con attenzione le prove che contraddicono quello che davi per scontato. Significa rimescolare di continuo le acque. […] Senza il dubbio non potrebbe nascere nessuna idea, nessuna opera d’arte e, anche se può spiazzare, è nondimeno molto entusiasmante».